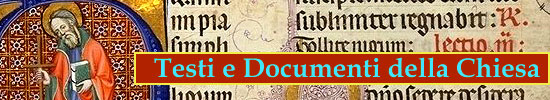HOME benvenuti | liturgia | bibbia | voci dal deserto | immagini & webcam | chiese locali | testi & documenti | pensieri
san francesco & santa chiara | massime eterne | papas pefkis | l'arcivescovo lambruschini | banner exch | links
|
GIOVANNI
PAOLO II - Esortazione Apostolica: |
|
|
Introduzione |
|
|
IO
SONO LA VITE, VOI I TRALCI |
|
|
TUTTI
TRALCI DELL'UNICA VITE |
|
|
VI
HO COSTITUITI PERCHE' ANDIATE E PORTIATE FRUTTO |
|
|
GLI
OPERAI DELLA VIGNA DEL SIGNORE |
|
|
PERCHE'
PORTIATE PIU' FRUTTO |
|
|
ESORTAZIONE
APOSTOLICA Ai
Vescovi |
|
|
INTRODUZIONE 1. I FEDELI LAICI (Christifideles laici), la cui «
vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo a vent'anni dal Concilio
Vaticano II » è stato l'argomento del Sinodo dei Vescovi del 1987,
appartengono a quel Popolo di Dio che è raffigurato dagli operai della
vigna, dei quali parla il Vangelo di Matteo: « Il regno dei cieli è
simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata
lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno,
li mandò nella sua vigna » (Mt 20, 1-2). La parabola evangelica spalanca davanti al nostro sguardo
l'immensa vigna del Signore e la moltitudine di persone, uomini e donne,
che da Lui sono chiamate e mandate perché in essa abbiano a lavorare. La
vigna è il mondo intero (cf. Mt 13, 38), che dev'essere
trasformato secondo il disegno di Dio in vista dell'avvento definitivo del
Regno di Dio. Andate anche voi nella mia vigna 2. « Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che
stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: "andate anche voi
nella mia vigna" » (Mt 20, 3-4). L'appello del Signore Gesù «Andate anche voi nella mia vigna
» non cessa di risuonare da quel lontano giorno nel corso della
storia: è rivolto a ogni uomo che viene in questo mondo. Ai nostri tempi, nella rinnovata effusione dello Spirito
pentecostale avvenuta con il Concilio Vaticano II, la Chiesa ha maturato
una più viva coscienza della sua natura missionaria e ha riascoltato la
voce del suo Signore che la manda nel mondo come « sacramento universale
di salvezza »(1). Andate anche voi. La chiamata non
riguarda soltanto i Pastori, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, ma
si estende a tutti: anche i fedeli laici sono personalmente chiamati dal
Signore, dal quale ricevono una missione per la Chiesa e per il mondo. Lo
ricorda S. Gregorio Magno che, predicando al popolo, così commenta la
parabola degli operai della vigna: « Guardate al vostro modo di vivere,
fratelli carissimi, e verificate se siete già operai del Signore.
Ciascuno valuti quello che fa e consideri se lavora nella vigna del
Signore »(2). In particolare il Concilio, con il suo ricchissimo patrimonio
dottrinale, spirituale e pastorale, ha riservato pagine quanto mai
splendide sulla natura, dignità, spiritualità, missione e responsabilità
dei fedeli laici. E i Padri conciliari, riecheggiando l'appello di
Cristo, hanno chiamato tutti i fedeli laici, uomini e donne, a lavorare
nella sua vigna: «Il sacro Concilio scongiura nel Signore tutti i
laici a rispondere volentieri, con animo generoso e con cuore pronto, alla
voce di Cristo, che in quest'ora li invita con maggiore insistenza, e
all'impulso dello Spirito Santo. In modo speciale i più giovani sentano
questo appello come rivolto a se stessi, e l'accolgano con slancio e
magnanimità. Il Signore stesso infatti ancora una volta per mezzo di
questo Santo Sinodo invita tutti i laici ad unirsi sempre più intimamente
a Lui e, sentendo come proprio tutto ciò che è di Lui (cf. Fil 2,
5), si associno alla sua missione salvifica; li manda ancora in ogni città
e in ogni luogo dov'egli sta per venire (cf. Lc 10, 1)»(3). Andate anche voi nella mia vigna. Queste
parole sono spiritualmente risuonate, ancora una volta, durante la
celebrazione del Sinodo dei Vescovi, tenutosi a Roma dal 1° al 30
ottobre 1987. Ponendosi sui sentieri del Concilio e aprendosi alla luce
delle esperienze personali e comunitarie di tutta la Chiesa, i Padri,
arricchiti dai Sinodi precedenti, hanno affrontato in modo specifico e
ampio l'argomento riguardante la vocazione e la missione dei laici nella
Chiesa e nel mondo. In questa Assemblea episcopale non è mancata una qualificata
rappresentanza di fedeli laici, uomini e donne, che hanno portato un
contributo prezioso ai lavori del Sinodo, come è stato pubblicamente
riconosciuto nell'omelia di conclusione: «Ringraziamo per il fatto che
nel corso del Sinodo abbiamo potuto non solo gioire per la partecipazione
dei laici (auditores e auditrices), ma ancor di più perché
lo svolgimento delle discussioni sinodali ci ha permesso di ascoltare la
voce degli invitati, i rappresentanti del laicato provenienti da tutte le
parti del mondo, dai diversi Paesi, e ci ha consentito di profittare delle
loro esperienze, dei loro consigli, dei suggerimenti che scaturiscono dal
loro amore per la causa comune»(4). Con lo sguardo rivolto al dopo-Concilio i Padri sinodali hanno
potuto costatare come lo Spirito abbia continuato a ringiovanire la
Chiesa, suscitando nuove energie di santità e di partecipazione in tanti
fedeli laici. Ciò è testimoniato, tra l'altro, dal nuovo stile di
collaborazione tra sacerdoti, religiosi e fedeli laici; dalla
partecipazione attiva nella liturgia, nell'annuncio della Parola di Dio e
nella catechesi; dai molteplici servizi e compiti affidati ai fedeli laici
e da essi assunti; dal rigoglioso fiorire di gruppi, associazioni e
movimenti di spiritualità e di impegno laicali; dalla partecipazione più
ampia e significativa delle donne nella vita della Chiesa e nello sviluppo
della società. Nello stesso tempo, il Sinodo ha rilevato come il cammino
postconciliare dei fedeli laici non sia stato esente da difficoltà e da
pericoli. In particolare si possono ricordare due tentazioni alle quali
non sempre essi hanno saputo sottrarsi: la tentazione di riservare un
interesse così forte ai servizi e ai compiti ecclesiali, da giungere
spesso a un pratico disimpegno nelle loro specifiche responsabilità nel
mondo professionale, sociale, economico, culturale e politico; e la
tentazione di legittimare l'indebita separazione tra la fede e la vita,
tra l'accoglienza del Vangelo e l'azione concreta nelle più diverse realtà
temporali e terrene. Nel corso dei suoi lavori il Sinodo ha fatto costante riferimento
al Concilio Vaticano II, il cui insegnamento sul laicato, a distanza di
vent'anni, è apparso di sorprendente attualità e talvolta di portata
profetica: tale insegnamento è capace di illuminare e di guidare le
risposte che oggi devono essere date ai nuovi problemi. In realtà, la
sfida che i Padri sinodali hanno accolto è stata quella di individuare le
strade concrete perché la splendida «teoria» sul laicato espressa dal
Concilio possa diventare un'autentica «prassi» ecclesiale. Alcuni
problemi poi s'impongono per una certa loro «novità», tanto da poterli
chiamare postconciliari, almeno in senso cronologico: ad essi i Padri
sinodali hanno giustamente riservato una particolare attenzione nel corso
della loro discussione e riflessione. Tra questi problemi sono da
ricordare quelli riguardanti i ministeri e i servizi ecclesiali affidati o
da affidarsi ai fedeli laici, la diffusione e la crescita di nuovi «movimenti»
accanto ad altre forme aggregative di laici, il posto e il ruolo della
donna sia nella Chiesa che nella società. I Padri sinodali, al termine dei loro lavori, svolti con grande
impegno, competenza e generosità, mi hanno manifestato il desiderio e mi
hanno rivolto la preghiera perché, a tempo opportuno, offrissi alla
Chiesa universale un documento conclusivo sui fedeli laici(5). Questa Esortazione Apostolica post-sinodale intende valorizzare
tutta quanta la ricchezza dei lavori sinodali, dai Lineamenta all'Instrumentum
laboris, dalla relazione introduttiva agli interventi dei singoli
vescovi e laici e alla relazione di sintesi dopo la discussione in aula,
dalle discussioni e relazioni dei «circoli minori» alle «proposizioni»
e al Messaggio finale. Per questo il presente documento non si pone
a lato del Sinodo, ma ne costituisce la fedele e coerente espressione, è
il frutto d'un lavoro collegiale, al cui esito finale hanno apportato il
loro contributo il Consiglio della Segreteria Generale del Sinodo e la
stessa Segreteria. Suscitare e alimentare una più decisa presa di coscienza del dono
e della responsabilità che tutti i fedeli laici, e ciascuno di essi in
particolare, hanno nella comunione e nella missione della Chiesa è lo
scopo che l'Esortazione intende perseguire. Le urgenze attuali del mondo: perché ve ne state qui tutto
il giorno oziosi? 3. Il significato fondamentale di questo Sinodo, e quindi il
frutto più prezioso da esso desiderato, è l'ascolto da parte dei
fedeli laici dell'appello di Cristo a lavorare nella sua vigna, a
prendere parte viva, consapevole e responsabile alla missione della Chiesa
in quest'ora magnifica e drammatica della storia, nell'imminenza
del terzo millennio. Situazioni nuove, sia ecclesiali sia sociali, economiche,
politiche e culturali, reclamano oggi, con una forza del tutto
particolare, l'azione dei fedeli laici. Se il disimpegno è sempre stato
inaccettabile, il tempo presente lo rende ancora più colpevole. Non è
lecito a nessuno rimanere in ozio. Riprendiamo la lettura della parabola evangelica: «Uscito ancora
verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro:
"Perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi?". Gli
risposero: "Perché nessuno ci ha presi a giornata". Ed egli
disse loro: "Andate anche voi nella mia vigna"» (Mt 20,
6-7). Non c'è posto per l'ozio, tanto è il lavoro che attende tutti
nella vigna del Signore. Il «padrone di casa» ripete con più forza il
suo invito: «Andate anche voi nella mia vigna». La voce del Signore risuona certamente nell'intimo dell'essere
stesso d'ogni cristiano, che mediante la fede e i sacramenti
dell'iniziazione cristiana è configurato a Gesù Cristo, è inserito come
membro vivo nella Chiesa ed è soggetto attivo della sua missione di
salvezza. La voce del Signore passa però anche attraverso le vicende
storiche della Chiesa e dell'umanità, come ci ricorda il Concilio: «Il
Popolo di Dio, mosso dalla fede, per cui crede di essere condotto dallo
Spirito del Signore, che riempie l'universo, cerca di discernere negli
avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme
con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della
presenza e del disegno di Dio. La fede infatti tutto rischiara di una luce
nuova e svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale dell'uomo, e
perciò guida l'intelligenza verso soluzioni pienamente umane»(6). E' necessario, allora, guardare in faccia questo nostro mondo, con
i suoi valori e problemi, le sue inquietudini e speranze, le sue conquiste
e sconfitte: un mondo le cui situazioni economiche, sociali, politiche e
culturali presentano problemi e difficoltà più gravi rispetto a quello
descritto dal Concilio nella Costituzione pastorale Gaudium et spes(7).
E' comunque questa la vigna, è questo il campo nel quale i
fedeli laici sono chiamati a vivere la loro missione. Gesù li vuole, come
tutti i suoi discepoli, sale della terra e luce del mondo (cf. Mt 5,
13-14). Ma qual è il volto attuale della «terra» e del «mondo»,
di cui i cristiani devono essere «sale» e «luce»? E' assai grande la diversità delle situazioni e delle
problematiche che oggi esistono nel mondo, peraltro caratterizzate da una
crescente accelerazione di mutamento. Per questo è del tutto necessario
guardarsi dalle generalizzazioni e dalle semplificazioni indebite. E' però
possibile rilevare alcune linee di tendenza che emergono nella società
attuale. Come nel campo evangelico insieme crescono la zizzania e il
buon grano, così nella storia, teatro quotidiano di un esercizio spesso
contraddittorio della libertà umana, si trovano, accostati e talvolta
profondamente aggrovigliati tra loro, il male e il bene, l'ingiustizia e
la giustizia, l'angoscia e la speranza. Secolarismo e bisogno religioso 4. Come non pensare alla persistente diffusione dell'indifferentismo
religioso e dell'ateismo nelle sue più diverse forme, in
particolare nella forma, oggi forse più diffusa, del secolarismo? Inebriato
dalle prodigiose conquiste di un inarrestabile sviluppo
scientifico-tecnico e soprattutto affascinato dalla più antica e sempre
nuova tentazione, quella di voler diventare come Dio (cf. Gen 3, 5)
mediante l'uso d'una libertà senza limiti, l'uomo taglia le radici
religiose che sono nel suo cuore: dimentica Dio, lo ritiene senza
significato per la propria esistenza, lo rifiuta ponendosi in adorazione
dei più diversi «idoli». E' veramente grave il fenomeno attuale del secolarismo: non
riguarda solo i singoli, ma in qualche modo intere comunità, come già
rilevava il Concilio: «Moltitudini crescenti praticamente si staccano
dalla religione»(8). Più volte io stesso ho ricordato il fenomeno della
scristianizzazione che colpisce i popoli cristiani di vecchia data e che
reclama, senza alcuna dilazione, una nuova evangelizzazione. Eppure l'aspirazione e il bisogno religiosi non possono
essere totalmente estinti. La coscienza di ogni uomo, quando ha il
coraggio di affrontare gli interrogativi più gravi dell'esistenza umana,
in particolare l'interrogativo sul senso del vivere, del soffrire e del
morire, non può non fare propria la parola di verità gridata da
Sant'Agostino: «Tu ci hai fatto per te, o Signore, e il nostro cuore è
inquieto sino a quando non riposa in Te»(9). Così anche il mondo attuale
testimonia, in forme sempre più ampie e vive, l'apertura ad una visione
spirituale e trascendente della vita, il risveglio della ricerca
religiosa, il ritorno al senso del sacro e alla preghiera, la richiesta di
essere liberi nell'invocare il Nome del Signore. La persona umana: dignità calpestata ed esaltata 5. Pensiamo, inoltre, alle molteplici violazioni alle quali
viene oggi sottoposta la persona umana. Quando non è riconosciuto
e amato nella sua dignità di immagine vivente di Dio (cf. Gen 1,
26), l'essere umano è esposto alle più umilianti e aberranti forme di «strumentalizzazione»,
che lo rendono miseramente schiavo del più forte. E «il più forte» può
assumere i nomi più diversi: ideologia, potere economico, sistemi
politici disumani, tecnocrazia scientifica, invadenza dei mass-media. Di
nuovo ci troviamo di fronte a moltitudini di persone, nostri fratelli e
sorelle, i cui diritti fondamentali sono violati, anche in seguito
all'eccessiva tolleranza e persino alla palese ingiustizia di certe leggi
civili: il diritto alla vita e all'integrità, il diritto alla casa e al
lavoro, il diritto alla famiglia e alla procreazione responsabile, il
diritto alla partecipazione alla vita pubblica e politica, il diritto alla
libertà di coscienza e di professione di fede religiosa. Chi può contare i bambini non nati perché uccisi nel seno delle
loro madri, i bambini abbandonati e maltrattati dagli stessi genitori, i
bambini che crescono senza affetto ed educazione? In alcuni Paesi intere
popolazioni sono sprovviste di casa e di lavoro, mancano dei mezzi
assolutamente indispensabili per condurre una vita degna di esseri umani e
sono private persino del necessario per la stessa sussistenza. Tremende
sacche di povertà e di miseria, fisica e morale ad un tempo, stanno
oramai di casa ai margini delle grandi metropoli e colpiscono mortalmente
interi gruppi umani. Ma la sacralità della persona non può essere annullata,
quantunque essa troppo spesso venga disprezzata e violata: avendo il suo
incrollabile fondamento in Dio Creatore e Padre, la sacralità della
persona torna ad imporsi, sempre e di nuovo. Di qui il diffondersi sempre più vasto e l'affermarsi sempre più
forte del senso della dignità personale di ogni essere umano. Una
corrente benefica oramai percorre e pervade tutti i popoli della terra,
resi sempre più consapevoli della dignità dell'uomo: non è affatto una
«cosa» o un «oggetto» di cui servirsi, ma è sempre e solo un «soggetto»,
dotato di coscienza e di libertà, chiamato a vivere responsabilmente
nella società e nella storia, ordinato ai valori spirituali e religiosi. E stato detto che il nostro è il tempo degli «umanesimi»:
alcuni, per la loro matrice atea e secolaristica, finiscono
paradossalmente per mortificare e annullare l'uomo; altri umanesimi invece
lo esaltano a tal punto da giungere a forme di vera e propria idolatria;
altri, infine, riconoscono secondo verità la grandezza e la miseria
dell'uomo, manifestando, sostenendo e favorendo la sua dignità totale. Segno e frutto di queste correnti umanistiche è il crescente
bisogno della partecipazione. E' questa, indubbiamente, uno dei
tratti distintivi dell'umanità attuale, un vero «segno dei tempi» che
viene maturando in diversi campi e in diverse direzioni: nel campo
soprattutto delle donne e del mondo giovanile, e nella direzione della
vita non solo familiare e scolastica, ma anche culturale, economica,
sociale e politica. L'essere protagonisti, in qualche modo creatori di una
nuova cultura umanistica, è un'esigenza insieme universale e
individuale(10). Conflittualità e pace 6. Non possiamo infine, non ricordare un altro fenomeno che
contraddistingue l'attuale umanità: forse come non mai nella sua storia,
l'umanità è quotidianamente e profondamente colpita e scardinata dalla conflittualità.
E' questo un fenomeno pluriforme, che si distingue dal pluralismo
legittimo delle mentalità e delle iniziative, e si manifesta
nell'infausto contrapporsi di persone, gruppi, categorie, nazioni e
blocchi di nazioni. E' una contrapposizione che assume forme di violenza,
di terrorismo, di guerra. Ancora una volta, ma con proporzioni enormemente
ampliate, diversi settori dell'umanità d'oggi, volendo dimostrare la loro
«onnipotenza», rinnovano la stolta esperienza della costruzione della «torre
di Babele» (cf. Gen 11, 1-9), la quale però prolifera confusione,
lotta, disgregazione ed oppressione. La famiglia umana è così in se
stessa drammaticamente sconvolta e lacerata. D'altra parte, del tutto insopprimibile è l'aspirazione dei
singoli e dei popoli al bene inestimabile della pace nella
giustizia. La beatitudine evangelica: «Beati gli operatori di pace» (Mt
5, 9) trova negli uomini del nostro tempo una nuova e significativa
risonanza: per l'avvento della pace e della giustizia popolazioni intere
oggi vivono, soffrono e lavorano. La partecipazione di tante
persone e gruppi alla vita della società è la strada oggi sempre più
percorsa perché da desiderio la pace diventi realtà. Su questa strada
incontriamo tanti fedeli laici generosamente impegnati nel campo sociale e
politico, nelle più varie forme sia istituzionali che di volontariato e
di servizio agli ultimi. Gesù Cristo, la speranza dell'umanità 7. Questo è l'immenso e travagliato campo che sta davanti agli
operai mandati dal «padrone di casa» a lavorare nella sua vigna. In questo campo è presente e operante la Chiesa, noi tutti,
pastori e fedeli, sacerdoti, religiosi e laici. Le situazioni ora
ricordate toccano profondamente la Chiesa: da esse è in parte
condizionata, non però schiacciata né tanto meno sopraffatta, perché lo
Spirito Santo, che ne è l'anima, la sostiene nella sua missione. La Chiesa sa che tutti gli sforzi che l'umanità va compiendo per
la comunione e la partecipazione, nonostante ogni difficoltà, ritardo e
contraddizione causati dai limiti umani, dal peccato e dal Maligno,
trovano piena risposta nell'intervento di Gesù Cristo, Redentore
dell'uomo e del mondo. La Chiesa sa di essere mandata da Lui come «segno e strumento
dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano»(11). Nonostante tutto, dunque, l'umanità può sperare, deve sperare:
il Vangelo vivente e personale, Gesù Cristo stesso, è la «notizia»
nuova e apportatrice di gioia che la Chiesa ogni giorno annuncia e
testimonia a tutti gli uomini. In questo annuncio e in questa testimonianza i fedeli laici hanno
un posto originale e insostituibile: per mezzo loro la Chiesa di Cristo è
resa presente nei più svariati settori del mondo, come segno e fonte di
speranza e di amore. |
|
|
CAPITOLO I IO SONO LA VITE, VOI I
TRALCI Il mistero della vigna 8. L'immagine della vigna viene usata dalla Bibbia in molti modi e
con diversi significati: in particolare, essa serve ad esprimere il
mistero del Popolo di Dio. In questa prospettiva più interiore i
fedeli laici non sono semplicemente gli operai che lavorano nella vigna,
ma sono parte della vigna stessa: «Io sono la vite, voi i tralci» (Gv
15, 5),dice Gesù. Già nell'Antico Testamento i profeti per indicare il popolo
eletto ricorrono all'immagine della vigna. Israele è la vigna di Dio,
l'opera del Signore, la gioia del suo cuore: «Io ti avevo piantato come
vigna scelta» (Ger 2, 21); «Tua madre era come una vite piantata
vicino alle acque. Era rigogliosa e frondosa per l'abbondanza dell'acqua»
(Ez 19, 10); «Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile
colle. Egli l'aveva vangata e sgombrata dai sassi, e vi aveva piantato
scelte viti (...)» (Is 5, 1-2). Gesù riprende il simbolo della vigna e se ne serve per rivelare
alcuni aspetti del Regno di Dio: «Un uomo piantò una vigna, vi pose
attorno una siepe, scavò un torchio, costruì una torre, poi la diede in
affitto a dei vignaioli e se ne andò lontano» (Mc 12, 1; cf. Mt
21, 28 ss.). L'evangelista Giovanni ci invita a scendere in profondità e ci
introduce a scoprire il mistero della vigna: essa è il simbolo e
la figura non solo del Popolo di Dio, ma di Gesù stesso. Lui è il
ceppo e noi, i discepoli, siamo i tralci; Lui è la «vera vite», nella
quale sono vitalmente inseriti i tralci (cf. Gv 15, 1 ss.). Il Concilio Vaticano II, riferendo le varie immagini bibliche che
illuminano il mistero della Chiesa, ripropone l'immagine della vite e dei
tralci: «Cristo è la vera vite, che dà vita e fecondità ai tralci, cioè
a noi, che per mezzo della Chiesa rimaniamo in Lui, e senza di Lui nulla
possiamo fare (Gv 15, 1-5)»(12). La Chiesa stessa è, dunque, la
vigna evangelica. E' mistero perché l'amore e la vita del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo sono il dono assolutamente gratuito
offerto a quanti sono nati dall'acqua e dallo Spirito (cf. Gv 3,
5), chiamati a rivivere la comunione stessa di Dio e a manifestarla
e comunicarla nella storia (missione): «In quel giorno _ dice Gesù
_ voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi» (Gv
14, 20). Ora solo all'interno del mistero della Chiesa come mistero di
comunione si rivela l'«identità» dei fedeli laici, la loro
originale dignità. E solo all'interno di questa dignità si possono
definire la loro vocazione e la loro missione nella Chiesa e nel mondo. Chi sono i fedeli laici 9. I Padri sinodali hanno giustamente rilevato la necessità di
individuare e di proporre una descrizione positiva della vocazione
e della missione dei fedeli laici, approfondendo lo studio della dottrina
del Concilio Vaticano II alla luce sia dei più recenti documenti del
Magisterio sia dell'esperienza della vita stessa della Chiesa guidata
dallo Spirito Santo(13). Nel dare risposta all'interrogativo «chi sono i fedeli laici»,
il Concilio, superando precedenti interpretazioni prevalentemente
negative, si è aperto ad una visione decisamente positiva e ha
manifestato il suo fondamentale intento nell'asserire la piena
appartenenza dei fedeli laici alla Chiesa e al suo mistero e il carattere
peculiare della loro vocazione, che ha in modo speciale lo scopo di «cercare
il Regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio»(14).
«Col nome di laici _ così la Costituzione Lumen gentium li
descrive _ si intendono qui tutti i fedeli ad esclusione dei membri
dell'ordine sacro e dello stato religioso sancito dalla Chiesa, i fedeli
cioè, che, dopo essere stati incorporati a Cristo col Battesimo e
costituiti Popolo di Dio e, a loro modo, resi partecipi dell'ufficio
sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono,
nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano»(15). Già Pio XII diceva: «I fedeli, e più precisamente i laici, si
trovano nella linea più avanzata della vita della Chiesa; per loro la
Chiesa è il principio vitale della società umana. Perciò essi,
specialmente essi, debbono avere una sempre più chiara consapevolezza, non
soltanto di appartenere alla Chiesa, ma di essere la Chiesa, vale a
dire la comunità dei fedeli sulla terra sotto la condotta del Capo
comune, il Papa, e dei Vescovi in comunione con lui. Essisono la Chiesa(...)»(16). Secondo l'immagine biblica della vigna, i fedeli laici, come tutti
quanti i membri della Chiesa, sono tralci radicati in Cristo, la vera
vite, da Lui resi vivi e vivificanti. L'inserimento in Cristo per mezzo della fede e dei sacramenti
dell'iniziazione cristiana è la radice prima che origina la nuova
condizione del cristiano nel mistero della Chiesa, che costituisce la sua
più profonda «fisionomia», che sta alla base di tutte le vocazioni e
del dinamismo della vita cristiana dei fedeli laici: in Gesù Cristo,
morto e risorto, il battezzato diventa una «creatura nuova» (Gal
6, 15; 2 Cor 5, 17), una creatura purificata dal peccato e
vivificata dalla grazia. In tal modo, solo cogliendo la misteriosa ricchezza che Dio dona
al cristiano nel santo Battesimo è possibile delineare la «figura» del
fedele laico. Il battesimo e la novità cristiana 10. Non è esagerato dire che l'intera esistenza del fedele laico
ha lo scopo di portarlo a conoscere la radicale novità cristiana che
deriva dal Battesimo, sacramento della fede, perché possa viverne gli
impegni secondo la vocazione ricevuta da Dio. Per descrivere la «figura»
del fedele laico prendiamo ora in esplicita e più diretta considerazione,
tra gli altri, questi tre fondamentali aspetti: il Battesimo ci
rigenera alla vita dei figli di Dio, ci unisce a Gesù Cristo e al suo
Corpo che è la Chiesa, ci unge nello Spirito Santo costituendoci templi
spirituali. Figli nel Figlio 11. Ricordiamo le parole di Gesù a Nicodemo: «In verità, in
verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare
nel regno di Dio» (Gv 3, 5). Il santo Battesimo è, dunque, una
nuova nascita, è una rigenerazione. Proprio pensando a questo aspetto del dono battesimale l'apostolo
Pietro prorompe nel canto: «Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro
Gesù Cristo; nella sua grande misericordia egli ci ha rigenerati,
mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva,
per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce» (1 Pt
1, 3-4). E chiama i cristiani coloro che sono stati «rigenerati non
da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio viva ed
eterna» (1 Pt 1, 23). Con il santo Battesimo diventiamo figli di Dio nell'Unigenito
suo Figlio, Cristo Gesù. Uscendo dalle acque del sacro fonte, ogni
cristiano riascolta la voce che un giorno si è udita sulle rive del fiume
Giordano: «Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto» (Lc
3, 22), e capisce che è stato associato al Figlio prediletto, diventando
figlio di adozione (cf. Gal 4, 4-7) e fratello di Cristo. Si compie
così nella storia di ciascuno l'eterno disegno del Padre: «quelli che
egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi
all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti
fratelli» (Rom 8, 29). E' lo Spirito Santo che costituisce i battezzati in figli
di Dio e nello stesso tempo membra del corpo di Cristo. Lo ricorda Paolo
ai cristiani di Corinto: «Noi tutti siamo stati battezzati in un solo
Spirito per formare un solo corpo» (1 Cor 12, 13), sicché
l'apostolo può dire ai fedeli laici: «Ora voi siete corpo di Cristo e
sue membra, ciascuno per la sua parte» (1 Cor 12, 27);«Che voi
siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo
Spirito del suo Figlio» (Gal 4, 6; cf. Rom 8, 15-16). Un solo corpo in Cristo 12. Rigenerati come «figli nel Figlio», i battezzati sono
inscindibilmente «membri di Cristo e membri del corpo della Chiesa», come
insegna il Concilio di Firenze(17). Il Battesimo significa e produce un'incorporazione mistica ma
reale al corpo crocifisso e glorioso di Gesù. Mediante il sacramento Gesù
unisce il battezzato alla sua morte per unirlo alla sua risurrezione (cf. Rom
6, 3-5), lo spoglia dell'«uomo vecchio» e lo riveste dell'«uomo
nuovo», ossia di Se stesso: «Quanti siete stati battezzati in Cristo _
proclama l'apostolo Paolo _ vi siete rivestiti di Cristo» (Gal
3,27; cf. Ef 4, 22-24; Col 3, 9-10). Ne risulta che «noi,
pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo» (Rom 12, 5). Ritroviamo nelle parole di Paolo l'eco fedele dell'insegnamento di
Gesù stesso, il quale ha rivelato la misteriosa unità dei suoi
discepoli con Lui e tra di loro, presentandola come immagine e
prolungamento di quell'arcana comunione che lega il Padre al Figlio e il
Figlio al Padre nel vincolo amoroso dello Spirito (cf. Gv 17, 21). E' la stessa unità di cui Gesù parla con l'immagine della vite e
dei tralci: «Io sono la vite, voi i tralci» (Gv 15, 5),
un'immagine che fa luce non solo sull'intimità profonda dei discepoli con
Gesù ma anche sulla comunione vitale dei discepoli tra loro: tutti tralci
dell'unica Vite. Templi vivi e santi dello Spirito 13. Con un'altra immagine, quella di un edificio, l'apostolo
Pietro definisce i battezzati come «pietre vive» fondate su Cristo, la
«pietra angolare», e destinate alla «costruzione di un edificio
spirituale» (1 Pt 2, 5 ss). L'immagine ci introduce a un altro
aspetto della novità battesimale, così presentato dal Concilio Vaticano
II: «Per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo i battezzati
vengono consacrati a formare una dimora spirituale»(18). Lo Spirito Santo «unge» il battezzato, vi imprime il suo
indelebile sigillo (cf. 2 Cor 1, 21-22), e lo costituisce tempio
spirituale, ossia lo riempie della santa presenza di Dio grazie all'unione
e alla conformazione a Gesù Cristo. Con questa spirituale «unzione», il cristiano può, a suo modo,
ripetere le parole di Gesù: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per
questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai
poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e
ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un
anno di grazia del Signore» (Lc 4, 18-19; cf. Is 61, 1-2).
Così con l'effusione battesimale e cresimale il battezzato partecipa alla
medesima missione di Gesù il Cristo, il Messia Salvatore. Partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di
Gesù Cristo 14. Rivolgendosi ai battezzati come a «bambini appena nati»,
l'apostolo Pietro scrive: «Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata
dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite
impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale,
per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio,
per mezzo di Gesù Cristo (...). Ma voi siete la stirpe eletta, il
sacerdozio regale, la nazione santa, il popoio che Dio si è acquistato
perché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle
tenebre alla sua ammirabile luce (...)» (1 Pt 2, 4-5. 9). Ecco un nuovo aspetto della grazia e della dignità battesimale: i
fedeli laici partecipano, per la loro parte, al triplice ufficio _
sacerdotale, profetico e regale _ di Gesù Cristo. E questo un aspetto non
mai dimenticato dalla tradizione viva della Chiesa, come appare, ad
esempio, dalla spiegazione che del Salmo 26 offre Sant'Agostino. Scrive:
«Davide fu unto re. A quel tempo si ungevano solo il re e il sacerdote.
In queste due persone era prefigurato il futuro unico re e sacerdote,
Cristo (e perciò "Cristo" viene da "crisma"). Non
solo però è stato unto il nostro capo, ma siamo stati unti anche noi,
suo corpo (...). Perciò l'unzione spetta a tutti i cristiani, mentre al
tempo dell'Antico Testamento apparteneva a due sole persone. Appare chiaro
che noi siamo il corpo di Cristo dal fatto che siamo tutti unti e tutti in
lui siamo cristi e Cristo, perché in certo modo la testa e il corpo
formano il Cristo nella sua integrità»(19). Nella scia del Concilio Vaticano II(20), sin dall'inizio del mio
servizio pastorale, ho inteso esaltare la dignità sacerdotale, profetica
e regale dell'intero Popolo di Dio dicendo: «Colui che è nato dalla
Vergine Maria, il Figlio del falegname _ come si riteneva _ il Figlio del
Dio vivente, come ha confessato Pietro, è venuto per fare di tutti noi
"un regno di sacerdoti". Il Concilio Vaticano II ci ha ricordato
il mistero di questa potestà e il fatto che la missione di Cristo _
Sacerdote, Profeta-Maestro, Re _ continua nella Chiesa. Tutti, tutto il
Popolo di Dio è partecipe di questa triplice missione»(21). Con questa Esortazione i fedeli laici sono invitati ancora una
volta a rileggere, a meditare e ad assimilare con intelligenza e con amore
il ricco e fecondo insegnamento del Concilio circa la loro partecipazione
al triplice ufficio di Cristo(22). Ecco ora in sintesi gli elementi
essenziali di questo insegnamento. I fedeli laici sono partecipi dell'ufficio sacerdotale, per
il quale Gesù ha offerto Se stesso sulla Croce e continuamente si offre
nella celebrazione eucaristica a gloria del Padre per la salvezza
dell'umanità. Incorporati a Gesù Cristo, i battezzati sono uniti a Lui e
al suo sacrificio nell'offerta di se stessi e di tutte le loro attività
(cf. Rom 12, 1-2). Parlando dei fedeli laici il Concilio dice: «Tutte
le loro opere, le preghiere e le iniziative apostoliche, la vita coniugale
e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se
sono compiute nello Spirito, e persino le molestie della vita se sono
sopportate con pazienza, diventano spirituali sacrifici graditi a Dio per
Gesù Cristo (cf. 1 Pt 2, 5), i quali nella celebrazione
dell'Eucaristia sono piissimamente offerti al Padre insieme all'oblazione
del Corpo del Signore. Così anche i laici, operando santamente
dappertutto come adoratori, consacrano a Dio il mondo stesso»(23). La partecipazione all'ufficio profetico di Cristo, «il
quale e con la testimonianza della vita e con la virtù della parola ha
proclamato il Regno del Padre»(24), abilita e impegna i fedeli laici ad
accogliere nella fede il Vangelo e ad annunciarlo con la parola e con le
opere non esitando a denunciare coraggiosamente il male. Uniti a Cristo,
il «grande profeta» (Lc 7, 16), e costituiti nello Spirito «testimoni»
di Cristo Risorto, i fedeli laici sono resi partecipi sia del senso di
fede soprannaturale della Chiesa che «non può sbagliarsi nel credere»
(25) sia della grazia della parola (cf. At 2, 17-18; Ap 19,
10); sono altresì chiamati a far risplendere la novità e la forza del
Vangelo nella loro vita quotidiana, familiare e sociale, come pure ad
esprimere, con pazienza e coraggio, nelle contraddizioni dell'epoca
presente la loro speranza nella gloria «anche attraverso le strutture
della vita secolare»(26). Per la loro appartenenza a Cristo Signore e Re dell'universo i
fedeli laici partecipano al suo ufficio regale e sono da Lui
chiamati al servizio del Regno di Dio e alla sua diffusione nella storia.
Essi vivono la regalità cristiana, anzitutto mediante il combattimento
spirituale per vincere in se stessi il regno del peccato (cf. Rom 6,
12), e poi mediante il dono di sé per servire, nella carità e nella
giustizia, Gesù stesso presente in tutti i suoi fratelli, soprattutto nei
più piccoli (cf. Mt 25, 40). Ma i fedeli laici sono chiamati in particolare a ridare alla
creazione tutto il suo originario valore. Nell'ordinare il creato al vero
bene dell'uomo con un'attività sorretta dalla vita di grazia, essi
partecipano all'esercizio del potere con cui Gesù Risorto attrae a sé
tutte le cose e le sottomette, con Se stesso, al Padre, così che Dio sia
tutto in tutti (cf. Gv 12, 32; 1 Cor 15, 28). La partecipazione dei fedeli laici al triplice ufficio di Cristo
Sacerdote, Profeta e Re trova la sua radice prima nell'unzione del
Battesimo, il suo sviluppo nella Confermazione e il suo compimento e
sostegno dinamico nell'Eucaristia. E una partecipazione donata ai singoli
fedeli laici, ma in quanto formano l'unico Corpo del
Signore. Infatti, Gesù arricchisce dei suoi doni la Chiesa stessa, quale
suo Corpo e sua Sposa. In tal modo i singoli sono partecipi del triplice
ufficio di Cristo in quanto membra della Chiesa, come chiaramente
insegna l'apostolo Pietro, che definisce i battezzati come «la stirpe
eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è
acquistato» (1 Pt 2, 9). Proprio perché deriva dalla comunione
ecclesiale, la partecipazione dei fedeli laici al triplice ufficio di
Cristo esige d'essere vissuta e attuata nella comunione e per la
crescita della comunione stessa. Scriveva Sant'Agostino: «Come chiamiamo tutti cristiani in forza
del mistico crisma, così chiamiamo tutti sacerdoti perché sono membra
dell'unico sacerdote»(27). I fedeli laici e l'indole secolare 15. La novità cristiana è il fondamento e il titolo
dell'eguaglianza di tutti i battezzati in Cristo, di tutti i membri del
Popolo di Dio: «comune è la dignità dei membri per la loro
rigenerazione in Cristo, comune la grazia dei figli, comune la vocazione
alla perfezione, una sola salvezza, una sola speranza e indivisa carità»(28).
In forza della comune dignità battesimale il fedele laico è
corresponsabile, insieme con i ministri ordinati e con i religiosi e le
religiose, della missione della Chiesa. Ma la comune dignità battesimale assume nel fedele laico una
modalità che lo distingue, senza però separarlo, dal presbitero, dal
religioso e dalla religiosa. Il Concilio Vaticano II ha indicato questa
modalità nell'indole secolare: «L'indole secolare è propria e peculiare
dei laici»(29). Proprio per cogliere in modo completo, adeguato e specifico la
condizione ecclesiale del fedele laico è necessario approfondire la
portata teologica dell'indole secolare alla luce del disegno salvifico di
Dio e del mistero della Chiesa. Come diceva Paolo VI, la Chiesa «ha un'autentica dimensione
secolare, inerente alla sua intima natura e missione, la cui radice
affonda nel mistero del Verbo Incarnato, e che è realizzata in forme
diverse per i suoi membri»(30). La Chiesa, infatti, vive nel mondo anche se non è del mondo (cf. Gv
17, 16) ed è mandata a continuare l'opera redentrice di Gesù Cristo, la
quale «mentre per natura sua ha come fine la salvezza degli uomini,
abbraccia pure la instaurazione di tutto l'ordine temporale»(31). Certamente tutti i membri della Chiesa sono partecipi della
sua dimensione secolare; ma lo sono in forme diverse. In
particolare la partecipazione dei fedeli laici ha una sua modalità
di attuazione e di funzione che, secondo il Concilio, è loro «propria e
peculiare»: tale modalità viene designata con l'espressione «indole
secolare»(32). In realtà il Concilio descrive la condizione secolare dei fedeli
laici indicandola, anzitutto, come il luogo nel quale viene loro rivolta
la chiamata di Dio: «Ivi sono da Dio chiamati»(33). Si tratta di
un «luogo» presentato in termini dinamici: i fedeli laici «vivono nel
secolo, cioèimplicati in tutti e singoli gli impieghi e gli affari del
mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui
la loro esistenza è come intessuta»(34). Essi sono persone che vivono la
vita normale nel mondo, studiano, lavorano, stabiliscono rapporti amicali,
sociali, professionali, culturali, ecc. Il Concilio considera la loro condizione
non semplicemente come un dato esteriore e ambientale, bensì come una
realtà destinata a trovare in Gesù Cristo la pienezza del suo
significato(35). Anzi afferma che «lo stesso Verbo incarnato volle
essere partecipe della convivenza umana (...) Santificò le relazioni
umane, innanzitutto quelle familiari, dalle quali traggono origine i
rapporti sociali, volontariamente sottomettendosi alle leggi della sua
patria. Volle condurre la vita di un lavoratore del suo tempo e della sua
regione»(36). Il «mondo» diventa così l'ambito e il mezzo della vocazione
cristiana dei fedeli laici, perché esso stesso è
destinato a glorificare Dio Padre in Cristo. Il Concilio può allora
indicare il senso proprio e peculiare della vocazione divina rivolta ai
fedeli laici. Non sono chiamati ad abbandonare la posizione ch'essi hanno
nel mondo. Il Battesimo non li toglie affatto dal mondo, come rileva
l'apostolo Paolo: «Ciascuno, fratelli, rimanga davanti a Dio in quella
condizione in cui era quando è stato chiamato» (1 Cor 7, 24); ma
affida loro una vocazione che riguarda proprio la situazione intramondana:
i fedeli laici, infatti, «sono da Dio chiamati a contribuire, quasi
dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo mediante
l'esercizio della loro funzione propria e sotto la guida dello spirito
evangelico, e in questo modo a rendere visibile Cristo agli altri,
principalmente con la testimonianza della loro vita e con il fulgore della
fede, della speranza e della carità»(37). Così l'essere e l'agire nel
mondo sono per i fedeli laici una realtà non solo antropologica e
sociologica, ma anche e specificamente teologica ed ecclesiale. Nella loro
situazione intramondana, infatti, Dio manifesta il suo disegno e comunica
la particolare vocazione di «cercare il Regno di Dio trattando le cose
temporali e ordinandole secondo Dio»(38). Proprio in questa prospettiva i Padri sinodali hanno detto: «L'indole
secolare del fedele laico non è quindi da definirsi soltanto in senso
sociologico, ma soprattutto in senso teologico. La caratteristica secolare
va intesa alla luce dell'atto creativo e redentivo di Dio, che ha affidato
il mondo agli uomini e alle donne, perché essi partecipino all'opera
della creazione, liberino la creazione stessa dall'influsso del peccato e
santifichino se stessi nel matrimonio o nella vita celibe, nella famiglia,
nella professione e nelle varie attività sociali»(39). La condizione ecclesiale dei fedeli laici viene
radicalmente definita dalla loro novità cristiana e caratterizzata
dalla loro indole secolare(40). Le immagini evangeliche del sale, della luce e del lievito, pur
riguardando indistintamente tutti i discepoli di Gesù, trovano una
specifica applicazione ai fedeli laici. Sono immagini splendidamente
significative, perché dicono non solo l'inserimento profondo e la
partecipazione piena dei fedeli laici nella terra, nel mondo, nella
comunità umana; ma anche e soprattutto la novità e l'originalità di un
inserimento e di una partecipazione destinati alla diffusione del Vangelo
che salva. Chiamati alla santità 16. La dignità dei fedeli laici ci si rivela in pienezza se
consideriamo la prima e fondamentale vocazione che il Padre in Gesù
Cristo per mezzo dello Spirito rivolge a ciascuno di loro: la vocazione
alla santità, ossia alla perfezione della carità. Il santo è la
testimonianza più splendida della dignità conferita al discepolo di
Cristo. Sull'universale vocazione alla santità ha avuto parole
luminosissime il Concilio Vaticano II. Si può dire che proprio questa sia
stata la consegna primaria affidata a tutti i figli e le figlie della
Chiesa da un Concilio voluto per il rinnovamento evangelico della vita
cristiana(41). Questa consegna non è una semplice esortazione morale,
bensì un'insopprimibile esigenza del mistero della Chiesa: essa è
la Vigna scelta, per mezzo della quale i tralci vivono e crescono con la
stessa linfa santa e santificante di Cristo; è il Corpo mistico, le cui
membra partecipano della stessa vita di santità del Capo che è Cristo;
è la Sposa amata dal Signore Gesù, che ha consegnato se stesso per
santificarla (cf. Ef 5, 25 ss.). Lo Spirito che santificò la
natura umana di Gesù nel seno verginale di Maria (cf. Lc 1, 35) è
lo stesso Spirito che è dimorante e operante nella Chiesa al fine di
comunicarle la santità del Figlio di Dio fatto uomo. E' quanto mai urgente che oggi tutti i cristiani riprendano il
cammino del rinnovamento evangelico, accogliendo con generosità l'invito
apostolico ad «essere santi in tutta la condotta» (1 Pt 1, 15).
Il Sinodo straordinario del 1985, a vent'anni dalla conclusione del
Concilio, ha opportunamente insistito su questa urgenza: «Poiché la Chiesa in Cristo è mistero, deve essere considerata
segno e strumento di santità (...). I santi e le sante sempre sono stati
fonte e origine di rinnovamento nelle più difficili circostanze in tutta
la storia della Chiesa. Oggi abbiamo grandissimo bisogno di santi, che
dobbiamo implorare da Dio con assiduità»(42). Tutti nella Chiesa, proprio perché ne sono membri, ricevono e
quindi condividono la comune vocazione alla santità. A pieno titolo,
senz'alcuna differenza dagli altri membri della Chiesa, ad essa sono
chiamati i fedeli laici: «Tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono
chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità»(43);
«Tutti i fedeli sono invitati e tenuti a tendere alla santità e alla
perfezione del proprio stato»(44). La vocazione alla santità affonda le sue radici nel Battesimo e
viene riproposta dagli altri Sacramenti, principalmente dall'Eucaristia:
rivestiti di Gesù Cristo e abbeverati dal suo Spirito, i cristiani sono
«santi» e sono, perciò, abilitati e impegnati a manifestare la santità
del loro essere nella santità di tutto il loro operare. L'apostolo
Paolo non si stanca di ammonire tutti i cristiani perché vivano «come si
addice a santi» (Ef 5, 3). La vita secondo lo Spirito, il cui frutto è la santificazione
(cf. Rom 6, 22; Gal 5, 22), suscita ed esige da tutti
e da ciascun battezzato la sequela e l'imitazione di Gesù Cristo, nell'accoglienza
delle sue Beatitudini, nell'ascolto e nella meditazione della Parola di
Dio, nella consapevole e attiva partecipazione alla vita liturgica e
sacramentale della Chiesa, nella preghiera individuale, familiare e
comunitaria, nella fame e nella sete di giustizia, nella pratica del
comandamento dell'amore in tutte le circostanze della vita e nel servizio
ai fratelli, specialmente se piccoli, poveri e sofferenti. Santificarsi nel mondo 17. La vocazione dei fedeli laici alla santità comporta che la
vita secondo lo Spirito si esprima in modo peculiare nel loro inserimento
nelle realtà temporali e nella loro partecipazione alle attività
terrene. E' ancora l'apostolo ad ammonirci: «Tutto quello che fate in
parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per
mezzo di lui grazie a Dio Padre» (Col 3, 17). Riferendo le parole
dell'apostolo ai fedeli laici, il Concilio afferma categoricamente: «Né
la cura della famiglia né gli altri impegni secolari devono essere
estranei all'orientamento spirituale della vita»(45). A loro volta i
Padri sinodali hanno detto: «L'unità della vita dei fedeli laici è di
grandissima importanza: essi, infatti, debbono santificarsi nell'ordinaria
vita professionale e sociale. Perché possano rispondere alla loro
vocazione, dunque, i fedeli laici debbono guardare alle attività della
vita quotidiana come occasione di unione con Dio e di compimento della sua
volontà, e anche di servizio agli altri uomini, portandoli alla comunione
con Dio in Cristo»(46). La vocazione alla santità dev'essere percepita e vissuta dai
fedeli laici, prima che come obbligo esigente e irrinunciabile, come segno
luminoso dell'infinito amore del Padre che li ha rigenerati alla sua vita
di santità. Tale vocazione, allora, deve dirsi una componente
essenziale e inseparabile della nuova vita battesimale, e pertanto un
elemento costitutivo della loro dignità. Nello stesso tempo la vocazione
alla santità è intimamente connessa con la missione e con la
responsabilità affidate ai fedeli laici nella Chiesa e nel mondo.
Infatti, già la stessa santità vissuta, che deriva dalla partecipazione
alla vita di santità della Chiesa, rappresenta il primo e fondamentale
contributo all'edificazione della Chiesa stessa, quale «Comunione dei
Santi». Agli occhi illuminati dalla fede si spalanca uno scenario
meraviglioso: quello di tantissimi fedeli laici, uomini e donne, che
proprio nella vita e nelle attività d'ogni giorno, spesso inosservati o
addirittura incompresi, sconosciuti ai grandi della terra ma guardati con
amore dal Padre, sono gli operai instancabili che lavorano nella vigna del
Signore, sono gli artefici umili e grandi _ certo per la potenza della
grazia di Dio _ della crescita del Regno di Dio nella storia. La santità, poi, deve dirsi un fondamentale presupposto e una
condizione del tutto insostituibile per il compiersi della missione di
salvezza nella Chiesa. E' la santità della Chiesa la sorgente segreta e
la misura infallibile della sua operosità apostolica e del suo slancio
missionario. Solo nella misura in cui la Chiesa, Sposa di Cristo, si
lascia amare da Lui e Lo riama, essa diventa Madre feconda nello Spirito. Riprendiamo di nuovo l'immagine biblica: lo sbocciare e
l'espandersi dei tralci dipendono dal loro inserimento nella vite. «Come
il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così
anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane
in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far
nulla» (Gv 15, 4-5). E' naturale qui ricordare la solenne proclamazione di fedeli
laici, uomini e donne, come beati e santi, avvenuta durante il mese del
Sinodo. L'intero Popolo di Dio, e i fedeli laici in particolare, possono
trovare ora nuovi modelli di santità e nuove testimonianze di virtù
eroiche vissute nelle condizioni comuni e ordinarie dell'esistenza umana.
Come hanno detto i Padri sinodali: «Le Chiese locali e soprattutto le
cosiddette Chiese più giovani debbono riconoscere attentamente fra i
propri membri quegli uomini e quelle donne che hanno offerto in tali
condizioni (le condizioni quotidiane del mondo e lo stato coniugale) la
testimonianza della santità e che possono essere di esempio agli altri
affinché, se si dia il caso, li propongano per la beatificazione e la
canonizzazione»(47). Al termine di queste riflessioni, destinate a definire la
condizione ecclesiale del fedele laico, ritorna alla mente il celebre
monito di San Leone Magno: «Agnosce, o Christiane, dignitatem tuam»(48).
E' lo stesso monito di San Massimo, vescovo di Torino, rivolto a quanti
avevano ricevuto l'unzione del santo Battesimo: «Considerate l'onore che
vi è fatto in questo mistero!»(49). Tutti i battezzati sono invitati a
riascoltare le parole di Sant'Agostino: «Rallegriamoci e ringraziamo:
siamo diventati non solo cristiani, ma Cristo (...). Stupite e gioite:
Cristo siamo diventati!»(50). La dignità cristiana, fonte dell'eguaglianza di tutti i membri
della Chiesa, garantisce e promuove lo spirito di comunione e di fraternità,
e, nello stesso tempo, diventa il segreto e la forza del dinamismo
apostolico e missionario dei fedeli laici. E' una dignità esigente, la
dignità degli operai chiamati dal Signore a lavorare nella sua vigna: «Grava
su tutti i laici _ leggiamo nel Concilio _ il glorioso peso di lavorare,
perché il divino disegno di salvezza raggiunga ogni giorno di più tutti
gli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra»(51). |
|
|
CAPITOLO II TUTTI TRALCI
DELL'UNICA VITE Il mistero della Chiesa-Comunione 18. Riascoltiamo le parole di Gesù: «Io sono la vera vite e il
Padre mio è il vignaiolo (...). Rimanete in me e io in voi» (Gv 15,
1-4). Con queste semplici parole ci viene rivelata la comunione
misteriosa che vincola in unità il Signore e i discepoli, Cristo e i
battezzati: una comunione viva e vivificante, per la quale i cristiani non
appartengono a se stessi ma sono proprietà di Cristo, come i tralci
inseriti nella vite. La comunione dei cristiani con Gesù ha quale modello, fonte e
meta la comunione stessa del Figlio con il Padre nel dono dello Spirito
Santo: uniti al Figlio nel vincolo amoroso dello Spirito, i cristiani sono
uniti al Padre. Gesù continua: «Io sono la vite, voi i tralci» (Gv 15,
5). Dalla comunione dei cristiani con Cristo scaturisce la comunione dei
cristiani tra di loro: tutti sono tralci dell'unica Vite, che è Cristo.
In questa comunione fraterna il Signore Gesù indica il riflesso
meraviglioso e la misteriosa partecipazione all'intima vita d'amore del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per questa comunione Gesù prega:
«Tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano
anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai
mandato» (Gv 17, 21). Tale comunione è il mistero stesso della Chiesa, come
ci ricorda il Concilio Vaticano II, con la celebre parola di San Cipriano:
«La Chiesa universale si presenta come "un popolo adunato dall'unità
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo"»(52). A questo mistero
della Chiesa-Comunione siamo abitualmente richiamati all'inizio della
celebrazione eucaristica, allorquando il sacerdote ci accoglie con il
saluto dell'apostolo Paolo: «La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore
di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi» (2 Cor 13,
13). Dopo aver delineato la «figura» dei fedeli laici nella loro
dignità dobbiamo ora riflettere sulla loro missione e responsabilità
nella Chiesa e nel mondo: ma queste si possono comprendere adeguatamente
solo nel contesto vivo della Chiesa-Comunione. Il Concilio e l'ecclesiologia di comunione 19. E' questa l'idea centrale che di se stessa la Chiesa ha
riproposto nel Concilio Vaticano II, come ci ha ricordato il Sinodo
straordinario del 1985, celebratosi a vent'anni dall'evento conciliare: «L'ecclesiologia
di comunione è l'idea centrale e fondamentale nei documenti del Concilio.
La koinonia-comunione, fondata sulla Sacra Scrittura, è tenuta in
grande onore nella Chiesa antica e nelle Chiese orientali fino ai nostri
giorni. Perciò molto è stato fatto dal Concilio Vaticano II perché la
Chiesa come comunione fosse più chiaramente intesa e concretamente
tradotta nella vita. Che cosa significa la complessa parola
"comunione"? Si tratta fondamentalmente della comunione con Dio
per mezzo di Gesù Cristo, nello Spirito Santo. Questa comunione si ha
nella parola di Dio e nei sacramenti. Il Battesimo è la porta ed il
fondamento della comunione nella Chiesa. L'Eucaristia è la fonte ed il
culmine di tutta la vita cristiana (cf. LG, 11). La comunione del
corpo eucaristico di Cristo significa e produce, cioè edifica l'intima
comunione di tutti i fedeli nel corpo di Cristo che è la Chiesa (cf. 1
Cor 10, 16 s.)»(53). All'indomani del Concilio così Paolo VI si rivolgeva ai fedeli:
«La Chiesa è una comunione. Che cosa vuol dire in questo caso:
comunione? Noi vi rimandiamo al paragrafo del catechismo che parla della sanctorum
communionem, la comunione dei santi. Chiesa vuol dire comunione dei
santi. E comunione dei santi vuol dire una duplice partecipazione vitale:
l'incorporazione dei cristiani nella vita di Cristo, e la circolazione
della medesima carità in tutta la compagine dei fedeli, in questo mondo e
nell'altro. Unione a Cristo ed in Cristo; e unione fra i cristiani, nella
Chiesa»(54). Le immagini bibliche, con cui il Concilio ha voluto introdurci a
contemplare il mistero della Chiesa, pongono in luce la realtà della
Chiesa-Comunione nella sua inscindibile dimensione di comunione dei
cristiani con Cristo e di comunione dei cristiani tra loro. Sono le
immagini dell'ovile, del gregge, della vite, dell'edificio spirituale,
della città santa(55). Soprattutto è l'immagine del corpo presentata
dall'apostolo Paolo, la cui dottrina rifluisce fresca e attraente in
numerose pagine del Concilio(56). A sua volta il Concilio riprende
dall'intera storia della salvezza e ripropone l'immagine della Chiesa come
Popolo di Dio: «Piacque a Dio di santificare e salvare gli uomini
non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di
loro un popolo, che lo riconoscesse nella verità e santamente Lo servisse»(57).
Già nelle sue primissime righe, la Costituzione Lumen gentium compendia
in modo mirabile questa dottrina scrivendo: «La Chiesa è in Cristo come
sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità
di tutto il genere umano»(58). La realtà della Chiesa-Comunione è, allora,
parte integrante, anzi rappresenta il contenuto centrale del «mistero»,
ossia del disegno divino della salvezza dell'umanità. Per questo la
comunione ecclesiale non può essere interpretata in modo adeguato se
viene intesa come una realtà semplicemente sociologica e psicologica. La
Chiesa-Comunione è il popolo «nuovo», il popolo «messianico», il
popolo che «ha per Capo Cristo (...) per condizione la dignità e la
libertà dei figli di Dio (...) per legge il nuovo precetto di amare come
lo stesso Cristo ci ha amati (...) per fine il Regno di Dio (... ed è)
costituito da Cristo in una comunione di vita, di carità e di verità»(59).
I vincoli che uniscono i membri del nuovo Popolo tra di loro _ e prima
ancora con Cristo _ non sono quelli della «carne» e del «sangue», bensì
quelli dello spirito, più precisamente quelli dello Spirito Santo, che
tutti i battezzati ricevono (cf. Gl 3, 1). Infatti, quello Spirito che dall'eternità vincola l'unica e
indivisa Trinità, quello Spirito che «nella pienezza del tempo» (Gal
4, 4) unisce indissolubilmente la carne umana al Figlio di Dio, quello
stesso e identico Spirito è nel corso delle generazioni cristiane la
sorgente ininterrotta e inesauribile della comunione nella e della Chiesa. Una comunione organica: diversità e complementarietà 20. La comunione ecclesiale si configura, più precisamente, come
una comunione «organica», analoga a quella di un corpo vivo e operante:
essa, infatti, è caratterizzata dalla compresenza della diversità e
della complementarietà delle vocazioni e condizioni di vita, dei
ministeri, dei carismi e delle responsabilità. Grazie a questa diversità
e complementarietà ogni fedele laico si trova in relazione con tutto
il corpo e ad esso offre il suo proprio contributo. Sulla comunione organica del Corpo mistico di Cristo insiste in
modo tutto particolare l'apostolo Paolo, il cui ricco insegnamento
possiamo riascoltare nella sintesi tracciata dal Concilio: Gesù Cristo _
leggiamo nella Costituzione Lumen gentium _ «comunicando il suo
Spirito, costituisce misticamente come suo corpo i suoi fratelli, chiamati
da tutte le genti. In quel corpo la vita di Cristo si diffonde nei
credenti (...). Come tutte le membra del corpo umano, anche se numerose,
formano un solo corpo, così i fedeli in Cristo (cf. 1 Cor 12, 12).
Anche nell'edificazione del corpo di Cristo vige la diversità delle
membra e delle funzioni. Uno è lo Spirito, il quale per l'utilità della
Chiesa distribuisce i suoi vari doni con magnificenza proporzionata alla
sua ricchezza e alle necessità dei servizi (cf. 1 Cor 12, 1-11 ).
Fra questi doni viene al primo posto la grazia degli Apostoli, alla cui
autorità lo stesso Spirito sottomette anche i carismatici (cf. 1 Cor
14). Ed è ancora lo Spirito stesso che, con la sua forza e mediante
l'intima connessione delle membra, produce e stimola la carità tra i
fedeli. E quindi se un membro soffre, soffrono con esso tutte le altre
membra; se un membro è onorato, ne gioiscono con esso tutte le altre
membra (cf. 1 Cor 12, 26)»(60). E' sempre l'unico e identico Spirito il principio dinamico
della varietà e dell'unità nella e della Chiesa. Leggiamo di nuovo
nella Costituzione Lumen gentium: «Perché poi ci rinnovassimo
continuamente in Lui (Cristo) (cf. Ef 4, 23), ci ha dato del suo
Spirito, il quale, unico e identico nel Capo e nelle membra, dà a tutto
il corpo la vita, l'unità e il movimento, così che i santi Padri
poterono paragonare la sua funzione con quella che esercita il principio
vitale, cioè l'anima, nel corpo umano»(61). E in un altro testo,
particolarmente denso e prezioso per cogliere l'«organicità» propria
della comunione ecclesiale anche nel suo aspetto di crescita incessante
verso la perfetta comunione, il Concilio scrive: «Lo Spirito dimora nella
Chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio (cf. 1 Cor 3,
16; 6, 19) e in essi prega e rende testimonianza dell'adozione filiale
(cf. Gal 4, 6; Rom 8, 15-16. 26). Egli guida la Chiesa verso
tutta intera la verità (cf. Gv 16, 13), la unifica nella comunione
e nel servizio, la istruisce e dirige con diversi doni gerarchici e
carismatici, la abbellisce dei suoi frutti (cf. Ef 4, 11-12; 1
Cor 12, 4; Gal 5, 22). Con la forza del Vangelo fa
ringiovanire la Chiesa, continuamente la rinnova e la conduce alla
perfetta unione con il suo Sposo. Poiché lo Spirito e la Sposa dicono al
Signore Gesù: Vieni! (cf. Ap 22, 17»(62). La comunione ecclesiale è, dunque, un
dono, un grande dono dello Spirito Santo, che i fedeli laici sono
chiamati ad accogliere con gratitudine e, nello stesso tempo, a vivere con
profondo senso di responsabilità. Ciò si attua concretamente mediante la
loro partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa, al cui
servizio i fedeli laici pongono i loro diversi e complementari ministeri e
carismi. Il fedele laico «non può mai chiudersi in se stesso, isolandosi
spiritualmente dalla comunità, ma deve vivere in un continuo scambio con
gli altri, con un vivo senso di fraternità, nella gioia di una uguale
dignità e nell'impegno di far fruttificare insieme l'immenso tesoro
ricevuto in eredità. Lo Spirito del Signore dona a lui, come agli altri,
molteplici carismi, lo invita a differenti ministeri e incarichi, gli
ricorda, come anche lo ricorda agli altri in rapporto con lui, che tutto
ciò che lo distingue non è un di più di dignità, ma una
speciale e complementare abilitazione al servizio (...).Così, i
carismi, i ministeri, gli incarichi ed i servizi del Fedele Laico esistono
nella comunione e per la comunione. Sono ricchezze complementari a favore
di tutti, sotto la saggia guida dei Pastori»(63). I ministeri e i carismi, doni dello Spirito alla Chiesa 21. Il Concilio Vaticano II presenta i ministeri e i carismi come
doni dello Spirito Santo per l'edificazione del Corpo di Cristo e per la
sua missione di salvezza nel mondo(64). La Chiesa, infatti, è diretta e
guidata dallo Spirito che elargisce diversi doni gerarchici e carismatici
a tutti i battezzati chiamandoli ad essere, ciascuno a suo modo, attivi e
corresponsabili. Consideriamo ora i ministeri e i carismi in diretto riferimento ai
fedeli laici e alla loro partecipazione alla vita della Chiesa-Comunione. Ministeri, uffici e funzioni I ministeri presenti e operanti nella Chiesa sono tutti, anche se
in modalità diverse, una partecipazione al ministero di Gesù Cristo, il
buon Pastore che dà la vita per le sue pecore (cf. Gv 10, 11 ), il
servo umile e totalmente sacrificato per la salvezza di tutti (cf. Mc 10,
45). Paolo è oltremodo chiaro nel parlare della costituzione ministeriale
delle Chiese apostoliche. Nella Prima Lettera ai Corinzi scrive: «Alcuni
Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo
luogo come profeti, in terzo luogo come maestri (...)» (1 Cor 12,
28). Nella Lettera agli Efesini leggiamo: «A ciascuno di noi è stata
data la grazia secondo la misura del dono di Cristo (...). E' lui che ha
dato da una parte gli apostoli, d'altra parte i profeti, gli evangelisti,
i pastori e i maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il
ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo
tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo
stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di
Cristo» (Ef 4, 7. 11-13; cf. Rom 12, 4-8). Come appare da
questi e da altri testi del Nuovo Testamento, i ministeri, come pure i
doni e i compiti ecclesiali, sono molteplici e diversi. I ministeri derivanti dall'Ordine 22. Nella Chiesa si trovano in primo luogo, i ministeri
ordinati, ossia i ministeri che derivano dal sacramento
dell'Ordine. Il Signore Gesù, infatti, ha scelto e costituito gli
Apostoli, seme del Popolo della Nuova Alleanza e origine della sacra
Gerarchia(65), affidando loro il mandato di fare discepole tutte le genti
(cf. Mt 28, 19), di formare e di reggere il popolo sacerdotale. La
missione degli Apostoli, che il Signore Gesù continua a trasmettere ai
pastori del suo popolo, è un vero servizio, significativamente chiamato
nella Sacra Scrittura «diakonia», ossia servizio, ministero.
Nella ininterrotta successione apostolica i ministri ricevono il carisma
dello Spirito Santo dal Cristo Risorto mediante il sacramento dell'Ordine:
ricevono così l'autorità e il potere sacro di agire «in persona Christi
Capitis» (nella persona di Cristo Capo)(66) per servire la Chiesa e per
radunarla nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e dei sacramenti. I ministeri ordinati, prima ancora che per le persone che li
ricevono, sono una grazia per l'intera Chiesa. Essi esprimono e attuano
una partecipazione al sacerdozio di Gesù Cristo che è diversa, non solo
per grado ma per essenza, dalla partecipazione donata con il Battesimo e
con la Confermazione a tutti i fedeli. D'altra parte il sacerdozio
ministeriale, come ha ricordato il Concilio Vaticano II, è essenzialmente
finalizzato al sacerdozio regale di tutti i fedeli e ad esso ordinato(67). Per questo, per assicurare e per far crescere la comunione nella
Chiesa, in particolare nell'ambito dei diversi e complementari ministeri,
i pastori devono riconoscere che il loro ministero è radicalmente
ordinato al servizio di tutto il Popolo di Dio (cf. Eb 5, 1), e,
a loro volta, i fedeli laici devono riconoscere che il sacerdozio
ministeriale è del tutto necessario per la loro vita e per la loro
partecipazione alla missione nella Chiesa(68). Ministeri, uffici e funzioni dei laici 23. La missione salvifica della Chiesa nel mondo è attuata non
solo dai ministri in virtù del sacramento dell'Ordine ma anche da tutti i
fedeli laici: questi, infatti, in virtù della loro condizione battesimale
e della loro specifica vocazione, nella misura a ciascuno propria,
partecipano all'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo. I pastori, pertanto, devono riconoscere e promuovere i ministeri,
gli uffici e le funzioni dei fedeli laici, che hanno il loro fondamento
sacramentale nel Battesimo e nella Confermazione, nonché, per molti
di loro, nel Matrimonio. Quando poi la necessità o l'utilità della Chiesa lo esige, i
pastori possono affidare ai fedeli laici, secondo le norme stabilite dal
diritto universale, alcuni compiti che sono connessi con il loro proprio
ministero di pastori ma che non esigono il carattere dell'Ordine. Il
Codice di Diritto Canonico scrive: «Ove le necessità della Chiesa lo
suggeriscano, in mancanza di ministri, anche i laici, pur senza essere
lettori o accoliti, possono supplire alcuni dei loro uffici, cioè
esercitare il ministero della parola, presiedere alle preghiere
liturgiche, amministrare il Battesimo e distribuire la sacra Comunione,
secondo le disposizioni del diritto»(69).L'esercizio però di questi
compiti non fa del fedele laico un pastore: in realtà non è il
compito a costituire il ministero, bensì l'ordinazione sacramentale. Solo
il sacramento dell'Ordine attribuisce al ministero ordinato una peculiare
partecipazione all'ufficio di Cristo Capo e Pastore e al suo sacerdozio
eterno(70). Il compito esercitato in veste di supplente deriva la sua
legittimazione immediatamente e formalmente dalla deputazione ufficiale
data dai pastori, e nella sua concreta attuazione è diretto dall'autorità
ecclesiastica(71). La recente Assemblea del Sinodo ha presentato un ampio e
significativo panorama della situazione ecclesiale circa i ministeri, gli
uffici e le funzioni dei battezzati. I Padri hanno vivamente apprezzato
l'apporto apostolico dei fedeli laici, uomini e donne, in favore
dell'evangelizzazione, della santificazione e dell'animazione cristiana
delle realtà temporali, come pure la loro generosa disponibilità alla
supplenza in situazioni di emergenza e di croniche necessità(72). In seguito al rinnovamento liturgico promosso dal Concilio, gli
stessi fedeli laici hanno acquisito più viva coscienza dei loro compiti
nell'assemblea liturgica e nella sua preparazione, e si sono resi
ampiamente disponibili a svolgerli: la celebrazione liturgica, infatti, è
un'azione sacra non soltanto del clero, ma di tutta l'assemblea. E'
naturale, pertanto, che i compiti non propri dei ministri ordinati siano
svolti dai fedeli laici(73). Il passaggio poi da un effettivo
coinvolgimento dei fedeli laici nell'azione liturgica a quello
nell'annuncio della Parola di Dio e nella cura pastorale è stato
spontaneo(74). Nella stessa Assemblea sinodale non sono mancati però, insieme a
quelli positivi, giudizi critici circa l'uso troppo indiscriminato del
termine «ministero», la confusione e talvolta il livellamento tra il
sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale, la scarsa osservanza di
certe leggi e norme ecclesiastiche, l'interpretazione arbitraria del
concetto di «supplenza», la tendenza alla «clericalizzazione» dei
fedeli laici e il rischio di creare di fatto una struttura ecclesiale di
servizio parallela a quella fondata sul sacramento dell'Ordine. Proprio per superare questi pericoli i Padri sinodali hanno
insistito sulla necessità che siano espresse con chiarezza, anche
servendosi di una terminologia più precisa(75), l'unità di missione della
Chiesa, alla quale partecipano tutti i battezzati, ed insieme l'essenziale
diversità di ministero dei pastori, radicato nel sacramento
dell'Ordine, rispetto agli altri ministeri, uffici e funzioni ecclesiali,
che sono radicati nei sacramenti del Battesimo e della Confermazione. E' necessario allora, in primo luogo, che i pastori, nel
riconoscere e nel conferire ai fedeli laici i vari ministeri, uffici e
funzioni, abbiano la massima cura di instruirli sulla radice battesimale
di questi compiti. E' necessario poi che i pastori siano vigilanti perché
si eviti un facile ed abusivo ricorso a presunte «situazioni di emergenza»
o di «necessaria supplenza», là dove obiettivamente non esistono o là
dove è possibile ovviarvi con una programmazione pastorale più
razionale. I vari ministeri, uffici e funzioni che i fedeli laici possono
legittimamente svolgere nella liturgia, nella trasmissione della fede e
nelle strutture pastorali della Chiesa, dovranno essere esercitati in
conformità alla loro specifica vocazione laicale, diversa da quella
dei sacri ministri. In tal senso, l'Esortazione Evangelii nuntiandi, che
tanta e benefica parte ha avuto nello stimolare la diversificata
collaborazione dei fedeli laici alla vita e alla missione evangelizzatrice
della Chiesa, ricorda che «il campo proprio della loro attività
evangelizzatrice è il mondo vasto e complicato della politica, della
realtà sociale, dell'economia; così pure della cultura, delle scienze e
delle arti, della vita internazionale, degli strumenti della comunicazione
sociale; ed anche di altre realtà particolarmente aperte
all'evangelizzazione, quali l'amore, la famiglia, l'educazione dei bambini
e degli adolescenti, il lavoro professionale, la sofferenza. Più ci
saranno laici penetrati di spirito evangelico, responsabili di queste
realtà ed esplicitamente impegnati in esse, competenti nel promuoverle e
consapevoli di dover sviluppare tutta la loro capacità cristiana spesso
tenuta nascosta e soffocata, tanto più queste realtà, senza nulla
perdere né sacrificare del loro coefficiente umano, ma manifestando una
dimensione trascendente spesso sconosciuta, si troveranno al servizio
dell'edificazione del Regno di Dio, e quindi della salvezza in Gesù
Cristo»(76). Durante i lavori del Sinodo i Padri hanno dedicato non poca
attenzione al Lettorato e all'Accolitato. Mentre in passato
esistevano nella Chiesa Latina soltanto come tappe spirituali
dell'itinerario verso i ministeri ordinati, con il Motu proprio di Paolo
VI Ministeria quaedam (15Agosto 1972) essi hanno ricevuto una loro
autonomia e stabilità, come pure una loro possibile destinazione agli
stessi fedeli laici, sia pure soltanto uomini. Nello stesso senso si è
espresso il nuovo Codice di Diritto Canonico(77). Ora i Padri sinodali
hanno espresso il desiderio che «il Motu proprio "Ministeria quaedam"
sia rivisto, tenendo conto dell'uso delle Chiese locali e soprattutto
indicando i criteri secondo cui debbano essere scelti i destinatari di
ciascun ministero»(78). In tal senso è stata costituita un'apposita Commissione non solo
per rispondere a questo desiderio espresso dai Padri sinodali, ma anche e
ancor più per studiare in modo approfondito i diversi problemi teologici,
liturgici, giuridici e pastorali sollevati dall'attuale grande fioritura
di ministeri affidati ai fedeli laici. In attesa che la Commissione concluda il suo studio, perché la
prassi ecclesiale dei ministeri affidati ai fedeli laici risulti ordinata
e fruttuosa, dovranno essere fedelmente rispettati da tutte le Chiese
particolari i principi teologici sopra ricordati, in particolare la
diversità essenziale tra il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio
comune e, conseguentemente, la diversità tra i ministeri derivanti dal
sacramento dell'Ordine e i ministeri derivanti dai sacramenti del
Battesimo e della Confermazione. I carismi 24. Lo Spirito Santo, mentre affida alla Chiesa-Comunione i
diversi ministeri, l'arricchisce di altri particolari doni e impulsi,
chiamati carismi. Possono assumere le forme più diverse, sia come
espressione dell'assoluta libertà dello Spirito che li elargisce, sia
come risposta alle esigenze molteplici della storia della Chiesa. La
descrizione e la classificazione che di questi doni fanno i testi del
Nuovo Testamento sono un segno della loro grande varietà: «E a ciascuno
è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità
comune: a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a
un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza;
a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far
guarigioni per mezzo dell'unico Spirito; a uno il potere dei miracoli, a
un altro il dono della profezia; a un altro il dono di distinguere gli
spiriti; a un altro le varietà delle lingue; a un altro infine
l'interpretazione delle lingue» (1 Cor 12, 7-10; cf. 1 Cor
12, 4-6. 28-31; Rom 12, 6-8; 1 Pt 4, 10-11). Straordinari o semplici e umili, i carismi sono grazie dello
Spirito Santo che hanno, direttamente o indirettamente, un'utilità
ecclesiale, ordinati come sono all'edificazione della Chiesa, al bene
degli uomini e alle necessità del mondo. Anche ai nostri tempi non manca la fioritura di diversi carismi
tra i fedeli laici, uomini e donne. Sono dati alla persona singola, ma
possono anche essere condivisi da altri e in tal modo vengono continuati
nel tempo come una preziosa e viva eredità, che genera una particolare
affinità spirituale tra le persone. Proprio in riferimento all'apostolato
dei laici il Concilio Vaticano II scrive: «Per l'esercizio di tale
apostolato lo Spirito Santo, che opera la santificazione del Popolo di Dio
per mezzo del ministero e dei sacramenti, elargisce ai fedeli anche dei
doni particolari (cf. 1 Cor 12, 7), "distribuendoli a
ciascuno come vuole" (1 Cor 12, 11), affinché,
"mettendo ciascuno a servizio degli altri la grazia ricevuta",
contribuiscano anch'essi, "come buoni dispensatori delle diverse
grazie ricevute da Dio" (1 Pt 4, 10), alla edificazione di
tutto il corpo nella carità (cf. Ef 4, 16)»(79). Nella logica dell'originaria donazione da cui sono scaturiti, i
doni dello Spirito esigono che quanti li hanno ricevuti li esercitino per
la crescita di tutta la Chiesa, come ci ricorda il Concilio(80). I carismi vanno accolti con gratitudine: da parte di chi li
riceve, ma anche da parte di tutti nella Chiesa. Sono, infatti, una
singolare ricchezza di grazia per la vitalità apostolica e per la santità
dell'intero Corpo di Cristo: purché siano doni che derivino veramente
dallo Spirito e vengano esercitati in piena conformità agli impulsi
autentici dello Spirito. In tal senso si rende sempre necessario il discernimento
dei carismi. In realtà, come hanno detto i Padri sinodali, «l'azione
dello Spirito Santo, che soffia dove vuole, non è sempre facile da
riconoscere e da accogliere. Sappiamo che Dio agisce in tutti i fedeli
cristiani e siamo coscienti dei benefici che vengono dai carismi sia per i
singoli sia per tutta la comunità cristiana. Tuttavia, siamo anche
coscienti della potenza del peccato e dei suoi sforzi per turbare e per
confondere la vita dei fedeli e della comunità»(81). Per questo nessun carisma dispensa dal riferimento e dalla
sottomissione ai Pastori della Chiesa. Con chiare parole il
Concilio scrive: «Il giudizio sulla loro (dei carismi) genuinità e sul
loro esercizio ordinato appartiene a quelli che presiedono nella Chiesa,
ai quali spetta specialmente, non di estinguere lo Spirito, ma di
esaminare tutto e ritenere ciò che è buono (cf. 1 Tess 5, 12 e
19-21)»(82), affinché tutti i carismi cooperino, nella loro diversità e
complementarietà, al bene comune(83). La pertecipazione dei fedeli laici alla vita della Chiesa 25. I fedeli laici partecipano alla vita della Chiesa non solo
mettendo in opera i loro compiti e carismi, ma anche in molti altri modi. Tale partecipazione trova la sua prima e necessaria espressione
nella vita e missione delle Chiese particolari, delle diocesi,
nelle quali «è veramente presente e agisce la Chiesa di Cristo, una,
santa, cattolica e apostolica»(84). Chiese particolari e Chiesa universale Per un'adeguata partecipazione alla vita ecclesiale è del tutto
urgente che i fedeli laici abbiano una visione chiara e precisa della Chiesa
particolare nel suo originale legame con la Chiesa universale. La
Chiesa particolare non nasce da una specie di frammentazione della Chiesa
universale, né la Chiesa universale viene costituita dalla semplice somma
delle Chiese particolari; ma un vivo, essenziale e costante vincolo le
unisce tra loro, in quanto la Chiesa universale esiste e si manifesta
nelle Chiese particolari. Per questo il Concilio dice che le Chiese
particolari sono «formate a immagine della Chiesa universale, nelle quali
e a partire dalle quali esiste la sola e unica Chiesa cattolica»(85). Lo stesso Concilio stimola con forza i fedeli laici a vivere
operosamente la loro appartenenza alla Chiesa particolare, assumendo nello
stesso tempo un respiro sempre più «cattolico»: «Coltivino
costantemente _ leggiamo nel Decreto sull'apostolato dei laici _ il senso
della diocesi, di cui la parrocchia è come una cellula, sempre pronti,
all'invito del loro Pastore, ad unire anche le proprie forze alle
iniziative diocesane. Anzi, per venire incontro alle necessità delle città
e delle zone rurali, non limitino la loro propria cooperazione entro i
confini della parrocchia o della diocesi, ma procurino di allargarla
all'ambito interparrocchiale, interdiocesano, nazionale o internazionale,
tanto più che il crescente spostamento delle popolazioni, lo sviluppo
delle mutue relazioni e la facilità delle comunicazioni non consentono più
ad alcuna parte della società di rimanere chiusa in se stessa. Così
abbiano a cuore le necessità del Popolo di Dio sparso su tutta la terra»(86). Il recente Sinodo ha chiesto, in tal senso, che si favorisca la
creazione dei Cansigli Pastorali diocesani, ai quali ricorrere
secondo le opportunità. Si tratta, in realtà, della principale forma di
collaborazione e di dialogo, come pure di discernimento, a livello
diocesano. La partecipazione dei fedeli laici a questi Consigli potrà
ampliare il ricorso alla consultazione e il principio della collaborazione
_ che in certi casi è anche di decisione _ verrà applicato in un modo più
esteso e forte(87). La partecipazione dei fedeli laici nei Sinodi diocesani e
nei Concili particolari, provinciali o plenari, è prevista dal
Codice di Diritto Canonico(88); essa potrà contribuire alla comunione e
alla missione ecclesiale della Chiesa particolare, sia nel suo proprio
ambito sia in relazione con le altre Chiese particolari della provincia
ecclesiastica o della Conferenza Episcopale. Le Conferenze Episcopali sono chiamate a valutare il modo più
opportuno di sviluppare, a livello nazionale o regionale, la consultazione
e la collaborazione dei fedeli laici, uomini e donne: si potranno così
soppesare bene i problemi comuni e meglio si manifesterà la comunione
ecclesiale di tutti(89). La parrocchia 26. La comunione ecclesiale, pur avendo sempre una dimensione
universale, trova la sua espressione più immediata e visibile nella parrocchia:
essa è l'ultima localizzazione della Chiesa, è in un certo senso la
Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle
sue figlie(90). E' necessario che tutti riscopriamo, nella fede, il vero volto
della parrocchia, ossia il «mistero» stesso della Chiesa presente e
operante in essa: anche se a volte povera di persone e di mezzi, anche se
altre volte dispersa su territori quanto mai vasti o quasi introvabile
all'interno di popolosi e caotici quartieri moderni, la parrocchia non è
principalmente una struttura, un territorio, un edificio; è piuttosto «la
famiglia di Dio, come una fraternità animata dallo spirito d'unità»(91),
è «una casa di famiglia, fraterna ed accogliente»(92), è la «comunità
di fedeli»(93). In definitiva, la parrocchia è fondata su di una realtà
teologica, perché essa è unacomunità eucaristica(94). Ciò
significa che essa è una comunità idonea a celebrare l'Eucaristia, nella
quale stanno la radice viva del suo edificarsi e il vincolo sacramentale
del suo essere in piena comunione con tutta la Chiesa. Tale idoneità si
radica nel fatto che la parrocchia è una comunità di fede e una
comunità organica, ossia costituita dai ministri ordinati e
dagli altri cristiani, nella quale il parroco _ che rappresenta il Vescovo
diocesano(95) _ è il vincolo gerarchico con tutta la Chiesa particolare. E' certamente immane il compito della Chiesa ai nostri giorni e ad
assolverlo non può certo bastare la parrocchia da sola. Per questo il
Codice di Diritto Canonico prevede forme di collaborazione tra parrocchie
nell'ambito del territorio(96) e raccomanda al Vescovo la cura di tutte le
categorie di fedeli, anche di quelle che non sono raggiunte dalla cura
pastorale ordinaria(97). Infatti, molti luoghi e forme di presenza e di
azione sono necessari per recare la parola e la grazia del Vangelo nelle
svariate condizioni di vita degli uomini d'oggi, e molte altre funzioni di
irradiazione religiosa e d'apostolato d'ambiente, nel campo culturale,
sociale, educativo, professionale, ecc., non possono avere come centro o
punto di partenza la parrocchia. Eppure anche oggi la parrocchia vive una
nuova e promettente stagione. Come diceva Paolo VI, all'inizio del suo
pontificato, rivolgendosi al Clero romano: «Crediamo semplicemente che
questa antica e venerata struttura della parrocchia ha una missione
indispensabile e di grande attualità; ad essa spetta creare la prima
comunità del popolo cristiano; ad essa iniziare e raccogliere il popolo
nella normale espressione della vita liturgica; ad essa conservare e
ravvivare la fede nella gente d'oggi; ad essa fornirle la scuola della
dottrina salvatrice di Cristo; ad essa praticare nel sentimento e
nell'opera l'umile carità delle opere buone e fraterne»(98). I Padri sinodali, dal canto loro, hanno attentamente considerato
l'attuale situazione di molte parrocchie, sollecitando un loro più
deciso rinnovamento : «Molte parrocchie, sia in regioni urbanizzate
sia in territorio missionario, non possono funzionare con pienezza
effettiva per la mancanza di mezzi materiali o di uomini ordinati, o anche
per l'eccessiva estensione geografica e per la speciale condizione di
alcuni cristiani (come, per esempio, gli esuli e gli emigranti). Perché
tutte queste parrocchie siano veramente comunità cristiane, le autorità
locali devono favorire: a) l'adattamento delle strutture
parrocchiali con la flessibilità ampia concessa dal Diritto Canonico,
soprattutto promuovendo la partecipazione dei laici alle responsabilità
pastorali; b) le piccole comunità ecclesiali di base, dette anche
comunità vive, dove i fedeli possano comunicarsi a vicenda la Parola di
Dio ed esprimersi nel servizio e nell'amore; queste comunità sono vere
espressioni della comunione ecclesiale e centri di evangelizzazione, in
comunione con i loro Pastori»(99). Per il rinnovamento delle parrocchie e
per meglio assicurare la loro efficacia operativa si devono favorire forme
anche istituzionali di cooperazione tra le diverse parrocchie di un
medesimo territorio. L'impegno apostolico nella parrocchia 27. E' necessario ora considerare più da vicino la comunione e la
partecipazione dei fedeli laici alla vita della parrocchia. In tal senso
è da richiamarsi l'attenzione di tutti i fedeli laici, uomini e donne, su
di una parola tanto vera, significativa e stimolante del Concilio: «All'interno
delle comunità della Chiesa _ leggiamo nel Decreto sull'apostolato dei
laici _ la loro azione è talmente necessaria che senza di essa lo stesso
apostolato dei pastori non può per lo più raggiungere la sua piena
efficacia»(100). E', questa, un'affermazione radicale, che dev'essere
evidentemente intesa nella luce della «ecclesiologia di comunione»:
essendo diversi e complementari, i ministeri e i carismi sono tutti
necessari alla crescita della Chiesa, ciascuno secondo la propria modalità. I fedeli laici devono essere sempre più convinti del particolare
significato che assume l'impegno apostolico nella loro parrocchia. E'
ancora il Concilio a rilevarlo autorevolmente: «La parrocchia offre un
luminoso esempio di apostolato comunitario, fondendo insieme tutte le
differenze umane che vi si trovano e inserendole nell'universalità della
Chiesa. Si abituino i laici a lavorare nella parrocchia intimamente uniti
ai loro sacerdoti, ad esporre alla comunità della Chiesa i propri
problemi e quelli del mondo e le questioni che riguardano la salvezza
degli uomini, perché siano esaminati e risolti con il concorso di tutti;
a dare, secondo le proprie possibilità, il loro contributo ad ogni
iniziativa apostolica e missionaria della propria famiglia ecclesiastica»(101). L'accenno conciliare all'esame e alla risoluzione dei problemi
pastorali «con il concorso di tutti» deve trovare il suo adeguato e
strutturato sviluppo nella valorizzazione più convinta, ampia e decisa
dei Consigli pastorali parrocchiali, sui quali hanno giustamente
insistito i Padri sinodali(102). Nelle circostanze attuali i fedeli laici possono e devono fare
moltissimo per la crescita di un'autentica comunione ecclesiale all'interno
delle loro parrocchie e per ridestare lo slancio missionario verso
i non credenti e verso gli stessi credenti che hanno abbandonato o
affievolito la pratica della vita cristiana. Se la parrocchia è la Chiesa posta in mezzo alle case degli
uomini, essa vive e opera profondamente inserita nella società umana e
intimamente solidale con le sue aspirazioni e i suoi drammi. Spesso il
contesto sociale, soprattutto in certi paesi e ambienti, è violentemente
scosso da forze di disgregazione e di disumanizzazione: l'uomo è smarrito
e disorientato, ma nel cuore gli rimane sempre più il desiderio di poter
sperimentare e coltivare rapporti più fraterni e più umani La risposta a
tale desiderio può venire dalla parrocchia, quando questa, con la viva
partecipazione dei fedeli laici, rimane coerente alla sua originaria
vocazione e missione: essere nel mondo «luogo» della comunione dei
credenti e insieme «segno» e «strumento» della vocazione di tutti alla
comunione; in una parola, essere la casa aperta a tutti e al servizio di
tutti o, come amava dire il Papa Giovanni XXIII, la fontana del
villaggio alla quale tutti ricorrono per la loro sete. Forme di partecipazione nella vita della Chiesa 28. I fedeli laici, unitamente ai sacerdoti, ai religiosi e alle
religiose, formano l'unico Popolo di Dio e Corpo di Cristo. L'essere «membri» della Chiesa nulla toglie al fatto che ciascun
cristiano sia un essere «unico e irripetibile», bensì garantisce e
promuove il senso più profondo della sua unicità e irripetibilità, in
quanto fonte di varietà e di ricchezza per l'intera Chiesa. In tal senso
Dio in Gesù Cristo chiama ciascuno col proprio inconfondibile nome.
L'appello del Signore: «Andate anche voi nella mia vigna» si rivolge a
ciascuno personalmente e suona: «Vieni anche tu nella mia vigna!». Così ciascuno nella sua unicità e irripetibilità, con il suo
essere e con il suo agire, si pone al servizio della crescita della
comunione ecclesiale, come peraltro singolarmente riceve e fa sua la
comune ricchezza di tutta la Chiesa. E' questa la «Comunione dei Santi»,
da noi professata nel Credo: il bene di tutti diventa il bene di
ciascuno e il bene di ciascuno diventa il bene di tutti. «Nella santa
Chiesa _ scrive San Gregorio Magno _ ognuno è sostegno degli altri e gli
altri sono suo sostegno»(103). Forme personali di partecipazione E' del tutto necessario che ciascun fedele laico abbia sempre viva
coscienza di essere un «membro della Chiesa», al quale è
affidato un compito originale insostituibile e indelegabile, da svolgere
per il bene di tutti. In una simile prospettiva assume tutto il suo
significato l'affermazione conciliare circa l'assoluta necessità
dell'apostolato della singola persona: «L'apostolato che i singoli
devono svolgere, sgorgando abbondantemente dalla fonte di una vita
veramente cristiana (cf. Gv 4, 14), è la prima forma e la
condizione di ogni apostolato dei laici, anche di quello associato, ed è
insostituibile. A tale apostolato, sempre e dovunque proficuo, ma in certe
circostanze l'unico adatto e possibile, sono chiamati e obbligati tutti i
laici, di qualsiasi condizione, anche se manca loro l'occasione o la
possibilità di collaborare nelle associazioni»(104). Nell'apostolato personale ci sono grandi ricchezze che chiedono di
essere scoperte per un'intensificazione del dinamismo missionario di
ciascun fedele laico. Con tale forma di apostolato, l'irradiazione del
Vangelo può farsi quanto mai capillare, giungendo a tanti luoghi e
ambienti quanti sono quelli legati alla vita quotidiana e concreta dei
laici. Si tratta, inoltre, di un'irradiazione costante, essendo
legata alla continua coerenza della vita personale con la fede; come pure
di un'irradiazione particolarmente incisiva, perché, nella piena
condivisione delle condizioni di vita, del lavoro, delle difficoltà e
speranze dei fratelli, i fedeli laici possono giungere al cuore dei loro
vicini o amici o colleghi, aprendolo all'orizzonte totale, al senso pieno
dell'esistenza: la comunione con Dio e tra gli uomini. Forme aggregative di partecipazione 29. La comunione ecclesiale, già presente e operante nell'azione
della singola persona, trova una sua specifica espressione nell'operare
associato dei fedeli laici, ossia nell'azione solidale da essi svolta nel
partecipare responsabilmente alla vita e alla missione della Chiesa. In questi ultimi tempi il fenomeno dell'aggregarsi dei laici tra
loro è venuto ad assumere caratteri di particolare varietà e vivacità.
Se sempre nella storia della Chiesa l'aggregarsi dei fedeli ha
rappresentato in qualche modo una linea costante, come testimoniano sino
ad oggi le varie confraternite, i terzi ordini e i diversi sodalizi, esso
ha però ricevuto uno speciale impulso nei tempi moderni, che hanno visto
il nascere e il diffondersi di molteplici forme aggregative: associazioni,
gruppi, comunità, movimenti. Possiamo parlare di una nuova stagione
aggregativa dei fedeli laici. Infatti, «accanto all'associazionismo
tradizionale, e talvolta alle sue stesse radici, sono germogliati
movimenti e sodalizi nuovi, con fisionomia e finalità specifiche: tanta
è la ricchezza e la versatilità delle risorse che lo Spirito alimenta
nel tessuto ecclesiale, e tanta è pure la capacità d'iniziativa e la
generosità del nostro laicato»(105). Queste aggregazioni di laici si presentano spesso assai diverse
le une dalle altre in vari aspetti, come la configurazione esteriore,
i cammini e metodi educativi, e i campi operativi. Trovano però le linee
di un'ampia e profonda convergenza nella finalità che le anima:
quella di partecipare responsabilmente alla missione della Chiesa di
portare il Vangelo di Cristo come fonte di speranza per l'uomo e di
rinnovamento per la società. L'aggregarsi dei fedeli laici per motivi spirituali e apostolici
scaturisce da più fonti e corrisponde ad esigenze diverse: esprime,
infatti, la natura sociale della persona e obbedisce all'istanza di una più
vasta ed incisiva efficacia operativa. In realtà, l'incidenza «culturale»,
sorgente e stimolo ma anche frutto e segno di ogni altra trasformazione
dell'ambiente e della società, può realizzarsi solo con l'opera non
tanto dei singoli quanto di un «soggetto sociale», ossia di un gruppo,
di una comunità, di un'associazione, di un movimento. Ciò è
particolarmente vero nel contesto della società pluralistica e frantumata
_ com'è quella attuale in tante parti del mondo _ e di fronte a problemi
divenuti enormemente complessi e difficili. D'altra parte, soprattutto in
un mondo secolarizzato, le varie forme aggregative possono rappresentare
per tanti un aiuto prezioso per una vita cristiana coerente alle esigenze
del Vangelo e per un impegno missionario e apostolico. Al di là di questi motivi, la ragione profonda che giustifica ed
esige l'aggregarsi dei fedeli laici è di ordine teologico: è una ragione
ecclesiologica, come apertamente riconosce il Concilio Vaticano II che
indica nell'apostolato associato un «segno della comunione e dell'unità
della Chiesa in Cristo»(106). E' un «segno» che deve manifestarsi nei rapporti di «comunione»
sia all'interno che all'esterno delle varie forme aggregative nel più
ampio contesto della comunità cristiana. Proprio la ragione
ecclesiologica indicata spiega, da un lato il «diritto» di aggregazione
proprio dei fedeli laici, dall'altro lato la necessità di «criteri» di
discernimento circa l'autenticità ecclesiale delle loro forme aggregative. E' anzitutto da riconoscersi la libertà associativa dei fedeli
laici nella Chiesa. Tale libertà è un vero e proprio diritto che non
deriva da una specie di «concessione» dell'autorità, ma che scaturisce
dal Battesimo, quale sacramento che chiama i fedeli laici a partecipare
attivamente alla comunione e alla missione della Chiesa. Al riguardo è
del tutto chiaro il Concilio: «Salva la dovuta relazione con l'autorità
ecclesiastica, i laici hanno il diritto di creare e guidare associazioni e
dare nome a quelle fondate»(107). E il recente Codice testualmente
afferma: «I fedeli hanno il diritto di fondare e di dirigere liberamente
associazioni che si propongano un fine di carità o di pietà, oppure
associazioni che si propongano l'incremento della vocazione cristiana nel
mondo; hanno anche il diritto di tenere riunioni per il raggiungimento
comune di tali finalità»(108). Si tratta di una libertà riconosciuta e garantita dall'autorità
ecclesiastica e che dev'essere esercitata sempre e solo nella comunione
della Chiesa: in tal senso il diritto dei fedeli laici ad aggregarsi è
essenzialmente relativo alla vita di comunione e alla missione della
Chiesa stessa. Criteri di ecclesialità per le aggregazioni laicali 30. E' sempre nella prospettiva della comunione e della missione
della Chiesa, e dunque non in contrasto con la libertà associativa, che
si comprende la necessità di criteri chiari e precisi di discernimento
e di riconoscimento delle aggregazioni laicali, detti anche «criteri
di ecclesialità». Come criteri fondamentali per il discernimento di ogni e qualsiasi
aggregazione dei fedeli laici nella Chiesa si possono considerare, in modo
unitario, i seguenti: -Il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità,
manifestata «nei frutti della grazia che lo Spirito produce nei
fedeli»(109) come crescita verso la pienezza della vita cristiana e la
perfezione della carità(110). In tal senso ogni e qualsiasi aggregazione
di fedeli laici è chiamata ad essere sempre più strumento di santità
nella Chiesa, favorendo e incoraggiando «una più intima unità tra la
vita pratica dei membri e la loro fede»(111). -La responsabilità di confessare la fede cattolica, accogliendo
e proclamando la verità su Cristo, sulla Chiesa e sull'uomo in obbedienza
al Magistero della Chiesa, che autenticamente la interpreta. Per questo
ogni aggregazione di fedeli laici dev'essere luogo di annuncio e di
proposta della fede e di educazione ad essa nel suo integrale contenuto. -La testimonianza di una comunione salda e convinta, in
relazione filiale con il Papa, perpetuo e visibile centro dell'unità
della Chiesa universale(112), e con il Vescovo «principio visibile e
fondamento dell'unità»(113) della Chiesa particolare, e nella «stima
vicendevole fra tutte le forme di apostolato nella Chiesa»(114). La comunione con il Papa e con il Vescovo è chiamata ad
esprimersi nella leale disponibilità ad accogliere i loro insegnamenti
dottrinali e orientamenti pastorali. La comunione ecclesiale esige,
inoltre, il riconoscimento della legittima pluralità delle forme
aggregative dei fedeli laici nella Chiesa e, nello stesso tempo, la
disponibilità alla loro reciproca collaborazione. - La conformità e la partecipazione al fine apostolico della
Chiesa, ossia «l'evangelizzazione e la santificazione degli uomini e
la formazione cristiana della loro coscienza, in modo che riescano a
permeare di spirito evangelico le varie comunità e i vari ambienti»(115). In questa prospettiva, da tutte le forme aggregative di fedeli
laici, e da ciascuna di esse, è richiesto uno slancio missionario che le
renda sempre più soggetti di una nuova evangelizzazione. - L'impegno di una presenza nella società umana che, alla
luce della dottrina sociale della Chiesa, si ponga a servizio della dignità
integrale dell'uomo. In tal senso le aggregazioni dei fedeli laici devono diventare
correnti vive di partecipazione e di solidarietà per costruire condizioni
più giuste e fraterne all'interno della società. I criteri fondamentali ora esposti trovano la loro verifica nei frutti
concreti che accompagnano la vita e le opere delle diverse forme
associative quali: il gusto rinnovato per la preghiera, la contemplazione,
la vita liturgica e sacramentale; l'animazione per il fiorire di vocazioni
al matrimonio cristiano, al sacerdozio ministeriale, alla vita consacrata;
la disponibilità a partecipare ai programmi e alle attività della Chiesa
a livello sia locale sia nazionale o internazionale; l'impegno catechetico
e la capacità pedagogica nel formare i cristiani; l'impulso a una
presenza cristiana nei diversi ambienti della vita sociale e la creazione
e animazione di opere caritative, culturali e spirituali; lo spirito di
distacco e di povertà evangelica per una più generosa carità verso
tutti; la conversione alla vita cristiana o il ritorno alla comunione di
battezzati «lontani». Il servizio dei Pastori per la comunione 31. I Pastori nella Chiesa, sia pure di fronte a possibili e
comprensibili difficoltà di alcune forme aggregative e all'imporsi di
nuove forme, non possono rinunciare al servizio della loro autorità, non
solo per il bene della Chiesa, ma anche per il bene delle stesse
aggregazioni laicali. In tal senso devono accompagnare l'opera di
discernimento con la guida e soprattutto con l'incoraggiamento per una
crescita delle aggregazioni dei fedeli laici nella comunione e nella
missione della Chiesa. E' oltremodo opportuno che alcune nuove associazioni e alcuni
nuovi movimenti, per la loro diffusione spesso nazionale o anche
internazionale, abbiano a ricevere un riconoscimento ufficiale, un'approvazione
esplicita della competente autorità ecclesiastica. In questo senso già
il Concilio affermava: «L'apostolato dei laici ammette certo vari tipi di
rapporti con la Gerarchia secondo le diverse forme e oggetti
dell'apostolato stesso (...). Alcune forme di apostolato dei laici vengono
in vari modi esplicitamente riconosciute dalla Gerarchia. L'autorità
ecclesiastica, per le esigenze del bene comune della Chiesa, fra le
associazioni e iniziative apostoliche aventi un fine immediatamente
spirituale, può inoltre sceglierne in modo particolare e promuoverne
alcune per le quali assume una speciale responsabilità»(116). Tra le diverse forme apostoliche dei laici che hanno un
particolare rapporto con la Gerarchia i Padri sinodali hanno
esplicitamente ricordato vari movimenti e associazioni di Azione
Cattolica, in cui «i laici si associano liberamente in forma organica
e stabile, sotto la spinta dello Spirito Santo, nella comunione con il
Vescovo e con i sacerdoti, per poter servire, nel modo proprio della loro
vocazione, con un particolare metodo, all'incremento di tutta la comunità
cristiana, ai progetti pastorali e all'animazione evangelica di tutti gli
ambiti della vita, con fedeltà e operosità»(117). Il Pontificio Consiglio per i Laici è incaricato di preparare un
elenco delle associazioni che ricevono l'approvazione ufficiale della
Santa Sede e di definire, insieme al Segretariato per l'Unione dei
Cristiani, le condizioni in base alle quali può essere approvata
un'associazione ecumenica in cui la maggioranza sia cattolica e una
minoranza non cattolica, stabilendo anche in quali casi non si può dare
un giudizio positivo(118). Tutti, Pastori e fedeli, siamo obbligati a favorire e ad
alimentare di continuo vincoli e rapporti fraterni di stima, di cordialità,
di collaborazione tra le varie forme aggregative di laici. Solo così la
ricchezza dei doni e dei carismi che il Signore ci offre può portare il
suo fecondo e ordinato contributo all'edificazione della casa comune: «Per
la solidale edificazione della casa comune è necessario, inoltre, che sia
deposto ogni spirito di antagonismo e di contesa, e che si gareggi
piuttosto nello stimarsi a vicenda (cf. Rom 12, 10), nel prevenirsi
reciprocamente nell'affetto e nella volontà di collaborazione, con la
pazienza, la lungimiranza, la disponibilità al sacrificio che ciò potrà
talvolta comportare»(119). Ritorniamo ancora una volta alle parole di Gesù: «Io sono la
vite, voi i tralci» (Gv 15, 5), per rendere grazie a Dio del
grande dono della comunione ecclesiale, riflesso nel tempo
dell'eterna e ineffabile comunione d'amore di Dio Uno e Trino. La
coscienza del dono si deve accompagnare ad un forte senso di responsabilità:
è, infatti, un dono che, come il talento evangelico, esige d'essere
trafficato in una vita di crescente comunione. Essere responsabili del dono della comunione significa, anzitutto,
essere impegnati a vincere ogni tentazione di divisione e di
contrapposizione, che insidia la vita e l'impegno apostolico dei
cristiani. Il grido di dolore e di sconcerto dell'apostolo Paolo: «Mi
riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: "Io sono di Paolo",
"Io invece sono di Apollo", "E io di Cefa", "E io
di Cristo!". Cristo è stato forse diviso?» (1 Cor 1, 12-13 )
continua a suonare come rimprovero per le «lacerazioni del Corpo di
Cristo». Risuonino, invece, come appello persuasivo queste altre parole
dell'apostolo: «Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù
Cristo, ad essere unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra
voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e d'intenti» (1 Cor
1, 10). Così la vita di comunione ecclesiale diventa un segno per
il mondo e una forza attrattiva che conduce a credere in Cristo: «Come
tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola,
perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17, 21). In tal
modo la comunione si apre alla missione, si fa essa stessa
missione. |
|
|
CAPITOLO III VI HO COSTITUITI PERCHÉ
ANDIATE E PORTIATE FRUTTO Comunione missionaria 32. Riprendiamo l'immagine biblica della vite e dei tralci. Essa
ci apre, in modo immediato e naturale, alla considerazione della fecondità
e della vita. Radicati e vivificati dalla vite, i tralci sono chiamati a
portare frutto: «Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io
in lui fa molto frutto» (Gv 15, 5). Portare frutto è un'esigenza
essenziale della vita cristiana ed ecclesiale. Chi non porta frutto non
rimane nella comunione: «Ogni tralcio che in me non porta frutto, (il
Padre mio) lo toglie» (Gv 15, 2). La comunione con Gesù, dalla quale deriva la comunione dei
cristiani tra loro, è condizione assolutamente indispensabile per portare
frutto: «Senza di me non potete far nulla» (Gv 15, 5). E la
comunione con gli altri è il frutto più bello che i tralci possono dare:
essa, infatti, è dono di Cristo e del suo Spirito. Ora la comunione genera comunione, e si configura
essenzialmente come comunione missionaria. Gesù, infatti, dice ai
suoi discepoli: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto
rimanga» (Gv 15, 16). La comunione e la missione sono profondamente congiunte tra loro,
si compenetrano e si implicano mutuamente, al punto che la comunione
rappresenta la sorgente e insieme il frutto della missione: la comunione
è missionaria e la missione è per la comunione. E' sempre l'unico e
identico Spirito colui che convoca e unisce la Chiesa e colui che la manda
a predicare il Vangelo «fino agli estremi confini della terra» (At
1, 8). Da parte sua, la Chiesa sa che la comunione, ricevuta in dono, ha
una destinazione universale. Così la Chiesa si sente debitrice all'umanità
intera e a ciascun uomo del dono ricevuto dallo Spirito che effonde nei
cuori dei credenti la carità di Gesù Cristo, prodigiosa forza di
coesione interna ed insieme di espansione esterna. La missione della
Chiesa deriva dalla sua stessa natura, così come Cristo l'ha voluta:
quella di «segno e strumento (...) di unità di tutto il genere umano»(120).
Tale missione ha lo scopo di far conoscere e di far vivere a tutti la «nuova»
comunione che nel Figlio di Dio fatto uomo è entrata nella storia del
mondo. In tal senso la testimonianza dell'evangelista Giovanni definisce
oramai in modo irrevocabile il termine beatificante al quale punta
l'intera missione della Chiesa: «Quello che abbiamo veduto e udito, noi
lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi.
La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo» (1 Gv
1, 3). Ora nel contesto della missione della Chiesa il Signore affida
ai fedeli laici, in comunione con tutti gli altri membri del Popolo di
Dio, una grande parte di responsabilità. Ne erano pienamente
consapevoli i Padri del Concilio Vaticano II: «I sacri Pastori, infatti,
sanno benissimo quanto contribuiscano i laici al bene di tutta la Chiesa.
Sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutta
la missione della salvezza che la Chiesa ha ricevuto nei confronti del
mondo, ma che il loro magnifico incarico è di pascere i fedeli e di
riconoscere i loro servizi e i loro carismi, in modo che tutti
concordemente cooperino, nella loro misura, all'opera comune»(121). La
loro consapevolezza è ritornata poi, con rinnovata chiarezza e con vigore
accresciuto, in tutti i lavori del Sinodo. Annunciare il Vangelo 33. I fedeli laici, proprio perché membri della Chiesa, hanno la
vocazione e la missione di essere annunciatori del Vangelo: per
quest'opera sono abilitati e impegnati dai sacramenti dell'iniziazione
cristiana e dai doni dello Spirito Santo. Leggiamo in un testo limpido e denso del Concilio Vaticano II: «In
quanto partecipi dell'ufficio di Cristo sacerdote, profeta e re, i laici
hanno la loro parte attiva nella vita e nell'azione della Chiesa (...).
Nutriti dell'attiva partecipazione alla vita liturgica della propria
comunità, partecipano con sollecitudine alle opere apostoliche della
medesima; conducono alla Chiesa gli uomini che forse ne vivono lontani;
cooperano con dedizione nel comunicare la parola di Dio, specialmente
mediante l'insegnamento del catechismo; mettendo a disposizione la loro
competenza rendono più efficace la cura delle anime ed anche
l'amministrazione dei beni della Chiesa»(122). Ora è nell' evangelizzazione che si concentra e si
dispiega l'intera missione della Chiesa, il cui cammino storico si snoda
sotto la grazia e il comando di Gesù Cristo: «Andate in tutto il mondo e
predicate il Vangelo ad ogni creatura» (Mc 16, 15); «Ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28, 20). «Evangelizzare
_ scrive Paolo VI _ è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la
sua identità più profonda»(123). Dall'evangelizzazione la Chiesa viene costruita e plasmata come comunità
di fede: più precisamente, come comunità di una fede confessata nell'adesione
alla Parola di Dio, celebrata nei sacramenti, vissuta nella
carità, quale anima dell'esistenza morale cristiana. Infatti, la «buona
novella» tende a suscitare nel cuore e nella vita dell'uomo la
conversione e l'adesione personale a Gesù Cristo Salvatore e Signore;
dispone al Battesimo e all'Eucaristia e si consolida nel proposito e nella
realizzazione della vita nuova secondo lo Spirito. Certamente l'imperativo di Gesù: «Andate e predicate il Vangelo»
mantiene sempre vivo il suo valore ed è carico di un'urgenza
intramontabile. Tuttavia la situazione attuale, non solo del mondo
ma anche di tante parti della Chiesa, esige assolutamente che la parola
di Cristo riceva un'obbedienza più pronta e generosa. Ogni discepolo
è chiamato in prima persona; nessun discepolo può sottrarsi nel dare la
sua propria risposta: «Guai a me, se non predicassi il Vangelo!» (1
Cor 9, 16). L'ora è venuta per intraprendere una nuova evangelizzazione 34. Interi paesi e nazioni, dove la religione e la vita cristiana
erano un tempo quanto mai fiorenti e capaci di dar origine a comunità di
fede viva e operosa, sono ora messi a dura prova, e talvolta sono persino
radicalmente trasformati, dal continuo diffondersi dell'indifferentismo,
del secolarismo e dell'ateismo. Si tratta, in particolare, dei paesi e
delle nazioni del cosiddetto Primo Mondo, nel quale il benessere economico
e il consumismo, anche se frammisti a paurose situazioni di povertà e di
miseria, ispirano e sostengono una vita vissuta «come se Dio non
esistesse». Ora l'indifferenza religiosa e la totale insignificanza
pratica di Dio per i problemi anche gravi della vita non sono meno
preoccupanti ed eversivi rispetto all'ateismo dichiarato. E anche la fede
cristiana, se pure sopravvive in alcune sue manifestazioni tradizionali e
ritualistiche, tende ad essere sradicata dai momenti più significativi
dell'esistenza, quali sono i momenti del nascere, del soffrire e del
morire. Di qui l'imporsi di interrogativi e di enigmi formidabili che,
rimanendo senza risposta, espongono l'uomo contemporaneo alla delusione
sconsolata o alla tentazione di eliminare la stessa vita umana che quei
problemi pone. In altre regioni o nazioni, invece, si conservano tuttora molto
vive tradizioni di pietà e di religiosità popolare cristiana; ma questo
patrimonio morale e spirituale rischia oggi d'essere disperso sotto
l'impatto di molteplici processi, tra i quali emergono la secolarizzazione
e la diffusione delle sette. Solo una nuova evangelizzazione può
assicurare la crescita di una fede limpida e profonda, capace di fare di
queste tradizioni una forza di autentica libertà. Certamente urge dovunque rifare il tessuto cristiano della società
umana. Ma la condizione è che si rifaccia il tessuto cristiano delle
stesse comunità ecclesiali che vivono in questi paesi e in queste
nazioni. Ora i fedeli laici, in forza della loro partecipazione all'ufficio
profetico di Cristo, sono pienamente coinvolti in questo compito della
Chiesa. Ad essi tocca, in particolare, testimoniare come la fede cristiana
costituisca l'unica risposta pienamente valida, più o meno coscientemente
da tutti percepita e invocata, dei problemi e delle speranze che la vita
pone ad ogni uomo e ad ogni società. Ciò sarà possibile se i fedeli
laici sapranno superare in se stessi la frattura tra il Vangelo e la vita,
ricomponendo nella loro quotidiana attività in famiglia, sul lavoro e
nella società, l'unità d'una vita che nel Vangelo trova ispirazione e
forza per realizzarsi in pienezza. A tutti gli uomini contemporanei ripeto, ancora una volta, il
grido appassionato con il quale ho iniziato il mio servizio pastorale: «Non
abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! Alla Sua
salvatrice potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi economici come
quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non
abbiate paura! Cristo sa "cosa è dentro l'uomo". Solo Lui lo
sa! Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del
suo animo, del suo cuore. Così spesso è in certo del senso della sua
vita su questa terra. E' invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione.
Permettete, quindi _ vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia _
permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha parole di vita, sì!
di vita eterna»(124). Spalancare le porte a Cristo, accoglierlo nello spazio della
propria umanità non è affatto una minaccia per l'uomo, bensì è l'unica
strada da percorrere se si vuole riconoscere l'uomo nell'intera sua verità
ed esaltarlo nei suoi valori. Sarà la sintesi vitale che i fedeli laici sapranno operare tra il
Vangelo e i doveri quotidiani della vita la più splendida e convincente
testimonianza che, non la paura, ma la ricerca e l'adesione a Cristo sono
il fattore determinante perché l'uomo viva e cresca, e perché si
costituiscano nuovi modi di vivere più conformi alla dignità umana. L'uomo è amato da Dio! E' questo il
semplicissimo e sconvolgente annuncio del quale la Chiesa è debitrice
all'uomo. La parola e la vita di ciascun cristiano possono e devono far
risuonare questo annuncio: Dio ti ama, Cristo è venuto per te, per te
Cristo è «Via, Verità, Vita!» (Gv 14, 6). Questa nuova evangelizzazione, rivolta non solo alle singole
persone ma anche ad intere fasce di popolazioni nelle loro varie
situazioni, ambienti e culture, è destinata alla formazione dicomunità
ecclesiali mature, nelle quali cioè la fede sprigioni e realizzi
tutto il suo originario significato di adesione alla persona di Cristo e
al suo Vangelo, di incontro e di comunione sacramentale con Lui, di
esistenza vissuta nella carità e nel servizio. I fedeli laici hanno la loro parte da compiere nella formazione di
simili comunità ecclesiali, non solo con una partecipazione attiva e
responsabile nella vita comunitaria, e pertanto con la loro insostituibile
testimonianza, ma anche con lo slancio e l'azione missionaria verso quanti
ancora non credono o non vivono più la fede ricevuta con il Battesimo. In rapporto alle nuove generazioni un contributo prezioso, quanto
mai necessario, deve essere offerto dai fedeli laici con una sistematica
opera di catechesi. I Padri sinodali hanno accolto con gratitudine il
lavoro dei catechisti, riconoscendo che essi «hanno un compito di grande
peso nell'animazione delle comunità ecclesiali»(125). Certamente i
genitori cristiani sono i primi e insostituibili catechisti dei loro
figli, a ciò abilitati dal sacramento del Matrimonio; nello stesso tempo
però dobbiamo essere tutti coscienti del «diritto» che ogni battezzato
ha di venire istruito, educato, accompagnato nella fede e nella vita
cristiana. Andate in tutto il mondo 35. La Chiesa, mentre avverte e vive l'urgenza attuale di una
nuova evangelizzazione, non può sottrarsi alla missione permanente di
portare il Vangelo a quanti _ e sono milioni e milioni di uomini e di
donne _ ancora non conoscono Cristo Redentore dell'uomo. E' questo
il compito più specificamente missionario che Gesù ha affidato e
quotidianamente riaffida alla sua Chiesa. L'opera dei fedeli laici, che peraltro non è mai mancata in
questo ambito, si rivela oggi sempre più necessaria e preziosa. In realtà,
il comando del Signore «Andate in tutto il mondo» continua a trovare
molti laici generosi, pronti a lasciare il loro ambiente di vita, il loro
lavoro, la loro regione o patria per recarsi, almeno per un determinato
tempo, in zone di missione. Anche coppie di sposi cristiani, a imitazione
di Aquila e Priscilla (cf. At 18; Rom 16, 3 s), vanno
offrendo una confortante testimonianza di amore appassionato a Cristo e
alla Chiesa mediante la loro presenza operosa nelle terre di missione.
Autentica presenza missionaria è anche quella di coloro che, vivendo per
vari motivi in paesi o ambienti dove la Chiesa non è ancora stabilita,
testimoniano la loro fede. Ma il problema missionario si presenta attualmente alla Chiesa con
un'ampiezza e con una gravità tali che solo un'assunzione veramente
solidale di responsabilità da parte di tutti i membri della Chiesa, sia
come singoli sia come comunità, può far sperare in una risposta più
efficace. L'invito che il Concilio Vaticano II ha rivolto alle Chiese
particolari conserva tutto il suo valore, anzi esige oggi un'accoglienza
più generalizzata e più decisa: «La Chiesa particolare, dovendo
rappresentare nel modo più perfetto la Chiesa universale, abbia la piena
coscienza di essere inviata anche a coloro che non credono in Cristo»(126). La Chiesa deve fare oggi un grande passo in avanti nella
sua evangelizzazione, deve entrare in una nuova tappa storica del
suo dinamismo missionario. In un mondo che con il crollare delle distanze
si fa sempre più piccolo, le comunità ecclesiali devono collegarsi tra
loro, scambiarsi energie e mezzi, impegnarsi insieme nell'unica e comune
missione di annunciare e di vivere il Vangelo. «Le Chiese cosiddette più
giovani _ hanno detto i Padri sinodali _ abbisognano della forza di quelle
antiche, mentre queste hanno bisogno della testimonianza e della spinta
delle più giovani, in modo che le singole Chiese attingano dalle
ricchezze delle altre Chiese»(127). In questa nuova tappa, la formazione non solo del clero locale ma
anche di un laicato maturo e responsabile si pone nelle giovani Chiese
come elemento essenziale e irrinunciabile della plantatio Ecclesiae(128).
In tal modo le stesse comunità evangelizzate si slanciano verso nuove
contrade del mondo per rispondere anch'esse alla missione di annunciare e
testimoniare il Vangelo di Cristo. I fedeli laici, con l'esempio della loro vita e con la propria
azione, possono favorire il miglioramento dei rapporti tra i seguaci delle
diverse religioni, come hanno opportunamente rilevato i Padri
sinodali: «Oggi la Chiesa vive dappertutto in mezzo a uomini di religioni
diverse (...). Tutti i fedeli, specialmente i laici che vivono in mezzo ai
popoli di altre religioni, sia nelle regioni di origine, sia in terre di
emigrazione, debbono essere per costoro un segno del Signore e della sua
Chiesa, in modo adatto alle circostanze di vita di ciascun luogo. Il
dialogo tra le religioni ha un'importanza preminente perché conduce
all'amore e al rispetto reciproco, elimina, o almeno diminuisce, i
pregiudizi tra i seguaci delle diverse religioni e promuove l'unità e
l'amicizia tra i popoli»(129). Per l'evangelizzazione del mondo occorrono, anzitutto, gli evangelizzatori.
Per questo tutti, a cominciare dalle famiglie cristiane, dobbiamo
sentire la responsabilità di favorire il sorgere e il maturare di vocazioni
specificamente missionarie, sia sacerdotali e religiose sia laicali,
ricorrendo ad ogni mezzo opportuno, senza mai trascurare il mezzo
privilegiato della preghiera, secondo la parola stessa del Signore Gesù:
«La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il padrone
della messe che mandi operai nella sua messe!» (Mt 9, 37-38). Vivere il Vangelo servendo la persona e la società 36. Accogliendo e annunciando il Vangelo nella forza dello Spirito
la Chiesa diviene comunità evangelizzata ed evangelizzante e proprio per
questo si fa serva degli uomini. In essa i fedeli laici partecipano
alla missione di servire la persona e la società. Certamente la Chiesa ha
come supremo fine il Regno di Dio, del quale «costituisce in terra il
germe e l'inizio»(130), ed è quindi totalmente consacrata alla
glorificazione del Padre. Ma il Regno è fonte di liberazione piena e di
salvezza totale per gli uomini: con questi, allora, la Chiesa cammina e
vive, realmente e intimamente solidale con la loro storia. Avendo ricevuto l'incarico di manifestare al mondo il mistero di
Dio che splende in Cristo Gesù, al tempo stesso la Chiesa svela l'uomo
all'uomo, gli fa noto il senso della sua esistenza, lo apre alla verità
intera su di sé e sul suo destino(131). In questa prospettiva la Chiesa
è chiamata, in forza della sua stessa missione evangelizatrice, a servire
l'uomo. Tale servizio si radica primariamente nel fatto prodigioso e
sconvolgente che «con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in
certo modo a ogni uomo»(132). Per questo l'uomo «è la prima strada che la Chiesa deve
percorrere nel compimento della sua missione: egli è la prima
fondamentale via della Chiesa, via tracciata da Cristo stesso, via che
immutabilmente passa attraverso il mistero dell'Incarnazione e della
Redenzione»(133). Proprio in questo senso si è espresso, ripetutamente e con
singolare chiarezza e forza, il Concilio Vaticano II nei suoi diversi
documenti. Rileggiamo un testo particolarmente illuminante della
Costituzione Gaudium et spes: «La Chiesa, certo, perseguendo il
suo proprio fine di salvezza, non solo comunica all'uomo la vita divina,
ma anche diffonde la sua luce con ripercussione, in qualche modo, su tutto
il mondo, soprattutto per il fatto che risana ed eleva la dignità della
persona umana, consolida la compagine dell'umana società, e immette nel
lavoro quotidiano degli uomini un più profondo senso e significato. Così
la Chiesa, con i singoli suoi membri e con tutta intera la sua comunità,
crede di poter contribuire molto a rendere più umana la famiglia degli
uomini e la sua storia»(134). In questo contributo alla famiglia degli uomini, del quale è
responsabile l'intera Chiesa, un posto particolare compete ai fedeli
laici, in ragione della loro «indole secolare», che li impegna, con
modalità proprie e insostituibili, nell'animazione cristiana dell'ordine
temporale. Promuovere la dignità della persona 37. Riscoprire e far riscoprire la dignità inviolabile di ogni
persona umana costituisce un compito essenziale, anzi, in un certo
senso, il compito centrale e unificante del servizio che la Chiesa e, in
essa, i fedeli laici sono chiamati a rendere alla famiglia degli uomini. Tra tutte le creature terrene, solo l'uomo è «persona»,
soggetto cosciente e libero e, proprio per questo, «centro e vertice»
di tutto quanto esiste sulla terra(135). La dignità personale è il bene più prezioso che l'uomo
possiede, grazie al quale egli trascende in valore tutto il mondo
materiale. La parola di Gesù: «Che giova all'uomo guadagnare il mondo
intero, se poi perde la propria anima?» (Mc 8, 36) implica
una luminosa e stimolante affermazione antropologica: l'uomo vale non per
quello che «ha» _ possedesse pure il mondo intero! _ , quanto per quello
che «è». Contano non tanto i beni del mondo, quanto il bene della
persona, il bene che è la persona stessa. La dignità della persona manifesta tutto il suo fulgore quando se
ne considerano l'origine e la destinazione: creato da Dio a sua immagine e
somiglianza e redento dal sangue preziosissimo di Cristo, l'uomo è
chiamato ad essere «figlio nel Figlio» e tempio vivo dello Spirito, ed
è destinato all'eterna vita di comunione beatificante con Dio. Per questo
ogni violazione della dignità personale dell'essere umano grida vendetta
al cospetto di Dio e si configura come offesa al Creatore dell'uomo. In forza della sua dignità personale l'essere umano è sempre
un valore in sé e per sé, e come tale esige d'essere considerato e
trattato, mai invece può essere considerato e trattato come un oggetto
utilizzabile, uno strumento, una cosa. La dignità personale costituisce il fondamento
dell'eguaglianza di tutti gli uomini tra loro. Di qui l'assoluta
inaccettabilità di tutte le più svariate forme di discriminazione che,
purtroppo, continuano a dividere e a umiliare la famiglia umana, da quelle
razziali ed economiche a quelle sociali e culturali, da quelle politiche a
quelle geografiche, ecc. Ogni discriminazione costituisce un'ingiustizia
del tutto intollerabile, non tanto per le tensioni e per i conflitti
ch'essa può generare nel tessuto sociale, quanto per il disonore inferto
alla dignità della persona: non solo alla dignità di chi è vittima
dell'ingiustizia, ma ancor più di chi quell'ingiustizia compie. Fondamento dell'uguaglianza di tutti gli uomini tra loro, la
dignità personale è anche il fondamento della partecipazione e della
solidarietà degli uomini tra loro: il dialogo e la comunione si
radicano ultimamente su ciò che gli uomini «sono», prima e più ancora
che su quanto essi «hanno». La dignità personale è proprietà indistruttibile di ogni
essere umano. E' fondamentale avvertire tutta la forza dirompente di
questa affermazione, che si basa sull'unicità e sull'irripetibilità
di ogni persona. Ne deriva che l'individuo è assolutamente
irriducibile a tutto ciò che lo vorrebbe schiacciare e annullare
nell'anonimato della collettività, dell'istituzione, della struttura, del
sistema. La persona, nella sua individualità, non è un numero, non è un
anello d'una catena, né un ingranaggio di un sistema. L'affermazione più
radicale ed esaltante del valore di ogni essere umano è stata fatta dal
Figlio di Dio nel suo incarnarsi nel seno d'una donna. Anche di questo
continua a parlarci il Natale cristiano(136). Venerare l'inviolabile diritto alla vita 38. Il riconoscimento effettivo della dignità personale di ogni
essere umano esige il rispetto, la difesa e la promozione dei diritti
della persona umana. Si tratta di diritti naturali, universali e
inviolabili: nessuno, né il singolo, né il gruppo, né l'autorità, né
lo Stato, li può modificare né tanto meno li può eliminare, perché
tali diritti provengono da Dio stesso. Ora l'inviolabilità della persona, riflesso dell'assoluta
inviolabilità di Dio stesso, trova la sua prima e fondamentale
espressione nell'inviolabilità della vita umana. E' del tutto
falso e illusorio il comune discorso, che peraltro giustamente viene
fatto, sui diritti umani _ come ad esempio sul diritto alla salute, alla
casa, al lavoro, alla famiglia e alla cultura _ se non si difende con la
massima risolutezza il diritto alla vita, quale diritto
primo e fontale, condizione per tutti gli altri diritti della persona. La Chiesa non si è mai data per vinta di fronte a tutte le
violazioni che il diritto alla vita, proprio di ogni essere umano, ha
ricevuto e continua a ricevere sia dai singoli sia dalle stesse autorità.
Titolare di tale diritto è l'essere umano in ogni fase del suo
sviluppo, dal concepimento sino alla morte naturale; e in ogni sua
condizione, sia essa di salute o di malattia, di perfezione o di
handicap, di ricchezza o di miseria. Il Concilio Vaticano II proclama
apertamente: «Tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie
di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio
volontario; tutto ciò che viola l'integrità della persona umana, come le
mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla mente, gli sforzi per
violentare l'intimo dello spirito; tutto ciò che offende la dignità
umana, come le condizioni infraumane di vita, le incarcerazioni
arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato
delle donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni di lavoro
con le quali i lavoratori sono trattati come semplici strumenti di
guadagno, e non come persone libere e responsabili; tutte queste cose, e
altre simili, sono certamente vergognose e, mentre guastano la civiltà
umana, ancor più inquinano coloro che così si comportano, che non quelli
che le subiscono; e ledono grandemente l'onore del Creatore»(137). Ora se di tutti sono la missione e la responsabilità di
riconoscere la dignità personale di ogni essere umano e di difenderne il
diritto alla vita, alcuni fedeli laici vi sono chiamati ad un titolo
particolare: tali sono i genitori, gli educatori, gli operatori della
salute, e quanti detengono il potere economico e politico. Nell'accoglienza amorosa e generosa di ogni vita umana,
soprattutto se debole o malata, la Chiesa vive oggi un momento
fondamentale della sua missione, tanto più necessaria quanto più
dominante si è fatta una «cultura di morte». Infatti «la Chiesa
fermamente crede che la vita umana, anche se debole e sofferente, è
sempre uno splendido dono del Dio della bontà. Contro il pessimismo e
l'egoismo, che oscurano il mondo, la Chiesa sta dalla parte della vita: e
in ciascuna vita umana sa scoprire lo splendore di quel "Sì",
di quell' "Amen", che è Cristo stesso (cf. 2 Cor 1, 19;
Ap 3, 14). Al "no" che invade e affligge il mondo,
contrappone questo vivente "Sì", difendendo in tal modo l'uomo
e il mondo da quanti insidiano e mortificano la vita»(138). Tocca ai
fedeli laici, che più direttamente o per vocazione o per professione sono
coinvolti nell'accoglienza della vita, rendere concreto ed efficace il «sì»
della Chiesa alla vita umana. Sulle frontiere della vita umana possibilità e responsabilità
nuove si sono oggi spalancate con l'enorme sviluppo delle scienze
biologiche e mediche, unitamente al sorprendente potere
tecnologico: l'uomo, infatti, è in grado oggi non solo di «osservare»,
ma anche di «manipolare» la vita umana nello stesso suo inizio e nei
suoi primi stadi di sviluppo. La coscienza morale dell'umanità non può rimanere
estranea o indifferente di fronte ai passi giganteschi compiuti da una
potenza tecnologica che acquista un dominio sempre più vasto e profondo
sui dinamismi che presiedono alla procreazione e alle prime fasi dello
sviluppo della vita umana. Forse non mai come oggi e in questo campo la
sapienza si dimostra l'unica àncora di salvezza, perché l'uomo nella
ricerca scientifica e in quella applicata possa agire sempre con
intelligenza e con amore, ossia rispettando, anzi venerando l'inviolabile
dignità personale di ogni essere umano, sin dal primo istante della sua
esistenza. Ciò avviene quando con mezzi leciti, la scienza e la tecnica
si impegnano nella difesa della vita e nella cura della malattia sin dagli
inizi, rifiutando invece _ per la dignità stessa della ricerca _
interventi che risultano alterativi del patrimonio genetico dell'individuo
e della generazione umana(139). I fedeli laici, a vario titolo e a diverso livello impegnati nella
scienza e nella tecnica, come pure nell'ambito medico, sociale,
legislativo ed economico devono coraggiosamente accettare le «sfide»
poste dai nuovi problemi della bioetica. Come hanno detto i Padri
sinodali, «i cristiani debbono esercitare la loro responsabilità come
padroni della scienza e della tecnologia, non come servi di essa (...).
Nella prospettiva di quelle «sfide» morali, che stanno per essere
provocate dalla nuova e immensa potenza tecnologica e che mettono in
pericolo non solo i diritti fondamentali degli uomini, ma la stessa
essenza biologica della specie umana, è della massima importanza che i
laici cristiani _ con l'aiuto di tutta la Chiesa _ si prendano a carico di
richiamare la cultura ai principi di un autentico umanesimo, affinché la
promozione e la difesa dei diritti dell'uomo possano trovare fondamento
dinamico e sicuro nella stessa sua essenza, quella essenza che la
predicazione evangelica ha rivelato agli uomini»(140). Urge oggi, da parte di tutti, la massima vigilanza di fronte al
fenomeno della concentrazione del potere, e in primo luogo di quello
tecnologico. Tale concentrazione, infatti, tende a manipolare non solo
l'essenza biologica ma anche i contenuti della stessa coscienza degli
uomini e i loro modelli di vita, aggravando in tal modo la discriminazione
e l'emarginazione di interi popoli. Liberi di invocare il Nome del Signore 39. Il rispetto della dignità personale, che comporta la difesa e
la promozione dei diritti umani, esige il riconoscimento della dimensione
religiosa dell'uomo. Non è, questa, un'esigenza semplicemente «confessionale»,
bensì un'esigenza che trova la sua radice inestirpabile nella realtà
stessa dell'uomo. Il rapporto con Dio, infatti, è elemento costitutivo
dello stesso «essere» ed «esistere» dell'uomo: è in Dio che noi «viviamo,
ci muoviamo ed esistiamo» (At 17, 28). Se non tutti credono a tale
verità, quanti ne sono convinti hanno il diritto di essere rispettati
nella loro fede e nelle scelte di vita, individuale e comunitaria, che da
essa derivano. E' questo il diritto alla libertà di coscienza e alla
libertà religiosa, il cui riconoscimento effettivo è tra i beni più
alti e tra i doveri più gravi di ogni popolo che voglia veramente
assicurare il bene della persona e della società: «La libertà
religiosa, esigenza insopprimibile della dignità di ogni uomo, è una
pietra angolare dell'edificio dei diritti umani e, pertanto, è un fattore
insostituibile del bene delle persone e di tutta la società, così come
della propria realizzazione di ciascuno. Ne consegue che la libertà dei
singoli e delle comunità di professare e di praticare la propria
religione è un elemento essenziale della pacifica convivenza degli uomini
(...): Il diritto civile e sociale alla libertà religiosa, in quanto
attinge la sfera più intima dello spirito, si rivela punto di riferimento
e, in certo modo, diviene misura degli altri diritti fondamentali»(141). Il Sinodo non ha dimenticato i tanti fratelIi e sorelle che ancora
non godono di tale diritto e che devono affrontare disagi, emarginazioni,
sofferenze, persecuzioni, e talvolta la morte a causa della confessione
della fede. Nella maggioranza sono fratelli e sorelle del laicato
cristiano. L'annuncio del Vangelo e la testimonianza cristiana della vita
nella sofferenza e nel martirio costituiscono l'apice dell'apostolato dei
discepoli di Cristo, così come l'amore al Signore Gesù sino al dono
della propria vita costituisce una sorgente di fecondità straordinaria
per l'edificazione della Chiesa. La mistica vite testimonia così la sua
rigogliosità, come rilevava Sant'Agostino: «Ma quella vite, com'era
stato preannunciato dai Profeti e dallo stesso Signore, che diffondeva in
tutto il mondo i suoi tralci fruttuosi, tanto più diveniva rigogliosa
quanto più era irrigata dal molto sangue dei martiri»(142). La Chiesa tutta è profondamente grata per questo esempio e per
questo dono: da questi suoi figli essa trae motivo per rinnovare il suo
slancio di vita santa e apostolica. In tal senso i Padri sinodali hanno
ritenuto loro speciale dovere «ringraziare quei laici i quali vivono come
instancabili testimoni della fede, in fedele unione con la Sede
Apostolica, nonostante le restrizioni della libertà e la privazione dei
ministri sacri. Essi si giocano tutto, perfino la vita. I laici in questo
modo danno testimonianza di una proprietà essenziale della Chiesa: la
Chiesa di Dio nasce dalla grazia di Dio e ciò si manifesta nel modo più
sublime nel martirio»(143). Quanto abbiamo sinora detto sul rispetto della dignità personale
e sul riconoscimento dei diritti umani riguarda senza dubbio la
responsabilità di ciascun cristiano, di ciascun uomo. Ma dobbiamo
immediatamente rilevare come tale problema rivesta oggi una dimensione
mondiale: è, infatti, una questione che investe oramai interi gruppi
umani, anzi interi popoli che sono violentemente vilipesi nei loro
fondamentali diritti. Di qui quelle forme di disuguaglianza dello sviluppo
tra i diversi Mondi che nella recente Enciclica Sollicitudo rei
socialis sono state apertamente denunciate. Il rispetto della persona umana va oltre la esigenza di una morale
individuale e si pone come criterio basilare, quasi pilastro fondamentale,
per la strutturazione della società stessa, essendo la società
finalizzata interamente alla persona. Così, intimamente congiunta alla responsabilità di servire la
persona, si pone la responsabilità di servire la società, quale
compito generale di quella animazione cristiana dell'ordine temporale alla
quale i fedeli laici sono chiamati secondo loro proprie e specifiche
modalità. La famiglia, primo spazio per l'impegno sociale 40. La persona umana ha una nativa e strutturale dimensione
sociale in quanto è chiamata dall'intimo di sé alla comunione con
gli altri e alla donazione agli altri: «Dio, che ha cura paterna
di tutti, ha voluto che gli uomini formassero una sola famiglia e si
trattassero tra loro con animo di fratelli»(144). E così la società,
frutto e segno della socialità dell'uomo, rivela la sua piena
verità nell'essere una comunità di persone. Si dà interdipendenza e reciprocità tra persona e società:
tutto ciò che viene compiuto a favore della persona è anche un servizio
reso alla società, e tutto ciò che viene compiuto a favore della società
si risolve a beneficio della persona. Per questo l'impegno apostolico dei
fedeli laici nell'ordine temporale riveste sempre e in modo inscindibile
il significato del servizio all'uomo singolo nella sua unicità e
irripetibilità e il significato del servizio a tutti gli uomini. Ora la prima e originaria espressione della dimensione sociale
della persona è la coppia e la famiglia: «Ma Dio non creò l'uomo
lasciandolo solo: fin da principio "uomo e donna li creò" (Gen
1, 27) e la loro unione costituisce la prima forma di comunione di
persone»(145). Gesù si è preoccupato di restituire alla coppia l'intera
sua dignità e alla famiglia la saldezza sua propria (cf. Mt 19,
3-9); San Paolo ha mostrato il rapporto profondo del matrimonio con il
mistero di Cristo e della Chiesa (cf. Ef 5, 22-6, 4; Col 3, 18-21;
1 Pt 3, 1-7). La coppia e la famiglia costituiscono il primo spazio per
l'impegno sociale dei fedeli laici. E' un impegno che può essere
assolto adeguatamente solo nella convinzione del valore unico e
insostituibile della famiglia per lo sviluppo della società e della
stessa Chiesa. Culla della vita e dell'amore, nella quale l'uomo «nasce» e «cresce»,
la famiglia è la cellula fondamentale della società. A questa comunità
è da riservarsi una privilegiata sollecitudine, soprattutto ogniqualvolta
l'egoismo umano, le campagne antinataliste, le politiche totalitarie, ma
anche le situazioni di povertà e di miseria fisica, culturale e morale,
nonché la mentalità edonistica e consumistica fanno disseccare le
sorgenti della vita, mentre le ideologie e i diversi sistemi, insieme a
forme di disinteresse e di disamore, attentano alla funzione educativa
propria della famiglia. Urge così un'opera vasta, profonda e sistematica, sostenuta non
solo dalla cultura ma anche dai mezzi economici e dagli strumenti
legislativi, destinata ad assicurare alla famiglia il suo compito di
essere il luogo primario della «umanizzazione» della persona e
della società. L'impegno apostolico dei fedeli laici è anzitutto quello di
rendere la famiglia cosciente della sua identità di primo nucleo sociale
di base e del suo originale ruolo nella società, perché divenga essa
stessa sempre più protagonista attiva e responsabile della propria
crescita e della propria partecipazione alla vita sociale. In tal modo la
famiglia potrà e dovrà esigere da tutti, a cominciare dalle autorità
pubbliche, il rispetto di quei diritti che, salvando la famiglia, salvano
la società stessa. Quanto è scritto nell'Esortazione Familiaris consortio circa
la partecipazione allo sviluppo della società(146) e quanto la Santa
Sede, su invito del Sinodo dei Vescovi del 1980, ha formulato con la «Carta
dei Diritti della Famiglia» rappresentano un programma operativo completo
e organico per tutti quei fedeli laici che, a diverso titolo, sono
interessati alla promozione dei valori e delle esigenze della famiglia: un
programma la cui realizzazione è da urgere con tanta maggior tempestività
e decisione quanto più gravi si fanno le minacce alla stabilità e alla
fecondità della famiglia e quanto più pesante e sistematico si fa il
tentativo di emarginare la famiglia e di vanificarne il peso sociale. Come l'esperienza attesta, la civiltà e la saldezza dei popoli
dipendono soprattutto dalla qualità umana delle loro famiglie. Per questo
l'impegno apostolico verso la famiglia acquista un incomparabile valore
sociale. La Chiesa, da parte sua, ne è profondamente convinta, ben
sapendo che «l'avvenire dell'umanità passa attraverso la famiglia»(147). La carità anima e sostegno della solidarietà 41. Il servizio alla società si esprime e si realizza in
diversissime modalità: da quelle libere e informali a quelle
istituzionali, dall'aiuto dato ai singoli a quello rivolto a vari gruppi e
comunità di persone. Tutta la Chiesa come tale è direttamente chiamata al servizio
della carità: «La santa Chiesa, come nelle sue origini unendo l'agape
con la Cena Eucaristica si manifestava tutta unita nel vincolo della
carità attorno a Cristo, così, in ogni tempo, si riconosce da questo
contrassegno della carità e, mentre gode delle iniziative altrui,
rivendica le opere di carità come suo dovere e diritto inalienabile.
Perciò la misericordia verso i poveri e gli infermi come pure le
cosiddette opere caritative e di mutuo aiuto, destinate ad alleviare le
necessità umane di ogni genere, sono tenute dalla Chiesa in particolare
onore»(148). La carità verso il prossimo, nelle forme antiche e
sempre nuove delle opere di misericordia corporale e spirituale,
rappresenta il contenuto più immediato, comune e abituale di
quell'animazione cristiana dell'ordine temporale che costituisce l'impegno
specifico dei fedeli laici. Con la carità verso il prossimo i fedeli laici vivono e
manifestano la loro partecipazione alla regalità di Gesù Cristo, al
potere cioè del Figlio dell'uomo che «non è venuto per essere servito,
ma per servire» (Mc 10, 45): essi vivono e manifestano tale
regalità nel modo più semplice, possibile a tutti e sempre, ed insieme
nel modo più esaltante, perché la carità è il più alto dono che lo
Spirito offre per l'edificazione della Chiesa (cf. 1 Cor 13, 13) e
per il bene dell'umanità. La carità, infatti, anima e sostiene
un'operosa solidarietà attenta alla totalità dei bisogni dell'essere
umano. Una simile carità, attuata non solo dai singoli ma anche in modo
solidale dai gruppi e dalle comunità, è e sarà sempre necessaria:
niente e nessuno la può e la potrà sostituire, neppure le molteplici
istituzioni e iniziative pubbliche, che pure si sforzano di dare risposta
ai bisogni _ spesso oggi così gravi e diffusi _ d'una popolazione.
Paradossalmente tale carità si fa più necessaria quanto più le
istituzioni, diventando complesse nell'organizzazione e pretendendo di
gestire ogni spazio disponibile, finiscono per essere rovinate dal
funzionalismo impersonale, dall'esagerata burocrazia, dagli ingiusti
interessi privati, dal disimpegno facile e generalizzato. Proprio in questo contesto continuano a sorgere e a diffondersi,
in particolare nelle società organizzate, varie forme di volontariato che
si esprimono in una molteplicità di servizi e di opere. Se vissuto nella
sua verità di servizio disinteressato al bene delle persone, specialmente
le più bisognose e le più dimenticate dagli stessi servizi sociali, il
volontariato deve dirsi una espressione importante di apostolato, nel
quale i fedeli laici, uomini e donne, hanno un ruolo di primo piano. Tutti destinatari e protagonisti della politica 42. La carità che ama e serve la persona non può mai essere
disgiunta dalla giustizia: e l'una e l'altra, ciascuna a suo modo,
esigono il pieno riconoscimento effettivo dei diritti della persona, alla
quale è ordinata la società con tutte le sue strutture ed
istituzioni(149). Per animare cristianamente l'ordine temporale, nel senso detto di
servire la persona e la società, i fedeli laici non possono affatto
abdicare alla partecipazione alla «politica», ossia alla molteplice
e varia azione economica, sociale, legislativa, amministrativa e
culturale, destinata a promuovere organicamente e istituzionalmente il
bene comune. Come ripetutamente hanno affermato i Padri sinodali,
tutti e ciascuno hanno diritto e dovere di partecipare alla politica, sia
pure con diversità e complementarietà di forme, livelli, compiti e
responsabilità. Le accuse di arrivismo, di idolatria del potere, di
egoismo e di corruzione che non infrequentemente vengono rivolte agli
uomini del governo, del parlamento, della classe dominante, del partito
politico; come pure l'opinione non poco diffusa che la politica sia un
luogo di necessario pericolo morale, non giustificano minimamente né lo
scetticismo né l'assenteismo dei cristiani per la cosa pubblica. E', invece, quanto mai significativa la parola del Concilio
Vaticano II: «La Chiesa stima degna di lode e di considerazione l'opera
di coloro che per servire gli uomini si dedicano al bene della cosa
pubblica e assumono il peso delle relative responsabilità»(150). Una politica per la persona e per la società trova il suo criterio
basilare nel perseguimento del bene comune, come bene di tutti
gli uomini e di tutto l'uomo, bene offerto e garantito alla
libera e responsabile accoglienza delle persone, sia singole che
associate: «La comunità politica _ leggiamo nella Costituzione Gaudium
et spes _ esiste proprio in funzione di quel bene comune, nel quale
essa trova piena giustificazione e significato e dal quale ricava il suo
ordinamento giuridico, originario e proprio. Il bene comune si concreta
nell'insieme di quelle condizioni della vita sociale, con le quali gli
uomini, le famiglie e le associazioni possono ottenere il conseguimento più
pieno della propria perfezione»(151). Inoltre, una politica per la persona e per la società trova la
sua linea costante di cammino nella difesa e nella promozione
della giustizia, intesa come «virtù» alla quale tutti devono essere
educati e come «forza» morale che sostiene l'impegno a favorire i
diritti e i doveri di tutti e di ciascuno, sulla base della dignità
personale dell'essere umano. Nell'esercizio del potere politico è fondamentale lo spirito
di servizio, che solo, unitamente alla necessaria competenza ed
efficienza, può rendere «trasparente» o «pulita» l'attività degli
uomini politici, come del resto la gente giustamente esige. Ciò sollecita
la lotta aperta e il deciso superamento di alcune tentazioni, quali il
ricorso alla slealtà e alla menzogna, lo sperpero del pubblico denaro per
il tornaconto di alcuni pochi e con intenti clientelari, l'uso di mezzi
equivoci o illeciti per conquistare, mantenere e aumentare ad ogni costo
il potere. I fedeli laici impegnati nella politica devono certamente
rispettare l'autonomia rettamente intesa delle realtà terrene, così come
leggiamo nella Costituzione Gaudium et spes: «E' di grande
importanza, soprattutto in una società pluralistica, che si abbia una
giusta visione dei rapporti tra la comunità politica e la Chiesa e che si
faccia una chiara distinzione tra le azioni che i fedeli, individualmente
o in gruppo, compiono in proprio nome, come cittadini, guidati dalla
coscienza cristiana, e le azioni che essi compiono in nome della Chiesa in
comunione con i loro pastori. La Chiesa, che, in ragione del suo ufficio e
della sua competenza, in nessuna maniera si confonde con la comunità
politica e non è legata ad alcun sistema politico, è insieme il segno e
la salvaguardia del carattere trascendente della persona umana»(152).
Nello stessotempo _ e questo è sentito oggi come urgenza e responsabilità
_ i fedeli laici devono testimoniare quei valori umani ed evangelici che
sono intimamente connessi con l'attività politica stessa, come la libertà
e la giustizia, la solidarietà, la dedizione fedele e disinteressata al
bene di tutti, lo stile semplice di vita, l'amore preferenziale per i
poveri e gli ultimi. Ciò esige che i fedeli laici siano sempre più
animati da una reale partecipazione alla vita della Chiesa e illuminati
dalla sua dottrina sociale. In questo potranno essere accompagnati e
aiutati dalla vicinanza delle comunità cristiane e dei loro Pastori(153). Stile e mezzo per il realizzarsi d'una politica che intenda mirare
al vero sviluppo umano è la solidarietà: questa sollecita la partecipazione
attiva e responsabile di tutti alla vita politica, dai singoli
cittadini ai gruppi vari, dai sindacati ai partiti: insieme, tutti e
ciascuno, siamo destinatari e protagonisti della politica. In questo
ambito, come ho scritto nell'Enciclica Sollicitudo rei socialis, la
solidarietà «non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale
intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario,
è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene
comune:ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti
siamo veramente responsabili di tutti»(154). La solidarietà politica esige oggi d'attuarsi secondo un
orizzonte che, superando la singola nazione o il singolo blocco di
nazioni, si configura come propriamente continentale e mondiale. Il frutto dell'attività politica solidale, da tutti tanto
desiderato ma pur sempre tanto immaturo, è la pace. I fedeli laici
non possono rimanere indifferenti, estranei e pigri di fronte a tutto ciò
che è negazione e compromissione della pace: violenza e guerra, tortura e
terrorismo, campi di concentramento, militarizzazione della politica,
corsa agli armamenti, minaccia nucleare. Al contrario, come discepoli di
Gesù Cristo «Principe della pace» (Is 9, 5) e «Nostra
Pace» (Ef 2, 14), i fedeli laici devono assumersi il compito di
essere «operatori di pace» (Mt 5, 9), sia mediante la
conversione del «cuore», sia mediante l'azione a favore della verità,
della libertà, della giustizia e della carità, che della pace sono gli
irrinunciabili fondamenti(155). Collaborando con tutti coloro che cercano veramente la pace e
servendosi degli specifici organismi e istituzioni nazionali e
internazionali, i fedeli laici devono promuovere un'opera educativa
capillare destinata a sconfiggere l'imperante cultura dell'egoismo,
dell'odio, della vendetta e dell'inimicizia e a sviluppare la cultura
della solidarietà ad ogni livello. Tale solidarietà, infatti, «è via
alla pace e insieme allo sviluppo»(156). In questa prospettiva i
Padri sinodali hanno invitato i cristiani a rifiutare forme inaccettabili
di violenza, a promuovere atteggiamenti di dialogo e di pace e ad
impegnarsi per instaurare un ordine sociale e internazionale giusto(157). Porre l'uomo al centro della vita economico-sociale 43. Il servizio alla società da parte dei fedeli laici trova un
suo momento essenziale nella questione economico-sociale, la cui
chiave è data dall'organizzazione del lavoro. La gravità attuale di tali problemi, colta nel panorama dello
sviluppo e secondo la proposta di soluzione da parte della dottrina
sociale della Chiesa, è stata ricordata recentemente nell'Enciclica Sollicitudo
rei socialis, alla quale desidero caldamente rimandare tutti, in
particolare i fedeli laici. Tra i caposaldi della dottrina sociale della Chiesa sta il
principio della destinazione universale dei beni: i beni della
terra sono, nel disegno di Dio, offerti a tutti gli uomini e a ciascun
uomo come mezzo per lo sviluppo d'una vita autenticamente umana. Al
servizio di questa destinazione si pone la proprietà privata, la
quale _ proprio per questo _ possiede un'intrinseca funzione sociale. Concretamente
il lavoro dell'uomo e della donna rappresenta lo strumento più
comune e più immediato per lo sviluppo della vita economica, strumento
che insieme costituisce un diritto e un dovere d'ogni uomo. Tutto questo rientra in modo particolare nella missione dei fedeli
laici. Il fine e il criterio della loro presenza e della loro azione sono
formulati in termini generali dal Concilio Vaticano II: «Anche nella vita
economico-sociale sono da onorare e da promuovere la dignità e
l'integrale vocazione della persona umana come pure il bene dell'intera
società. L'uomo infatti è l'autore, il centro e il fine di tutta la vita
economico-sociale»(158). Nel contesto delle sconvolgenti trasformazioni in atto nel mondo
dell'economia e del lavoro, i fedeli laici siano impegnati in prima fila a
risolvere i gravissimi problemi della crescente disoccupazione, a battersi
per il superamento più tempestivo di numerose ingiustizie che derivano da
distorte organizzazioni del lavoro, a far diventare il luogo di lavoro una
comunità di persone rispettate nella loro soggettività e nel loro
diritto alla partecipazione, a sviluppare nuove solidarietà tra coloro
che partecipano al lavoro comune, a suscitare nuove forme di
imprenditorialità e a rivedere i sistemi di commercio, di finanza e di
scambi tecnologici. A tal fine i fedeli laici devono compiere il loro lavoro con
competenza professionale, con onestà umana, con spirito cristiano, come
via della propria santificazione(159), secondo l'esplicito invito del
Concilio: «Con il lavoro, l'uomo ordinariamente provvede alla vita
propria e dei suoi familiari, comunica con gli altri e rende servizio agli
uomini suoi fratelli, può praticare una vera carità e collaborare con la
propria attività al completarsi della divina creazione. Ancor più:
sappiamo che, offrendo a Dio il proprio lavoro, l'uomo si associa
all'opera stessa redentiva di Cristo, il quale ha conferito al lavoro una
elevatissima dignità, lavorando con le proprie mani a Nazareth»(160). In rapporto alla vita economico-sociale e al lavoro si pone oggi,
in modo sempre più acuto, la questione cosiddetta «ecologica». Certamente
l'uomo ha da Dio stesso il compito di «dominare» le cose create e di «coltivare
il giardino» del mondo; ma è un compito, questo, che l'uomo deve
assolvere nel rispetto dell'immagine divina ricevuta, e quindi con
intelligenza e con amore: egli deve sentirsi responsabile dei doni che Dio
gli ha elargito e continuamente gli elargisce. L'uomo ha fra le mani un
dono che deve passare _ e, se possibile, persino migliorato _ alle
generazioni future, anch'esse destinatarie dei doni del Signore: «Il
dominio accordato dal Creatore all'uomo (...) non è un potere assoluto, né
si può parlare di libertà di "usare e abusare", o di disporre
delle cose come meglio aggrada. La limitazione imposta dallo stesso
Creatore fin dal principio, ed espressa simbolicamente con la proibizione
di "mangiare il frutto dell'albero" (cf. Gen 2, 16-17),
mostra con sufficiente chiarezza che, nei confronti della natura visibile
(...), siamo sottomessi a leggi non solo biologiche, ma anche morali, che
non si possono impunemente trasgredire. Una giusta concezione dello
sviluppo non può prescindere da queste considerazioni _ relative all'uso
degli elementi della natura, alla rinnovabilità delle risorse e alle
conseguenze di una industrializzazione disordinata _, le quali
ripropongono alla nostra coscienza la dimensione morale, che deve
distinguere lo sviluppo»(161). Evangelizzare la cultura e le culture dell'uomo 44. Il servizio alla persona e alla società umana si esprime e si
attua attraverso la creazione e la trasmissione della cultura, che,
specialmente ai nostri giorni, costituisce uno dei più gravi compiti
della convivenza umana e dell'evoluzione sociale. Alla luce del Concilio,
intendiamo per «cultura» tutti quei «mezzi con i quali l'uomo affina ed
esplica le molteplici sue doti di anima e di corpo; procura di ridurre in
suo potere il cosmo stesso con la conoscenza e il lavoro; rende più umana
la vita sociale sia nella famiglia che in tutta la società civile,
mediante il progresso del costume e delle istituzioni; infine, con
l'andare del tempo, esprime, comunica e conserva nelle sue opere le grandi
esperienze e aspirazioni spirituali, affinché possano servire al
progresso di molti, anzi di tutto il genere umano»(162). In questo senso,
la cultura deve ritenersi come il bene comune di ciascun popolo,
l'espressione della sua dignità, libertà e creatività; la testimonianza
del suo cammino storico. In particolare, solo all'interno e tramite la
cultura la fede cristiana diventa storica e creatrice di storia. Di fronte allo sviluppo di una cultura che si configura dissociata
non solo dalla fede cristiana, ma persino dagli stessi valori umani(163);
come pure di fronte ad una certa cultura scientifica e tecnologica
impotente nel dare risposta alla pressante domanda di verità e di bene
che brucia nel cuore degli uomini, la Chiesa è pienamente consapevole
dell'urgenza pastorale che alla cultura venga riservata un'attenzione del
tutto speciale. Per questo la Chiesa sollecita i fedeli laici ad essere presenti,
all'insegna del coraggio e della creatività intellettuale, nei posti
privilegiati della cultura, quali sono il mondo della scuola e
dell'università, gli ambienti della ricerca scientifica e tecnica, i
luoghi della creazione artistica e della riflessione umanistica. Tale
presenza è destinata non solo al riconoscimento e all'eventuale
purificazione degli elementi della cultura esistente criticamente
vagliati, ma anche alla loro elevazione mediante le originali ricchezze
del Vangelo e della fede cristiana. Quanto il Concilio Vaticano II scrive
circa il rapporto tra il Vangelo e la cultura rappresenta un fatto storico
costante ed insieme un ideale operativo di singolare attualità e urgenza;
è un programma impegnativo consegnato alla responsabilità pastorale
dell'intera Chiesa e in essa alla responsabilità specifica dei fedeli
laici: «La buona novella di Cristo rinnova continuamente la vita e la
cultura dell'uomo decaduto, combatte e rimuove gli errori e i mali,
derivanti dalla sempre minacciosa seduzione del peccato. Continuamente
purifica ed eleva la moralità dei popoli (...). In tal modo la Chiesa,
compiendo la sua missione, già con questo stesso fatto stimola e dà il
suo contributo alla cultura umana e civile e, mediante la sua azione,
anche liturgica, educa l'uomo alla libertà interiore»(164). Meritano di essere qui riascoltate alcune espressioni
particolarmente significative della Esortazione Evangelii nuntiandi di
Paolo VI: «La Chiesa evangelizza allorquando, in virtù della sola potenza
divina del Messaggio che essa proclama (cf. Rom 1, 16; 1 Cor 1,
18; 2, 4), cerca di convertire la coscienza personale e insieme
collettiva degli uomini, l'attività nella quale essi sono impegnati, la
vita e l'ambiente concreto loro propri. Strati dell'umanità che si
trasformano: per la Chiesa non si tratta soltanto di predicare il Vangelo
in fasce geografiche sempre più vaste o a popolazioni sempre più estese,
ma anche di raggiungere e quasi sconvolgere mediante la forza del Vangelo
i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti d'interesse, le
linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i modelli di vita dell'umanità,
che sono in contrasto con la Parola di Dio e col disegno della salvezza.
Si potrebbe esprimere tutto ciò dicendo così: occorre evangelizzare _
non in maniera decorativa, a somiglianza di vernice superficiale, ma in
modo vitale, in profondità e fino alle radici _ la cultura e le culture
dell'uomo (...). La rottura tra Vangelo e cultura è senza dubbio il
dramma della nostra epoca, come lo fu anche di altre. Occorre quindi fare
tutti gli sforzi in vista di una generosa evangelizzazione della cultura,
più esattamente delle culture»(165). La via attualmente privilegiata per la creazione e per la
trasmissione della cultura sono gli strumenti della comunicazione
sociale(166). Anche il mondo dei mass-media, in seguito all'accelerato
sviluppo innovativo e all'influsso insieme planetario e capillare sulla
formazione della mentalità e del costume, rappresenta una nuova frontiera
della missione della Chiesa. In particolare, la responsabilità
professionale dei fedeli laici in questo campo, esercitata sia a titolo
personale sia mediante iniziative ed istituzioni comunitarie, esige di
essere riconosciuta in tutto il suo valore e sostenuta con più adeguate
risorse materiali, intellettuali e pastorali. Nell'impiego e nella recezione degli strumenti di comunicazione
urgono sia un'opera educativa al senso critico, animato dalla passione per
la verità, sia un'opera di difesa della libertà, del rispetto alla
dignità personale, dell'elevazione dell'autentica cultura dei popoli,
mediante il rifiuto fermo e coraggioso di ogni forma di monopolizzazione e
di manipolazione. Né a quest'opera di difesa si ferma la responsabilità pastorale
dei fedeli laici: su tutte le strade del mondo, anche su quelle maestre
della stampa, del cinema, della radio, della televisione e del teatro,
dev'essere annunciato il Vangelo che salva. |
|
|
CAPITOLO IV GLI OPERAI DELLA VIGNA
DEL SIGNORE La varietà delle vocazioni 45. Secondo la parabola evangelica, il «padrone di casa» chiama
gli operai alla sua vigna nelle diverse ore della giornata: alcuni
all'alba, altri verso le nove del mattino, altri ancora verso mezzogiorno
e le tre, gli ultimi verso le cinque (cf. Mt 20, 1 ss.). Nel
commento a questa pagina del Vangelo, San Gregorio Magno interpreta le ore
diverse della chiamata rapportandole alle età della vita: «E'
possibile applicare la diversità delle ore _ egli scrive _ alle diverse
età dell'uomo. Il mattino può certo rappresentare, in questa nostra
interpretazione, la fanciullezza. L'ora terza, poi, si può intendere come
l'adolescenza: il sole si muove verso l'alto del cielo, cioè cresce
l'ardore dell'età. La sesta ora è la giovinezza: il sole sta come nel
mezzo del cielo, ossia in quest'età si rafforza la pienezza del vigore.
L'anzianità rappresenta l'ora nona, perché come il sole declina dal suo
alto asse così quest'età comincia a perdere l'ardore della giovinezza.
L'undicesima ora è l'età di quelli molto avanzati negli anni (...). Gli
operai sono, dunque, chiamati alla vigna in diverse ore, come per dire che
alla vita santa uno è condotto durante la fanciullezza, un altro nella
giovinezza, un altro nell'anzianità e un altro nell'età più avanzata»(167). Possiamo riprendere ed estendere il commento di San Gregorio Magno
in rapporto alla straordinaria varietà di presenze nella Chiesa, tutte e
ciascuna chiamate a lavorare per l'avvento del Regno di Dio secondo la
diversità di vocazioni e situazioni, carismi e ministeri. E' una varietà
legata non solo all'età, ma anche alla differenza di sesso e alla
diversità delle doti, come pure alle vocazioni e alle condizioni di vita;
è una varietà che rende più viva e concreta la ricchezza della Chiesa. Giovani, bambini, anziani I giovani, speranza della Chiesa 46. Il Sinodo ha voluto riservare un'attenzione particolare ai
giovani. E giustamente. In tanti paesi del mondo, essi rappresentano
la metà dell'intera popolazione e, spesso, la metà numerica dello stesso
Popolo di Dio che in quei paesi vive. Già sotto questo aspetto i giovani costituiscono una forza
eccezionale e sono una grande sfida per l'avvenire della Chiesa. Nei
giovani, infatti, la Chiesa legge il suo camminare verso il futuro che
l'attende e trova l'immagine e il richiamo di quella lieta giovinezza di
cui lo Spirito di Cristo costantemente l'arricchisce. In questo senso il
Concilio ha definito i giovani «speranza della Chiesa»(168). Nella lettera scritta ai giovani e alle giovani del mondo, il 31
marzo 1985, leggiamo: «La Chiesa guarda i giovani; anzi, la Chiesa in
modo speciale guarda se stessa nei giovani, in voi tutti ed insieme
in ciascuna e in ciascuno di voi. Così è stato sin dall'inizio, dai
tempi apostolici. Le parole di san Giovanni nella sua Prima Lettera possono
essere una particolare testimonianza: "Scrivo a voi, giovani, perché
avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete
conosciuto il Padre (...). Ho scritto a voi, giovani, perché siete
forti, e la parola di Dio dimora in voi" (1 Gv 2, 13 ss.)
(...). Nella nostra generazione, al termine del secondo Millennio dopo
Cristo, anche la Chiesa guarda se stessa nei giovani»(169). I giovani non devono essere considerati semplicemente come
l'oggetto della sollecitudine pastorale della Chiesa: sono di fatto, e
devono venire incoraggiati ad esserlo, soggetti attivi, protagonisti
dell'evangelizzazione e artefici del rinnovamento sociale(170). La
giovinezza è il tempo di una scoperta particolarmente intensa del
proprio «io» e del proprio «progetto di vita», è il tempo di una crescita
che deve avvenire «in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli
uomini» (Lc 2, 52). Come hanno detto i Padri sinodali, «la sensibilità dei giovani
percepisce profondamente i valori della giustizia, della non violenza e
della pace. Il loro cuore è aperto alla fraternità, alla amicizia e alla
solidarietà. Sono mobilitati al massimo per le cause che riguardano la
qualità della vita e la conservazione della natura. Ma essi sono anche
carichi di inquietudini, di delusioni, di angosce e paure del mondo, oltre
che delle tentazioni proprie del loro stato»(171). La Chiesa deve rivivere l'amore di predilezione che Gesù ha
testimoniato al giovane del Vangelo: «Gesù, fissatolo, lo amò» (Mc
10, 21). Per questo la Chiesa non si stanca di annunciare Gesù Cristo, di
proclamare il suo Vangelo come l'unica e sovrabbondante risposta alle più
radicali aspirazioni dei giovani, come la proposta forte ed esaltante di
una sequela personale («vieni e seguimi» [Mc 10, 21]), che
comporta la condivisione all'amore filiale di Gesù per il Padre e la
partecipazione alla sua missione di salvezza per l'umanità. La Chiesa ha tante cose da dire ai giovani, e i giovani hanno
tante cose da dire alla Chiesa. Questo reciproco
dialogo, da attuarsi con grande cordialità, chiarezza e coraggio, favorirà
l'incontro e lo scambio tra le generazioni, e sarà fonte di ricchezza e
di giovinezza per la Chiesa e per la società civile. Nel suo messaggio ai
giovani il Concilio dice: «La Chiesa vi guarda con fiducia e con amore
(...). Essa è la vera giovinezza del mondo (...), guardatela e troverete
in lei il volto di Cristo»(172). I bambini e il regno dei cieli 47. I bambini sono certamente il termine dell'amore delicato e
generoso del Signore Gesù: ad essi riserva la sua benedizione e ancor più
assicura il regno dei cieli (cf. Mt 19, 13-15; Mc 10, 14).
In particolare Gesù esalta il ruolo attivo che i piccoli hanno nel Regno
di Dio: sono il simbolo eloquente e la splendida immagine di quelle
condizioni morali e spirituali che sono essenziali per entrare nel Regno
di Dio e per viverne la logica di totale affidamento al Signore: «In
verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini,
non entrerete nel regno dei cieli. Perché chiunque diventerà piccolo
come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi
accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio accoglie me» (Mt
18, 3-5; cf. Lc 9, 48). I bambini ci ricordano che la fecondità missionaria della Chiesa
ha la sua radice vivificante non nei mezzi e nei meriti umani, ma nel dono
assolutamente gratuito di Dio. La vita di innocenza e di grazia dei
bambini, come pure le sofferenze loro ingiustamente inflitte, ottengono,
in virtù della Croce di Cristo, uno spirituale arricchimento per loro e
per l'intera Chiesa: di questo tutti dobbiamo prendere più viva e grata
coscienza. Si deve riconoscere, inoltre, che anche nell'età dell'infanzia e
della fanciullezza sono aperte preziose possibilità operative sia per
l'edificazione della Chiesa che per l'umanizzazione della società. Quanto
il Concilio dice della presenza benefica e costruttiva dei figli
all'interno della famiglia «chiesa domestica»: «I figli, come membra
vive della famiglia, contribuiscono pure a loro modo alla santificazione
dei genitori»(173) dev'essere ripetuto dei bambini in rapporto alla
Chiesa particolare e universale. Lo rilevava già Jean Gerson, teologo ed
educatore del xv secolo, per il quale «i fanciulli e gli adolescenti non
sono certo una parte trascurabile della Chiesa»(174). Gli anziani e il dono della sapienza 48. Alle persone anziane, spesso ingiustamente ritenute inutili se
non addirittura d'insopportabile peso, ricordo che la Chiesa chiede e
attende che esse abbiano a continuare la loro missione apostolica e
missionaria, non solo possibile e doverosa anche a quest'età, ma da
questa stessa età resa in qualche modo specifica e originale. La Bibbia ama presentare l'anziano come il simbolo della persona
ricca di sapienza e di timore di Dio (cf. Sir 25, 4-6). In questo
senso il «dono» dell'anziano potrebbe qualificarsi come quello di
essere, nella Chiesa e nella società, il testimone della tradizione di
fede (cf. Sal 44, 2; Es 12, 26-27), il maestro di vita (cf. Sir
6, 34; 8, 11-12), l'operatore di carità. Ora l'aumentato numero di persone anziane in diversi paesi del
mondo e la cessazione anticipata dell'attività professionale e lavorativa
aprono uno spazio nuovo al compito apostolico degli anziani: è un compito
da assumersi superando con decisione la tentazione di rifugiarsi
nostalgicamente in un passato che non ritorna più o di rifuggire da un
impegno presente per le difficoltà incontrate in un mondo dalle continue
novità; e prendendo sempre più chiara coscienza che il proprio ruolo
nella Chiesa e nella società non conosce affatto soste dovute all'età,
bensì conosce solo modi nuovi. Come dice il salmista: «Nella vecchiaia
daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto
è retto il Signore» (Sal 92, 15-16). Ripeto quanto ho detto
durante la celebrazione del Giubileo degli Anziani: «L'ingresso nella
terza età è da considerarsi un privilegio: non solo perché non tutti
hanno la fortuna di raggiungere questo traguardo, ma anche e soprattutto
perché questo è il periodo delle possibilità concrete di riconsiderare
meglio il passato, di conoscere e di vivere più profondamente il mistero
pasquale, di divenire esempio nella Chiesa a tutto il Popolo di Dio (...).
Nonostante la complessità dei vostri problemi da risolvere, le forze che
progressivamente si affievoliscono, e malgrado le insufficienze delle
organizzazioni sociali, i ritardi della legislazione ufficiale, le
incomprensioni di una società egoistica, voi non siete né dovete
sentirvi ai margini della vita della Chiesa, elementi passivi di un mondo
in eccesso di movimento, ma soggetti attivi di un periodo umanamente e
spiritualmente fecondo dell'esistenza umana. Avete ancora una missione da
compiere, un contributo da dare. Secondo il progetto divino ogni singolo
essere umano è una vita in crescita, dalla prima scintilla dell'esistenza
fino all'ultimo respiro»(175). Donne e uomini 49. I Padri sinodali hanno riservato una speciale attenzione alla
condizione e al ruolo della donna, secondo un duplice intento: riconoscere
e invitare a riconoscere, da parte di tutti ed ancora una volta,
l'indispensabile contributo della donna all'edificazione della Chiesa e
allo sviluppo della società; operare, inoltre, un'analisi più specifica
circa la partecipazione della donna alla vita e alla missione della
Chiesa. Riferendosi a Giovanni XXIII, che vide nella coscienza femminile
della propria dignità e nell'ingresso delle donne nella vita pubblica un
segno dei nostri tempi(176), i Padri del Sinodo hanno affermato
ripetutamente e fortemente, di fronte alle forme più varie di
discriminazioni e di emarginazioni alle quali soggiace la donna a motivo
del suo semplice essere donna, l'urgenza di difendere e di promuovere la dignità
personale della donna, e quindi la sua eguaglianza con l'uomo. Se di tutti nella Chiesa e nella società è questo compito, lo è
in particolare delle donne, che si devono sentire impegnate come
protagoniste in prima linea. C'è ancora tanto sforzo da compiere, in più
parti del mondo e in diversi ambiti, perché sia distrutta quella ingiusta
e deleteria mentalità che considera l'essere umano come una cosa, come un
oggetto di compra-vendita, come uno strumento dell'interesse egoistico o
del solo piacere, tanto più che di tale mentalità la prima vittima è
proprio la donna stessa. Al contrario, solo l'aperto riconoscimento della
dignità personale della donna costituisce il primo passo da compiere per
promuoverne la piena partecipazione sia alla vita ecclesiale che a quella
sociale e pubblica. Si deve dare risposta più ampia e decisiva alla
richiesta fatta dall'Esortazione Familiaris consortio circa le
molteplici discriminazioni delle quali le donne sono vittime: «che da
parte di tutti si svolga un'azione pastorale specifica più vigorosa e
incisiva, affinché esse siano definitivamente vinte, così da giungere
alla stima piena dell'immagine di Dio che risplende in tutti gli esseri
umani, nessuno escluso»(177). Nella stessa linea i Padri sinodali hanno
affermato: «La Chiesa, come espressione della sua missione, deve opporsi
con fermezza contro tutte le forme di discriminazione e di abuso delle
donne»(178). E ancora: «La dignità della donna, gravemente ferita
nell'opinione pubblica, dev'essere ricuperata per mezzo dell'effettivo
rispetto dei diritti della persona umana e per mezzo della pratica della
dottrina della Chiesa»(179). In particolare, circa la partecipazione attiva e responsabile
alla vita e alla missione della Chiesa, è da rilevarsi come già il
Concilio Vaticano II sia stato oltre modo esplicito nel sollecitarla: «Poiché
ai nostri giorni le donne prendono sempre più parte attiva in tutta la
vita della società, è di grande importanza una loro più larga
partecipazione anche nei vari campi dell'apostolato della Chiesa»(180). La coscienza che la donna, con i doni e i compiti propri, ha una
sua specifica vocazione è andata crescendo e approfondendosi nel
periodo post-conciliare, ritrovando la sua ispirazione più originale nel
Vangelo e nella storia della Chiesa. Per il credente, infatti, il Vangelo,
ossia la parola e l'esempio di Gesù Cristo, rimane il punto di
riferimento necessario e decisivo: ed è quanto mai fecondo ed innovativo
anche per l'attuale momento storico. Pur non chiamate all'apostolato proprio dei Dodici, e quindi al
sacerdozio ministeriale, molte donne accompagnano Gesù nel suo ministero
e assistono il gruppo degli Apostoli (cf. Lc 8, 2-3); sono presenti
sotto la Croce (cf. Lc 23, 49); assistono alla sepoltura di Gesù
(cf. Lc 23, 55) e il mattino di Pasqua ricevono e trasmettono
l'annuncio della risurrezione (cf. Lc 24, 1-10); pregano con gli
Apostoli nel Cenacolo nell'attesa della Pentecoste (cf. At 1, 14). Nella scia del Vangelo, la Chiesa delle origini si distacca dalla
cultura del tempo e chiama la donna a compiti connessi con
l'evangelizzazione. Nelle sue Lettere l'apostolo Paolo ricorda, anche per
nome, numerose donne per le loro varie funzioni all'interno e al servizio
delle prime comunità ecclesiali (cf. Rom 16, 1-15; Fil 4,
2-3; Col 4, 15 e 1 Cor 11, 5; 1 Tim 5, 16). «Se la
testimonianza degli Apostoli fonda la Chiesa _ ha detto Paolo VI _, quella
delle donne contribuisce grandemente a nutrire la fede delle comunità
cristiane»(181). E come alle origini, così nello sviluppo successivo la Chiesa ha
sempre conosciuto, anche se in differenti modi e con accentuazioni
diverse, donne che hanno esercitato un ruolo talvolta decisivo e svolto
compiti di valore considerevole per la Chiesa stessa. E' una storia
d'immensa operosità, il più delle volte umile e nascosta ma non per
questo meno decisiva per la crescita e per la santità della Chiesa. E'
necessario che questa storia sia continuata, anzi che si allarghi e si
intensifichi di fronte all'accresciuta e universalizzata consapevolezza
della dignità personale della donna e della sua vocazione, nonché di
fronte all'urgenza di una «nuova evangelizzazione» e di una maggiore «umanizzazione»
delle relazioni sociali. Raccogliendo la consegna del Concilio Vaticano II, nella quale si
specchia il messaggio del Vangelo e della storia della Chiesa, i Padri del
Sinodo hanno formulato, tra le altre, questa precisa «raccomandazione»:
«E' necessario che la Chiesa, per la sua vita e la sua missione,
riconosca tutti i doni delle donne e degli uomini e li traduca in pratica»(182).
E ancora: «Questo Sinodo proclama che la Chiesa esige il riconoscimento e
l'utilizzazione di tutti questi doni, esperienze e attitudini degli uomini
e delle donne perché la sua missione risulti più efficace (cf.
Congregazione per la Dottrina della Fede, Instructio de libertate
christiana et liberatione, 72)»(183). Fondamenti antropologici e teologici 50. La condizione per assicurare la giusta presenza della donna
nella Chiesa e nella società è una considerazione più penetrante e
accurata dei fondamenti antropologici della condizione maschile e
femminile, destinata a precisare l'identità personale propria della
donna nel suo rapporto di diversità e di reciproca complementarietà con
l'uomo, non solo per quanto riguarda i ruoli da tenere e le funzioni da
svolgere, ma anche e più profondamente per quanto riguarda la sua
struttura e il suo significato personale. I Padri sinodali hanno sentito
vivamente questa esigenza affermando che «i fondamenti antropologici e
teologici hanno bisogno di studi approfonditi per la risoluzione dei
problemi relativi al vero significato e alla dignità di ambedue i sessi»(184). Impegnandosi nella riflessione sui fondamenti antropologici e
teologici della condizione femminile, la Chiesa si rende presente nel
processo storico dei vari movimenti di promozione della donna e, scendendo
alle radici stesse dell'essere personale della donna, vi apporta il suo
contributo più prezioso. Ma prima e più ancora la Chiesa intende, in tal
modo, obbedire a Dio che, creando l'uomo «a sua immagine», «maschio e
femmina li creò» (Gen 1, 27); così come intende accogliere la
chiamata di Dio a conoscere, ad ammirare e a vivere il suo disegno. E' un
disegno che «al principio» è stato indelebilmente impresso nello stesso
essere della persona umana _ uomo e donna _ e, pertanto, nelle sue
strutture significative e nei suoi profondi dinamismi. Proprio questo
disegno, sapientissimo e amoroso, chiede di essere esplorato in tutta la
ricchezza del suo contenuto: è la ricchezza che dal «principio» si è
venuta poi progressivamente manifestando e attuando lungo l'intera storia
della salvezza, ed è culminata nella «pienezza del tempo», allorquando
«Dio mandò il suo Figlio, nato da donna» (Gal 4, 4). Quella
«pienezza» continua nella storia: la lettura del disegno di Dio sulla
donna è incessantemente operata e da operarsi nella fede della Chiesa,
anche grazie alla vita vissuta di tante donne cristiane. Senza dimenticare
l'aiuto che può venire dalle diverse scienze umane e dalle varie culture:
queste, grazie ad un illuminato discernimento, potranno aiutare a cogliere
e a precisare i valori e le esigenze che appartengono all'essenza perenne
della donna e quelli legati all'evolversi storico delle culture stesse.
Come ci ricorda il Concilio Vaticano II, «la Chiesa afferma che al di
sotto di tutti i mutamenti ci sono molte cose che non cambiano: esse
trovano il loro ultimo fondamento in Cristo, che è sempre lo stesso:
ieri, oggi e nei secoli (cf. Ebr 13, 8)»(185). Sui fondamenti antropologici e teologici della dignità personale
della donna si sofferma la Lettera Apostolica sulla dignità e sulla
vocazione della donna. Il documento, che riprende, prosegue e specifica le
riflessioni della catechesi del mercoledì dedicata per lungo tempo alla
«teologia del corpo», vuole essere insieme l'adempimento di una promessa
fatta nell'Enciclica Redemptoris Mater(186) e la risposta alla
richiesta dei Padri sinodali. La lettura della Lettera Mulieris dignitatem, anche per il
suo carattere di meditazione biblicoteologica, potrà stimolare tutti,
uomini e donne, e in particolare i cultori delle scienze umane e delle
discipline teologiche, a proseguire nello studio critico così da
approfondire sempre meglio, sulla base della dignità personale dell'uomo
e della donna e della loro reciproca relazione, i valori ed i doni
specifici della femminilità e della mascolinità, non solo nell'ambito
del vivere sociale ma anche e soprattutto in quello dell'esistenza
cristiana ed ecclesiale. La meditazione sui fondamenti antropologici e teologici della
donna deve illuminare e guidare la risposta cristiana alla domanda così
frequente, e talvolta così acuta, circa lo «spazio» che la donna può
e deve avere nella Chiesa e nella società. Dalla parola e dall'atteggiamento di Cristo, che sono normativi
per la Chiesa, risulta con grande chiarezza che nessuna discriminazione
esiste sul piano del rapporto con Cristo, nel quale «non c'è più uomo né
donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3, 28) e
sul piano della partecipazione alla vita e alla santità della Chiesa,
come splendidamente attesta la profezia di Gioele realizzatasi con la
Pentecoste: «Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno
profeti i vostri figli e le vostre figlie» (Gl 3, 1; cf. At 2,
17 ss.). Come si legge nella Lettera Apostolica sulla dignità e sulla
vocazione della donna, «tutt'e due _ la donna come l'uomo _ (...) sono
suscettibili in eguale misura dell'elargizione della verità divina e
dell'amore nello Spirito Santo. Ambedue accolgono le sue
"visite" salvifiche e santificanti»(187). Missione nella Chiesa e nel mondo 51. Circa poi la partecipazione alla missione apostolica della
Chiesa, non c'è dubbio che, in forza del Battesimo e della Cresima, la
donna _ come l'uomo _ è resa partecipe del triplice ufficio di Gesù
Cristo Sacerdote, Profeta, Re, e quindi è abilitata e impegnata
all'apostolato fondamentale della Chiesa: l'evangelizzazione. D'altre
parte, proprio nel compimento di questo apostolato, la donna è chiamata a
mettere in opera i suoi «doni» propri: anzitutto, il dono che è la sua
stessa dignità personale, mediante la parola e la testimonianza di vita;
i doni, poi, connessi con la sua vocazione femminile. Nella partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa la
donna non può ricevere il sacramento dell'Ordine e, pertanto, non
può compiere le funzioni proprie del sacerdozio ministeriale. E' questa
una disposizione che la Chiesa ha sempre ritrovato nella precisa volontà,
totalmente libera e sovrana, di Gesù Cristo che ha chiamato solo uomini
come suoi apostoli(188); una disposizione che può trovare luce nel
rapporto tra Cristo Sposo e la Chiesa Sposa(189). Siamo nell'ambito della funzione,
non della dignità e della santità. Si deve, in realtà,
affermare: «Anche se la Chiesa possiede una struttura
"gerarchica", tuttavia tale struttura è totalmente ordinata
alla santità delle membra di Cristo»(190). Ma, come già diceva Paolo VI, se «noi non possiamo cambiare il
comportamento di nostro Signore né la chiamata da Lui rivolta alle donne,
però dobbiamo riconoscere e promuovere il ruolo delle donne nella
missione evangelizzatrice e nella vita della comunità cristiana»(191). E' del tutto necessario passare dal riconoscimento teorico della
presenza attiva e responsabile della donna nella Chiesa alla realizzazione
pratica. E in questo preciso senso deve leggersi la presente
Esortazione che si rivolge ai fedeli laici, con la deliberata e ripetuta
specificazione «uomini e donne». Inoltre il nuovo Codice di Diritto
Canonico contiene molteplici disposizioni sulla partecipazione della donna
alla vita e alla missione della Chiesa: sono disposizioni che esigono
d'essere più comunemente conosciute e, sia pure secondo le diverse
sensibilità culturali e opportunità pastorali, attuate con maggiore
tempestività e risoluzione. Si pensi, ad esempio, alla partecipazione delle donne ai Consigli
pastorali diocesani e parrocchiali, come pure ai Sinodi diocesani e ai
Concili particolari. In questo senso i Padri sinodali hanno scritto: «Le
donne partecipino alla vita della Chiesa senza alcuna discriminazione,
anche nelle consultazioni e nell'elaborazione di decisioni»(192). E
ancora: «Le donne, le quali hanno già una grande importanza nella
trasmissione della fede e nel prestare servizi di ogni genere nella vita
della Chiesa, devono essere associate alla preparazione dei documenti
pastorali e delle iniziative missionarie e devono essere riconosciute come
cooperatrici della missione della Chiesa nella famiglia, nella professione
e nella comunità civile»(193). Nell'ambito più specifico dell'evangelizzazione e della catechesi
è da promuovere con più forza il compito particolare che la donna ha
nella trasmissione della fede, non solo nella famiglia ma anche nei più
diversi luoghi educativi e, in termini più ampi, in tutto ciò che
riguarda l'accoglienza della Parola di Dio, la sua comprensione e la sua
comunicazione, anche mediante lo studio, la ricerca e la docenza
teologica. Mentre adempirà il suo impegno di evangelizzazione, la donna
sentirà più vivo il bisogno di essere evangelizzata. Così, con gli
occhi illuminati dalla fede (cf. Ef 1, 18), la donna potrà
distinguere ciò che veramente risponde alla sua dignità personale e alla
sua vocazione da tutto ciò che, magari sotto il pretesto di questa «dignità»
e nel nome della «libertà» e del «progresso», fa sì che la donna non
serva al consolidamento dei veri valori ma, al contrario, diventi
responsabile del degrado morale delle persone, degli ambienti e della
società. Operare un simile «discernimento» è un'urgenza storica
indilazionabile e, nello stesso tempo, è una possibilità e un'esigenza
che derivano dalla partecipazione all'ufficio profetico di Cristo e della
sua Chiesa da parte della donna cristiana. Il «discernimento», di cui
parla più volte l'apostolo Paolo, non è solo valutazione delle realtà e
degli avvenimenti alla luce della fede; è anche decisione concreta e
impegno operativo, non solo nell'ambito della Chiesa ma anche in quello
della società umana. Si può dire che tutti i problemi del mondo contemporaneo, di cui
già parlava la seconda parte della Costituzione conciliare Gaudium et
spes e che il tempo non ha affatto né risolto né attutito, devono
vedere le donne presenti e impegnate, e precisamente con il loro
contributo tipico e insostituibile. In particolare, due grandi compiti affidati alla donna meritano di
essere riproposti all'attenzione di tutti. Il compito, anzitutto, di dare piena dignità alla vita
matrimoniale e alla maternità. Nuove possibilità si aprono oggi alla
donna per una comprensione più profonda e per una realizzazione più
ricca dei valori umani e cristiani implicati nella vita coniugale e
nell'esperienza della maternità: l'uomo stesso _ il marito e il padre _
può superare forme di assenteismo o di presenza episodica e parziale,
anzi può coinvolgersi in nuove e significative relazioni di comunione
interpersonale, proprio grazie all'intervento intelligente, amorevole e
decisivo della donna. Il compito, poi, di assicurare la dimensione morale della
cultura, la dimensione cioè di una cultura degna dell'uomo, della
sua vita personale e sociale. Il Concilio Vaticano II sembra collegare la
dimensione morale della cultura con la partecipazione dei laici alla
missione regale di Cristo: «I laici, anche mettendo in comune la loro
forza, risanino le istituzioni e le condizioni di vita del mondo, se ve ne
sono che spingono i costumi al peccato, così che tutte siano rese
conformi alle norme della giustizia e, anziché ostacolare, favoriscano
l'esercizio delle virtù. Così agendo impregneranno di valore morale la
cultura e i lavori dell'uomo»(194). Man mano che la donna partecipa attivamente e responsabilmente
alla funzione delle istituzioni, dalle quali dipende la salvaguardia del
primato dovuto ai valori umani nella vita delle comunità politiche, le
parole del Concilio ora citate indicano un importante campo d'apostolato
della donna: in tutte le dimensioni della vita di queste comunità, dalla
dimensione socio-economica a quella socio-politica, devono essere
rispettate e promosse la dignità personale della donna e la sua specifica
vocazione: nell'ambito non solo individuale ma anche comunitario, non solo
in forme lasciate alla libertà responsabile delle persone ma anche in
forme garantite da leggi civili giuste. «Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto a lui
simile» (Gen 2, 18). Alla donna Dio Creatore ha affidato
l'uomo. Certo, l'uomo è stato affidato ad ogni uomo, ma in modo
particolare alla donna, perché proprio la donna sembra avere una specifica
sensibilità, grazie alla speciale esperienza della sua maternità, per
l'uomo e per tutto ciò che costituisce il suo vero bene, a cominciare
dal fondamentale valore della vita. Quanto grandi sono le possibilità e
le responsabilità della donna in questo campo, in un tempo nel quale lo
sviluppo della scienza e della tecnica non è sempre ispirato e misurato
dalla vera sapienza, con l'inevitabile rischio di «disumanizzare» la
vita umana, soprattutto quando essa esigerebbe amore più intenso e più
generosa accoglienza. La partecipazione della donna alla vita della Chiesa e della
società, mediante i suoi doni, costituisce insieme la strada necessaria
per la sua realizzazione personale _ sulla quale oggi giustamente tanto si
insiste _ e il contributo originale della donna all'arricchimento della
comunione ecclesiale e al dinamismo apostolico del Popolo di Dio. In questa prospettiva si deve considerare la presenza anche
dell'uomo, insieme alla donna. Compresenza e collaborazione degli uomini e delle donne 52. Non è mancata nell'aula sinodale la voce di quanti hanno
espresso il timore che un'eccessiva insistenza portata sulla condizione e
sul ruolo delle donne potesse sfociare in un'inaccettabile dimenticanza:
quella, appunto, riguardante gli uomini. In realtà diverse
situazioni ecclesiali devono lamentare l'assenza o la troppo scarsa
presenza degli uomini, una parte dei quali abdica alle proprie
responsabilità ecclesiali, lasciando che siano assolte soltanto dalle
donne: così, ad esempio, la partecipazione alla preghiera liturgica in
Chiesa, l'educazione e in particolare la catechesi ai propri figli e ad
altri fanciulli, la presenza ad incontri religiosi e culturali, la
collaborazione ad iniziative caritative e missionarie. E' allora da urgere pastoralmente la presenza coordinata degli
uomini e delle donne perché sia resa più completa, armonica e ricca la
partecipazione dei fedeli laici alla missione salvifica della Chiesa. La ragione fondamentale che esige e spiega la compresenza e la
collaborazione degli uomini e delle donne non è solo, come ora si è
rilevato, la maggiore significatività ed efficacia dell'azione pastorale
della Chiesa; né, tanto meno, il semplice dato sociologico di una
convivenza umana che è naturalmente fatta di uomini e di donne. E',
piuttosto, il disegno originario del Creatore che dal «principio» ha
voluto l'essere umano come «unità dei due», ha voluto l'uomo e la donna
come prima comunità di persone, radice di ogni altra comunità, e, nello
stesso tempo, come «segno» di quella comunione interpersonale d'amore
che costituisce la misteriosa vita intima di Dio Uno e Trino. Proprio per questo il modo più comune e capillare, e nello stesso
tempo fondamentale, per assicurare questa presenza coordinata e armonica
di uomini e di donne nella vita e nella missione della Chiesa, è
l'esercizio dei compiti e delle responsabilità della coppia e della
famiglia cristiana, nel quale traspare e si comunica la varietà delle
diverse forme di amore e di vita: la forma coniugale, paterna e materna,
filiale e fraterna. Leggiamo nell'Esortazione Familiaris consortio: «Se
la famiglia cristiana è comunità, i cui vincoli sono rinnovati da Cristo
mediante la fede e i sacramenti, la sua partecipazione alla missione della
Chiesa deve avvenire secondo una modalità comunitaria: insieme,
dunque i coniugi in quanto coppia, i genitori e i figli in
quanto famiglia, devono vivere il loro servizio alla Chiesa e al mondo
(...). La famiglia cristiana, poi, edifica il Regno di Dio nella storia
mediante quelle stesse realtà quotidiane che riguardano e
contraddistinguono la sua condizione di vita: è allora nell'amore
coniugale e familiare _ vissuto nella sua straordinaria ricchezza di
valori ed esigenze di totalità, unicità, fedeltà e fecondità _ che si
esprime e si realizza la partecipazione della famiglia cristiana alla
missione profetica, sacerdotale e regale di Gesù Cristo e della sua
Chiesa»(195). Situandosi in questa prospettiva, i Padri sinodali hanno ricordato
il significato che il sacramento del Matrimonio deve assumere nella Chiesa
e nella società per illuminare e ispirare tutte le relazioni tra l'uomo e
la donna. In tal senso hanno ribadito «l'urgente necessità che ciascun
cristiano viva e annunci il messaggio di speranza contenuto nella
relazione tra l'uomo e la donna Il sacramento del Matrimonio, che consacra
questa relazione nella sua forma coniugale e la rivela come segno della
relazione di Cristo con la sua Chiesa, contiene un insegnamento di grande
importanza per la vita della Chiesa; questo insegnamento deve arrivare per
mezzo della Chiesa al mondo di oggi; tutte le relazioni tra l'uomo e la
donna debbono ispirarsi a questo spirito. La Chiesa deve utilizzare queste
ricchezze ancora più pienamente»(196). Gli stessi Padri hanno
giustamente rilevato che «la stima della verginità e il rispetto della
maternità debbono ambedue essere ricuperate»(197): ancora una volta per
lo sviluppo di vocazioni diverse e complementari nel contesto vivo della
comunione ecclesiale e al servizio della sua continua crescita. Malati e sofferenti 53. L'uomo è chiamato alla gioia ma fa quotidiana esperienza di
tantissime forme di sofferenza e di dolore. Agli uomini e alle donne
colpiti dalle più varie forme di sofferenza e di dolore i Padri sinodali
si sono rivolti nel loro finale Messaggio con queste parole: «Voi
abbandonati ed emarginati dalla nostra società consumistica; voi malati,
handicappati, poveri, affamati, emigranti, profughi, prigionieri,
disoccupati, anziani, bambini abbandonati e persone sole; voi, vittime
della guerra e di ogni violenza emananti dalla nostra società permissiva.
La Chiesa partecipa alla vostra sofferenza conducente al Signore, che vi
associa alla sua Passione redentrice e vi fa vivere alla luce della sua
Redenzione. Contiamo su di voi per insegnare al mondo intero che cosa è
l'amore. Faremo tutto il possibile perché troviate il posto di cui avete
diritto nella società e nella Chiesa»(198). Nel contesto di un mondo sconfinato come quello della sofferenza
umana, rivolgiamo ora l'attenzione a quanti sono colpiti dalla malattia
nelle sue diverse forme: i malati, infatti, sono l'espressione più
frequente e più comune del soffrire umano. A tutti e a ciascuno è rivolto l'appello del Signore: anche i
malati sono mandati come operai nella sua vigna. Il peso, che affatica
le membra del corpo e scuote la serenità dell'anima, lungi dal
distoglierli dal lavorare nella vigna, li chiama a vivere la loro
vocazione umana e cristiana ed a partecipare alla crescita del Regno di
Dio in modalità nuove, anche più preziose. Le parole
dell'apostolo Paolo devono divenire il loro programma e, prima ancora,
sono luce che fa splendere ai loro occhi il significato di grazia della
loro stessa situazione: «Completo quello che manca ai patimenti di Cristo
nella mia carne, in favore del suo corpo, che è la Chiesa» (Col
1, 24). Proprio facendo questa scoperta, l'apostolo è approdato
alla gioia: «Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi» (Col
1, 24). Similmente molti malati possono diventare portatori della «gioia
dello Spirito Santo in molte tribolazioni» (1 Tess 1, 6) ed
essere testimoni della Risurrezione di Gesù. Come ha espresso un
handicappato nel suo intervento in aula sinodale, «è di grande
importanza porre in luce il fatto che i cristiani che vivono in situazioni
di malattia, di dolore e di vecchiaia, non sono invitati da Dio soltanto
ad unire il proprio dolore con la Passione di Cristo, ma anche ad
accogliere già ora in se stessi e a trasmettere agli altri la forza del
rinnovamento e la gioia di Cristo risuscitato (cf. 2 Cor 4, 10-11;
1 Pt 4, 13; Rm 8, 18 ss.)»(199). Da parte sua _ come si
legge nella Lettera Apostolica Salvifici doloris _ «la Chiesa, che
nasce dal mistero della redenzione nella Croce di Cristo, è tenuta a cercare
l'incontro con l'uomo in modo particolare sulla via della sofferenza.
In un tale incontro l'uomo "diventa la via della Chiesa", ed è,
questa, una delle vie più importanti»(200). Ora l'uomo sofferente è
via della Chiesa perché egli è, anzitutto, via di Cristo stesso, il
buon Samaritano che «non passa oltre», ma «ne ha compassione, si fa
vicino (...) gli fascia le ferite (...) si prende cura di lui» (Lc 10,
32-34). La comunità cristiana ha ritrascritto, di secolo in secolo
nell'immensa moltitudine delle persone malate e sofferenti, la parabola
evangelica del buon Samaritano, rivelando e comunicando l'amore di
guarigione e di consolazione di Gesù Cristo. Ciò è avvenuto mediante la
testimonianza della vita religiosa consacrata al servizio degli ammalati e
mediante l'infaticabile impegno di tutti gli operatori sanitari. Oggi,
anche negli stessi ospedali e case di cura cattolici si fa sempre più
numerosa, e talvolta anche totale ed esclusiva, la presenza dei fedeli
laici, uomini e donne: proprio loro, medici, infermieri, altri operatori
della salute, volontari, sono chiamati ad essere l'immagine viva di Cristo
e della sua Chiesa nell'amore verso i malati e i sofferenti. Azione pastorale rinnovata 54. E' necessario che questa preziosissima eredità, che la Chiesa
ha ricevuto da Gesù Cristo «medico di carne e di spirito»(201), non
solo non venga mai meno, ma sia sempre più valorizzata e arricchita
attraverso una ripresa e un rilancio deciso di un'azione
pastorale per e con i malati e i sofferenti. Dev'essere un'azione
capace di sostenere e di promuovere attenzione, vicinanza, presenza,
ascolto, dialogo, condivisione e aiuto concreto verso l'uomo nei momenti
nei quali, a causa della malattia e della sofferenza, sono messe a dura
prova non solo la sua fiducia nella vita ma anche la sua stessa fede in
Dio e nel suo amore di Padre. Questo rilancio pastorale ha la sua
espressione più significativa nella celebrazione sacramentale con e per
gli ammalati, come fortezza nel dolore e nella debolezza, come speranza
nella disperazione, come luogo d'incontro e di festa. Uno dei fondamentali obiettivi di questa rinnovata e intensificata
azione pastorale, che non può non coinvolgere e in modo coordinato tutte
le componenti della comunità ecclesiale, è di considerare il malato, il
portatore di handicap, il sofferente non semplicemente come termine
dell'amore e del servizio della Chiesa, bensì come soggetto attivo e
responsabile dell'opera di evangelizzazione e di salvezza. In questa
prospettiva la Chiesa ha una buona novella da far risuonare all'interno di
società e di culture che, avendo smarrito il senso del soffrire umano, «censurano»
ogni discorso su tale dura realtà della vita. E la buona novella sta
nell'annuncio che il soffrire può avere anche un significato positivo per
l'uomo e per la stessa società, chiamato com'è a divenire una forma di
partecipazione alla sofferenza salvifica di Cristo e alla sua gioia di
risorto, e pertanto una forza di santificazione e di edificazione della
Chiesa. L'annuncio di questa buona novella diventa credibile allorquando
non risuona semplicemente sulle labbra, ma passa attraverso la
testimonianza della vita, sia di tutti coloro che curano con amore i
malati, gli handicappati e i sofferenti, sia di questi stessi, resi sempre
più coscienti e responsabili del loro posto e del loro compito nella
Chiesa e per la Chiesa. Di grande utilità perché «la civiltà dell'amore» possa
fiorire e fruttificare nell'immenso mondo del dolore umano, potrà essere
la rinnovata meditazione della Lettera Apostolica Salvifici doloris, di
cui ricordiamo ora le righe conclusive: «Occorre pertanto, che sotto la
Croce del Calvario idealmente convengano tutti i sofferenti che credono in
Cristo e, particolarmente, coloro che soffrono a causa della loro fede in
lui Crocifisso e Risorto, affinché l'offerta delle loro sofferenze
affretti il compimento della preghiera dello stesso Salvatore per l'unità
di tutti (cf. Gv 17, 11. 21-22). Là pure convengano gli uomini di
buona volontà, perché sulla Croce sta il "Redentore
dell'uomo", l'Uomo dei dolori, che in sé ha assunto le sofferenze
fisiche e morali degli uomini di tutti i tempi, affinché nell'amore possano
trovare il senso salvifico del loro dolore e risposte valide a tutti i
loro interrogativi. Insieme con Maria, Madre di Cristo, che stava
sotto la Croce (cf. Gv 19, 25), ci fermiamo accanto a tutte le
croci dell'uomo d'oggi (...). E chiediamo a tutti voi, che soffrite, di
sostenerci. Proprio a voi, che siete deboli, chiediamo che diventiate
una sorgente di forza per la Chiesa e per l'umanità. Nel terribile
combattimento tra le forze del bene e del male, di cui ci offre spettacolo
il nostro mondo contemporaneo, vinca la vostra sofferenza in unione con la
Croce di Cristo!»(202). Stati di vita e vocazioni 55. Operai della vigna sono tutti i membri del Popolo di Dio: i
sacerdoti, i religiosi e le religiose, i fedeli laici, tutti ad un tempo
oggetto e soggetto della comunione della Chiesa e della partecipazione
alla sua missione di salvezza. Tutti e ciascuno lavoriamo nell'unica e
comune vigna del Signore con carismi e con ministeri diversi e
complementari. Già sul piano dell'essere, prima ancora che su quello
dell'agire, i cristiani sono tralci dell'unica feconda vite che è
Cristo, sono membra vive dell'unico Corpo del Signore edificato nella
forza dello Spirito. Sul piano dell'essere: non significa solo mediante la
vita di grazia e di santità, che è la prima e più rigogliosa sorgente
della fecondità apostolica e missionaria della santa Madre Chiesa; ma
significa anche mediante lo stato di vita che caratterizza i sacerdoti e i
diaconi, i religiosi e le religiose, i membri degli istituti secolari, i
fedeli laici. Nella Chiesa-Comunione gli stati di vita sono tra loro così
collegati da essere ordinati l'uno all'altro. Certamente comune, anzi
unico è il loro significato profondo: quello di essere modalità
secondo cui vivere l'eguale dignità cristiana e l'universale vocazione
alla santità nella perfezione dell'amore. Sono modalità insieme diverse
e complementari, sicché ciascuna di esse ha una sua originale e
inconfondibile fisionomia e nello stesso tempo ciascuna di esse si pone in
relazione alle altre e al loro servizio. Così lo stato di vita laicale ha nell'indole secolare la
sua specificità e realizza un servizio ecclesiale nel testimoniare e nel
richiamare, a suo modo, ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose il
significato che le realtà terrene e temporali hanno nel disegno salvifico
di Dio. A sua volta il sacerdozio ministeriale rappresenta la
permanente garanzia della presenza sacramentale, nei diversi tempi e
luoghi, di Cristo Redentore. Lo stato religioso testimonia l'indole
escatologica della Chiesa, ossia la sua tensione verso il Regno di Dio,
che viene prefigurato e in qualche modo anticipato e pregustato dai voti
di castità, povertà e obbedienza. Tutti gli stati di vita, sia nel loro insieme sia ciascuno di essi
in rapporto agli altri, sono al servizio della crescita della Chiesa, sono
modalità diverse che si unificano profondamente nel «mistero di
comunione» della Chiesa e che si coordinano dinamicamente nella sua unica
missione. In tal modo, l'unico e identico mistero della Chiesa rivela e
rivive, nella diversità degli stati di vita e nella varietà delle
vocazioni, l'infinita ricchezza del mistero di Gesù Cristo. Come
amano ripetere i Padri, la Chiesa è come un campo dall'affascinante e
meravigliosa varietà di erbe, piante, fiori e frutti. Sant'Ambrogio
scrive: «Un campo produce molti frutti, ma migliore è quello che abbonda
di frutti e di fiori. Orbene, il campo della santa Chiesa è fecondo degli
uni e degli altri. Qui puoi vedere le gemme della verginità metter fiori,
là la vedovanza dominare austera come le foreste nella pianura; altrove
la ricca mietitura delle nozze benedette dalla Chiesa riempire i grandi
granai del mondo di messe abbondante, e i torchi del Signore Gesù
ridondare come di frutti di vite rigogliosa, frutti dei quali sono ricche
le nozze cristiane»(203). Le varie vocazioni laicali 56. La ricca varietà della Chiesa trova una sua ulteriore
manifestazione all'interno di ciascun stato di vita. Così entro lo
stato di vita laicale si danno diverse «vocazioni», ossia diversi
cammini spirituali e apostolici che riguardano i singoli fedeli laici.
Nell'alveo d'una vocazione laicale «comune» fioriscono vocazioni laicali
«particolari». In questo ambito possiamo ricordare anche l'esperienza
spirituale che è maturata recentemente nella Chiesa con il fiorire di
diverse forme di Istituti secolari: ai fedeli laici, ma anche agli stessi
sacerdoti, è aperta la possibilità di professare i consigli evangelici
di povertà, castità e obbedienza per mezzo dei voti o delle promesse,
conservando pienamente la propria condizione laicale o clericale(204).
Come hanno rilevato i Padri sinodali, «lo Spirito Santo suscita anche
altre forme di offerta di se stessi cui si dedicano persone che rimangono
pienamente nella vita laicale»(205). Possiamo concludere rileggendo una bella pagina di San Francesco
di Sales, che tanto ha promosso la spiritualità dei laici(206). Parlando
della «devozione», ossia della perfezione cristiana o «vita secondo lo
Spirito», egli presenta in una maniera semplice e splendida la vocazione
di tutti i cristiani alla santità e nello stesso tempo la forma specifica
con cui i singoli cristiani la realizzano: «Nella creazione Dio comandò
alle piante di produrre i loro frutti, ognuna "secondo la propria
specie" (Gen 1, 11). Lo stesso comando rivolge ai cristiani,
che sono le piante vive della sua Chiesa, perché producano frutti di
devozione, ognuno secondo il suo stato e la sua condizione. La devozione
deve essere praticata in modo diverso dal gentiluomo, dall'artigiano, dal
domestico, dal principe, dalla vedova, dalla donna non sposata e da quella
coniugata. Ciò non basta, bisogna anche accordare la pratica della
devozione alle forze, agli impegni e ai doveri di ogni persona (...). E'
un errore, anzi un'eresia, voler escludere l'esercizio della devozione
dall'ambiente militare, dalla bottega degli artigiani, dalla corte dei
principi, dalle case dei coniugati. E' vero, Filotea, che la devozione
puramente contemplativa, monastica e religiosa può essere vissuta solo in
questi stati, ma, oltre a questi tre tipi di devozione, ve ne sono molti
altri capaci di rendere perfetti coloro che vivono in condizioni secolari.
Perciò, dovunque ci troviamo, possiamo e dobbiamo aspirare alla vita
perfetta»(207). Ponendosi nella stessa linea il Concilio Vaticano II scrive: «Questo
comportamento spirituale dei laici deve assumere una peculiare
caratteristica dallo stato di matrimonio e di famiglia, di celibato o di
vedovanza, dalla condizione di infermità, dall'attività professionale e
sociale. Non tralascino, dunque, di coltivare costantemente le qualità e
le doti ad essi conferite corrispondenti a tali condizioni, e di servirsi
dei propri doni ricevuti dallo Spirito Santo»(208). Ciò che vale delle vocazioni spirituali vale anche, e in un certo
senso a maggior ragione, delle infinite varie modalità secondo cui tutti
e singoli i membri della Chiesa sono operai che lavorano nella vigna del
Signore, edificando il Corpo mistico di Cristo. Veramente ciascuno è
chiamato per nome, nell'unicità e irripetibilità della sua storia
personale, a portare il suo proprio contributo per l'avvento del Regno di
Dio. Nessun talento, neppure il più piccolo, può essere nascosto e
lasciato inutilizzato (cf. Mt 25, 24-27). L'apostolo Pietro ci ammonisce: «Ciascuno viva secondo la grazia
ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di
una multiforme grazia di Dio» (1 Pt 4, 10). |
|
|
CAPITOLO V PERCHÉ PORTIATE PIÙ
FRUTTO Maturare in continuità 57. L'immagine evangelica della vite e dei tralci ci rivela un
altro aspetto fondamentale della vita e della missione dei fedeli laici: la
chiamata a crescere, a maturare in continuità, a portare sempre più
frutto. Come solerte vignaiolo, il Padre si prende cura della sua vigna.
La presenza premurosa di Dio è ardentemente invocata da Israele, che così
prega: «Dio degli eserciti, volgiti, / guarda dal cielo e vedi / e visita
questa vigna, / proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, / il
germoglio che ti sei coltivato» (Sal 80, 15-16). Gesù stesso
parla dell'opera del Padre: «Io sono la vera vite e il Padre mio è il
vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni
tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto» (Gv
15, 1-2). La vitalità dei tralci è legata al loro rimanere radicati nella
vite, che è Cristo Gesù: «Chi rimane in me e io in lui, fa molto
frutto, perché senza di me non potete far nulla» (Gv 15, 5). L'uomo è interpellato nella sua libertà dalla chiamata di Dio a
crescere, a maturare, a portare frutto. Non può non rispondere, non può
non assumersi la sua personale responsabilità. E' a questa responsabilità,
tremenda ed esaltante, che alludono le gravi parole di Gesù: «Chi non
rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo
raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano» (Gv 15, 6). In questo dialogo tra Dio che chiama e la persona interpellata
nella sua responsabilità si situa la possibilità, anzi la necessità di
una formazione integrale e permanente dei fedeli laici, alla quale i Padri
sinodali hanno giustamente riservato un'ampia parte del loro lavoro. In
particolare, dopo aver descritto la formazione cristiana come «un
continuo processo personale di maturazione nella fede e di configurazione
con il Cristo, secondo la volontà del Padre, con la guida dello Spirito
Santo», hanno chiaramente affermato che «la formazione dei fedeli laici
va posta tra le priorità della diocesi e va collocata nei
programmi di azione pastorale in modo che tutti gli sforzi della
comunità (sacerdoti, laici e religiosi) convergano a questo fine»(209). Scoprire e vivere la propria vocazione e missione 58. La formazione dei fedeli laici ha come obiettivo fondamentale
la scoperta sempre più chiara della propria vocazione e la disponibilità
sempre più grande a viverla nel compimento della propria missione. Dio chiama me e manda me come operaio nella sua
vigna; chiama me e manda me a lavorare per l'avvento del suo Regno nella
storia: questa vocazione e missione personale definisce la dignità e la
responsabilità dell'intera opera formativa, ordinata al riconoscimento
gioioso e grato di tale dignità e all'assolvimento fedele e generoso di
tale responsabilità. Infatti, Dio dall'eternità ha pensato a noi e ci ha amato come
persone uniche e irripetibili, chiamando ciascuno di noi con il suo
proprio nome, come il buon Pastore che «chiama le sue pecore per nome» (Gv
10, 3). Ma il piano eterno di Dio si rivela a ciascuno di noi solo nello
sviluppo storico della nostra vita e delle sue vicende, e pertanto solo
gradualmente: in un certo senso, di giorno in giorno. Ora per poter scoprire la concreta volontà del Signore sulla
nostra vita sono sempre indispensabili l'ascolto pronto e docile della
parola di Dio e della Chiesa, la preghiera filiale e costante, il
riferimento a una saggia e amorevole guida spirituale, la lettura nella
fede dei doni e dei talenti ricevuti e nello stesso tempo delle diverse
situazioni sociali e storiche entro cui si è inseriti. Nella vita di ciascun fedele laico ci sono poi momenti
particolarmente significativi e decisivi per discernere la chiamata di
Dio e per accogliere la missione da Lui affidata: tra questi ci sono i
momenti dell'adolescenza e della giovinezza. Nessuno però
dimentichi che il Signore, come il padrone con gli operai della vigna,
chiama _ nel senso di rendere concreta e puntuale la sua santa volontà _ a
tutte le ore della vita: per questo la vigilanza, quale attenzione
premurosa alla voce di Dio, è un atteggiamento fondamentale e permanente
del discepolo. Non si tratta, comunque, soltanto di sapere quello che Dio
vuole da noi, da ciascuno di noi nelle varie situazioni della vita.
Occorre fare quello che Dio vuole: così ci ricorda la parola di
Maria, la Madre di Gesù, rivolta ai servi di Cana: «Fate quello che vi
dirà» (Gv 2, 5). E per agire in fedeltà alla volontà di Dio
occorre essere capaci e rendersi sempre più capaci. Certo,
con la grazia del Signore, che non manca mai, come dice San Leone Magno:
«Darà il vigore Colui che conferì la dignità!»(210); ma anche con la
libera e responsabile collaborazione di ciascuno di noi. Ecco il compito meraviglioso e impegnativo che attende tutti i
fedeli laici, tutti i cristiani, senza sosta alcuna: conoscere sempre più
le ricchezze della fede e del Battesimo e viverle in crescente pienezza.
L'apostolo Pietro, parlando di nascita e di crescita come delle due tappe
della vita cristiana, ci esorta: «Come bambini appena nati, bramate il
puro latte spirituale, per crescere con esso verso la salvezza» (1
Pt 2, 2). Una formazione integrale da vivere in unità 59. Nello scoprire e nel vivere la propria vocazione e missione, i
fedeli laici devono essere formati a quell'unità di cui è segnato
il loro stesso essere di membri della Chiesa e di cittadini della
società umana. Nella loro esistenza non possono esserci due vite parallele: da
una parte, la vita cosiddetta «spirituale», con i suoi valori e con le
sue esigenze; e dall'altra, la vita cosiddetta «secolare», ossia la vita
di famiglia, di lavoro, dei rapporti sociali, dell'impegno politico e
della cultura. Il tralcio, radicato nella vite che è Cristo, porta i suoi
frutti in ogni settore dell'attività e dell'esistenza. Infatti, tutti i
vari campi della vita laicale rientrano nel disegno di Dio, che li vuole
come il «luogo storico» del rivelarsi e del realizzarsi della carità di
Gesù Cristo a gloria del Padre e a servizio dei fratelli. Ogni attività,
ogni situazione, ogni impegno concreto _ come, ad esempio, la competenza e
la solidarietà nel lavoro, l'amore e la dedizione nella famiglia e
nell'educazione dei figli, il servizio sociale e politico, la proposta
della verità nell'ambito della cultura _ sono occasioni provvidenziali
per un «continuo esercizio della fede, della speranza e della carità»(211). A questa unità di vita il Concilio Vaticano II ha invitato
tutti i fedeli laici denunciando con forza la gravità della frattura tra
fede e vita, tra Vangelo e cultura: «Il Concilio esorta i cristiani, che
sono cittadini dell'una e dell'altra città, di sforzarsi di compiere
fedelmente i propri doveri terreni, facendosi guidare dallo spirito del
Vangelo. Sbagliano coloro che, sapendo che qui non abbiamo una
cittadinanza stabile ma cerchiamo quella futura, pensano di poter per
questo trascurare i propri doveri terreni, e non riflettono che invece
proprio la fede li obbliga ancora di più a compierli, secondo la
vocazione di ciascuno (...). Il distacco, che si costata in molti, tra la
fede che professano e la loro vita quotidiana, va annoverato tra i più
gravi errori del nostro tempo»(212). Perciò ho affermato che una fede
che non diventa cultura è una fede «non pienamente accolta, non
interamente pensata non fedelmente vissuta»(213). Aspetti della formazione 60. Entro questa sintesi di vita si situano i molteplici e
coordinati aspetti della formazione integrale dei fedeli laici. Non c'è dubbio che la formazione spirituale debba occupare
un posto privilegiato nella vita di ciascuno, chiamato a crescere senza
sosta nell'intimità con Gesù Cristo, nella conformità alla volontà del
Padre, nella dedizione ai fratelli nella carità e nella giustizia. Scrive
il Concilio: «Questa vita d'intima unione con Cristo si alimenta nella
Chiesa con gli aiuti spirituali, che sono comuni a tutti i fedeli,
soprattutto con la partecipazione attiva alla sacra Liturgia, e questi
aiuti i laici devono usarli in modo che, mentre compiono con rettitudine
gli stessi doveri del mondo nelle condizioni ordinarie di vita, non
separino dalla propria vita l'unione con Cristo, ma, svolgendo la propria
attività secondo il volere divino, crescano in essa»(214). Sempre più urgente si rivela oggi la formazione dottrinale dei
fedeli laici, non solo per il naturale dinamismo di approfondimento della
loro fede, ma anche per l'esigenza di «rendere ragione della speranza»
che è in loro di fronte al mondo e ai suoi gravi e complessi problemi. Si rendono così assolutamente necessarie una sistematica azione
di catechesi, da graduarsi in rapporto all'età e alle diverse
situazioni di vita, e una più decisa promozione cristiana della cultura,
come risposta agli eterni interrogativi che agitano l'uomo e la società
d'oggi. In particolare, soprattutto per i fedeli laici variamente
impegnati nel campo sociale e politico, è del tutto indispensabile una
conoscenza più esatta della dottrina sociale della Chiesa, come
ripetutamente i Padri sinodali hanno sollecitato nei loro interventi.
Parlando della partecipazione politica dei fedeli laici, si sono così
espressi: «Perché i laici possano realizzare attivamente questo nobile
proposito nella politica (ossia il proposito di far riconoscere e stimare
i valori umani e cristiani), non bastano le esortazioni, ma bisogna
offrire loro la dovuta formazione della coscienza sociale, specialmente
nella dottrina sociale della Chiesa, la quale contiene i principi di
riflessione, i criteri di giudizio e le direttrici pratiche (cf.
Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione su libertà cristiana
e liberazione, 72). Tale dottrina deve essere già presente nella
istruzione catechistica generale, negli incontri specializzati e nelle
scuole ed università. Questa dottrina sociale della Chiesa è, tuttavia,
dinamica, cioè adattata alle circostanze dei tempi e dei luoghi. E'
diritto e dovere dei pastori proporre i principi morali anche sull'ordine
sociale; è dovere di tutti i cristiani dedicarsi alla difesa dei diritti
umani; tuttavia, la partecipazione attiva nei partiti politici è
riservata ai laici»(215). E, infine, nel contesto della formazione integrale e unitaria dei
fedeli laici, è particolarmente significativa per la loro azione
missionaria e apostolica la personale crescita nei valori umani. Proprio
in questo senso il Concilio ha scritto: «(i laici) facciano pure gran
conto della competenza professionale, del senso della famiglia e del senso
civico e di quelle virtù che riguardano i rapporti sociali, cioè la
probità, lo spirito di giustizia, la sincerità, la cortesia, la fortezza
d'animo, senza le quali non ci può essere neanche vera vita cristiana»(216). Nel maturare la sintesi organica della loro vita, che insieme è
espressione dell'unità del loro essere e condizione per l'efficace
compimento della loro missione, i fedeli laici saranno interiormente
guidati e sostenuti dallo Spirito Santo, quale Spirito di unità e di
pienezza di vita. Collaboratori di Dio educatore 61. Quali sono i luoghi e i mezzi della formazione dei fedeli
laici? Quali sono le persone e le comunità chiamate ad assumersi
il compito della formazione integrale e unitaria dei fedeli laici? Come l'opera educativa umana è intimamente congiunta con la
paternità e la maternità, così la formazione cristiana trova la sua
radice e la sua forza in Dio, il Padre che ama ed educa i suoi figli. Sì,
Dio è il primo e grande educatore del suo Popolo, come dice lo
stupendo passo del Cantico di Mosè: «Egli lo trovò in terra deserta, /
in una landa di ululati solitari. / Lo circondò, lo allevò, / lo custodì
come pupilla del suo occhio. / Come un'aquila che veglia la sua nidiata, /
che vola sopra i suoi nati, / egli spiegò le sue ali e lo prese, / lo
sollevò sulle sue ali. / Il Signore lo guidò da solo, / non c'era con
lui alcun dio straniero» (Deut 32, 10-12; cf. 8, 5). L'opera educativa di Dio si rivela e si compie in Gesù, il
Maestro, e raggiunge dal di dentro il cuore d'ogni uomo grazie alla
presenza dinamica dello Spirito. A prendere parte all'opera educativa
divina è chiamata la Chiesa madre, sia in se stessa, sia nelle sue
varie articolazioni ed espressioni. E' così che i fedeli laici sono
formati dalla Chiesa e nella Chiesa, in una reciproca comunione e
collaborazione di tutti i suoi membri: sacerdoti, religiosi e fedeli
laici. Così l'intera comunità ecclesiale, nei suoi diversi membri,
riceve la fecondità dello Spirito e ad essa coopera attivamente. In tal
senso Metodio di Olimpo scriveva: «Gli imperfetti (...) sono portati e
formati, come nel seno di una madre, dai più perfetti finché siano
generati e partoriti per la grandezza e la bellezza della virtù»(217),
come avvenne per Paolo, portato e introdotto nella Chiesa dai perfetti
(nella persona di Anania) e diventato poi a sua volta perfetto e fecondo
di tanti figli. Educatrice è, anzi tutto, la Chiesa universale, nella
quale il Papa svolge il ruolo di primo formatore dei fedeli laici. A lui,
come successore di Pietro, spetta il ministero di «confermare nella fede
i fratelli», insegnando a tutti i credenti i contenuti essenziali della
vocazione e missione cristiana ed ecclesiale. Non solo la sua parola
diretta, ma anche la sua parola veicolata dai documenti dei vari Dicasteri
della Santa Sede chiede l'ascolto docile e amoroso dei fedeli laici. La Chiesa una e universale è presente nelle varie parti del mondo
nelle Chiese particolari. In ognuna di esse il Vescovo ha una
responsabilità personale nei riguardi dei fedeli laici, che deve formare
mediante l'annuncio della Parola, la celebrazione dell'Eucaristia e dei
sacramenti, l'animazione e la guida della loro vita cristiana. Entro la Chiesa particolare o diocesi si situa ed opera la parrocchia,
la quale ha un compito essenziale per la formazione più immediata e
personale dei fedeli laici. Infatti, in un rapporto che può raggiungere
più facilmente le singole persone e i singoli gruppi, la parrocchia è
chiamata a educare i suoi membri all'ascolto della Parola, al dialogo
liturgico e personale con Dio, alla vita di carità fraterna, facendo
percepire in modo più diretto e concreto il senso della comunione
ecclesiale e della responsabilità missionaria. All'interno poi di talune parrocchie, soprattutto se vaste e
disperse, le piccole comunità ecclesiali presenti possono essere
di notevole aiuto nella formazione dei cristiani, potendo rendere più
capillari e incisive la coscienza e l'esperienza della comunione e della
missione ecclesiale. Un aiuto può essere dato, come hanno detto i Padri
sinodali, anche da una catechesi postbattesimale a modo di catecumenato,
mediante la riproposizione di alcuni elementi del «Rituale
dell'Iniziazione Cristiana degli Adulti», destinati a far cogliere e
vivere le immense e straordinarie ricchezze e responsabilità del
Battesimo ricevuto(218). Nella formazione che i fedeli laici ricevono nella diocesi e nella
parrocchia, in particolare al senso della comunione e della missione, di
speciale importanza è l'aiuto che i diversi membri della Chiesa
reciprocamente si danno: è un aiuto che insieme rivela e attua il mistero
della Chiesa Madre ed Educatrice. I sacerdoti e i religiosi devono aiutare
i fedeli laici nella loro formazione. In questo senso i Padri del Sinodo
hanno invitato i presbiteri e i candidati agli Ordini a «prepararsi
accuratamente ad essere capaci di favorire la vocazione e la missione dei
laici»(219). A loro volta, gli stessi fedeli laici possono e devono aiutare i
sacerdoti e i religiosi nel loro cammino spirituale e pastorale. Altri ambiti educativi 62 . Pure la famiglia cristiana, in quanto «Chiesa
domestica», costituisce una scuola nativa e fondamentale per la
formazione della fede: il padre e la madre ricevono dal sacramento del
Matrimonio la grazia e il ministero dell'educazione cristiana nei riguardi
dei figli, ai quali testimoniano e trasmettono insieme valori umani e
valori religiosi. Imparando le prime parole, i figli imparano anche a
lodare Dio, che sentono vicino come Padre amorevole e provvidente;
imparando i primi gesti d'amore, i figli imparano anche ad aprirsi agli
altri, cogliendo nel dono di sé il senso del vivere umano. La stessa vita
quotidiana di una famiglia autenticamente cristiana costituisce la prima
«esperienza di Chiesa», destinata a trovare conferma e sviluppo nel
graduale inserimento attivo e responsabile dei figli nella più ampia
comunità ecclesiale e nella società civile. Quanto più i coniugi e i
genitori cristiani cresceranno nella consapevolezza che la loro «Chiesa
domestica» è partecipe della vita e della missione della Chiesa
universale, tanto più i figli potranno essere formati al «senso della
Chiesa» e sentiranno tutta la bellezza di dedicare le loro energie al
servizio del Regno di Dio. Luoghi importanti di formazione sono anche le scuole e le
università cattoliche, come pure i centri di rinnovamento spirituale
che oggi vanno sempre più diffondendosi. Come hanno rilevato i Padri
sinodali, nell'attuale contesto sociale e storico, segnato da una profonda
svolta culturale, non basta più la partecipazione _ peraltro sempre
necessaria e insostituibile _ dei genitori cristiani alla vita della
scuola; occorre preparare fedeli laici che si dedichino all'opera
educativa come a una vera e propria missione ecclesiale; occorre
costituire e sviluppare delle «comunità educative», formate insieme da
genitori, docenti, sacerdoti, religiosi e religiose, rappresentanti di
giovani. E perché la scuola possa degnamente svolgere la sua funzione
formativa, i fedeli laici si devono sentire impegnati a esigere da tutti e
a promuovere per tutti una vera libertà di educazione, anche mediante
un'opportuna legislazione civile(220). I Padri sinodali hanno avuto parole di stima e d'incoraggiamento
verso tutti quei fedeli laici, uomini e donne, che con spirito civile e
cristiano svolgono un compito educativo nella scuola e negli istituti
formativi. Hanno inoltre rilevato l'urgente necessità che i fedeli laici
maestri e professori nelle diverse scuole, cattoliche o no, siano veri
testimoni del Vangelo, mediante l'esempio della vita, la competenza e la
rettitudine professionale, l'ispirazione cristiana dell'insegnamento,
salva sempre _ com'è evidente _ l'autonomia delle varie scienze e
discipline. E di singolare importanza che la ricerca scientifica e
tecnica svolta dai fedeli laici sia retta dal criterio del servizio
all'uomo nella totalità dei suoi valori e delle sue esigenze: a questi
fedeli laici la Chiesa affida il compito di rendere a tutti più
comprensibile l'intimo legame che esiste tra la fede e la scienza, tra il
Vangelo e la cultura umana(221). «Questo Sinodo _ leggiamo in una proposizione _ fa appello al
ruolo profetico delle scuole e delle università cattoliche e loda la
dedizione dei maestri e degli insegnanti, al presente in massima parte
laici, perché negli istituti di educazione cattolica possano formare
uomini e donne in cui si incarni il "comandamento nuovo". La
presenza contemporanea di sacerdoti e laici, e anche di religiosi e
religiose, offre agli alunni un'immagine viva della Chiesa e rende più
facile la conoscenza delle sue ricchezze (cf. Congregazione per
l'Educazione Cattolica, Il laico educatore, testimone della fede nella
scuola)»(222). Anche i gruppi, le associazioni e i movimenti hanno un loro
posto nella formazione dei fedeli laici: hanno, infatti, la possibilità,
ciascuno con i propri metodi, di offrire una formazione profondamente
inserita nella stessa esperienza di vita apostolica, come pure hanno
l'opportunità di integrare, concretizzare e specificare la formazione che
i loro aderenti ricevono da altre persone e comunità. La formazione reciprocamente ricevuta e donata da tutti 63. La formazione non è il privilegio di alcuni, bensì un
diritto e un dovere per tutti. I Padri sinodali al riguardo hanno detto:
«Sia offerta a tutti la possibilità della formazione, soprattutto ai
poveri, i quali possono essere essi stessi fonte di formazione per tutti»,
e hanno aggiunto: «Per la formazione si usino mezzi adatti che aiutino
ciascuno ad assecondare la piena vocazione umana e cristiana»(223). Ai fini d'una pastorale veramente incisiva ed efficace è da
svilupparsi, anche mettendo in atto opportuni corsi o scuole apposite, la
formazione dei formatori. Formare coloro che, a loro volta, dovranno
essere impegnati nella formazione dei fedeli laici costituisce un'esigenza
primaria per assicurare la formazione generale e capillare di tutti i
fedeli laici. Nell'opera formativa un'attenzione particolare dovrà essere
riservata alla cultura locale, secondo l'esplicito invito dei Padri del
Sinodo: «La formazione dei cristiani terrà nel massimo conto la cultura
umana del luogo, la quale contribuisce alla stessa formazione e aiuterà a
giudicare il valore sia insito nella cultura tradizionale, sia proposto in
quella moderna. Si dia la dovuta attenzione anche alle diverse culture che
possono coesistere in uno stesso popolo e in una stessa nazione. La
Chiesa, Madre e Maestra dei popoli, si sforzerà di salvare, dove ne sia
il caso, la cultura delle minoranze che vivono in grandi nazioni»(224). Nell'opera formativa alcune convinzioni si rivelano
particolarmente necessarie e feconde. La convinzione, anzitutto, che non
si dà formazione vera ed efficace se ciascuno non si assume e non
sviluppa da se stesso la responsabilità della formazione: questa,
infatti, si configura essenzialmente come «auto-formazione». La convinzione, inoltre, che ognuno di noi è il termine e insieme
il principio della formazione: più veniamo formati e più sentiamo
l'esigenza di proseguire e approfondire tale formazione, come pure più
veniamo formati e più ci rendiamo capaci di formare gli altri. Di singolare importanza è la coscienza che l'opera formativa,
mentre ricorre con intelligenza ai mezzi e ai metodi delle scienze umane,
è tanto più efficace quanto più è disponibile alla azione di Dio: solo
il tralcio che non teme di lasciarsi potare dal vignaiolo produce più
frutto per sé e per gli altri. Appello e preghiera 64. A conclusione di questo documento post-sinodale ripropongo
ancora una volta l'invito del «padrone di casa» di cui ci parla il
Vangelo: Andate anche voi nella mia vigna. Si può dire che il
significato del Sinodo sulla vocazione e missione dei laici stia proprio
in questo appello del Signore Gesù rivolto a tutti, e in
particolare ai fedeli laici, uomini e donne. I lavori sinodali hanno costituito per tutti i partecipanti una
grande esperienza spirituale: quella di una Chiesa attenta, nella luce e
nella forza dello Spirito, a discernere e ad accogliere il rinnovato
appello del suo Signore in ordine a riproporre al mondo d'oggi il mistero
della sua comunione e il dinamismo della sua missione di salvezza, in
particolare cogliendo il posto e il ruolo specifici dei fedeli laici. Il
frutto poi del Sinodo, che questa Esortazione intende sollecitare il più
abbondante possibile in tutte le Chiese sparse nel mondo, sarà dato
dall'effettiva accoglienza che l'appello del Signore riceverà da parte
dell'intero Popolo di Dio e, in esso, da parte dei fedeli laici. Per questo rivolgo a tutti e a ciascuno, Pastori e fedeli, la
vivissima esortazione a non stancarsi mai di mantenere vigile, anzi di
rendere sempre più radicata nella mente, nel cuore e nella vita la coscienza
ecclesiale, la coscienza cioè di essere membri della Chiesa di Gesù
Cristo, partecipi del suo mistero di comunione e della sua energia
apostolica e missionaria. E' di particolare importanza che tutti i cristiani siano
consapevoli di quella straordinaria dignità che è stata loro
donata mediante il santo Battesimo: per grazia siamo chiamati ad essere
figli amati dal Padre, membra incorporate a Gesù Cristo e alla sua
Chiesa, templi vivi e santi dello Spirito. Riascoltiamo, commossi e grati,
le parole di Giovanni Evangelista: «Quale grande amore ci ha dato il
Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!» (1 Gv
3, 1). Questa «novità cristiana» donata ai membri della Chiesa, mentre
costituisce per tutti la radice della loro partecipazione all'ufficio
sacerdotale, profetico e regale di Cristo e della loro vocazione alla
santità nell'amore, si esprime e si attua nei fedeli laici secondo «l'indole
secolare» loro «propria e peculiare». La coscienza ecclesiale comporta, unitamente al senso della comune
dignità cristiana, il senso di appartenere al mistero della
Chiesa-Comunione: è questo un aspetto fondamentale e decisivo per la
vita e per la missione della Chiesa. Per tutti e per ciascuno la preghiera
ardente di Gesù nell'ultima Cena: «Ut unum sint!» deve
diventare, ogni giorno, un esigente e irrinunciabile programma di vita e
di azione. Il senso vivo della comunione ecclesiale, dono dello Spirito che
sollecita la nostra libera risposta, avrà come suo prezioso frutto la
valorizzazione armonica nella Chiesa «una e cattolica» della ricca
varietà delle vocazioni e condizioni di vita, dei carismi, dei ministeri
e dei compiti e responsabilità, come pure una più convinta e decisa
collaborazione dei gruppi, delle associazioni e dei movimenti di fedeli
laici nel solidale compimento della comune missione salvifica della Chiesa
stessa. Questa comunione è già in se stessa il primo grande segno della
presenza di Cristo Salvatore nel mondo; nello stesso tempo essa favorisce
e stimola la diretta azione apostolica e missionaria della Chiesa. Alle soglie del terzo millennio, la Chiesa tutta, Pastori e
fedeli, deve sentire più forte la sua responsabilità di obbedire al
comando di Cristo: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a
ogni creatura» (Mc 16, 15), rinnovando il suo slancio
missionario. Una grande, impegnativa e magnifica impresa è affidata alla
Chiesa: quella di una nuova evangelizzazione, di cui il mondo
attuale ha immenso bisogno. I fedeli laici devono sentirsi parte viva e
responsabile di quest'impresa, chiamati come sono ad annunciare e a vivere
il Vangelo nel servizio ai valori e alle esigenze della persona e della
società. Il Sinodo dei Vescovi, celebratosi nel mese di ottobre durante
l'Anno Mariano, ha affidato i suoi lavori, in modo del tutto particolare,
alla intercessione di Maria Santissima, Madre del Redentore. Ed ora alla
stessa intercessione affido la fecondità spirituale dei frutti del
Sinodo. Alla Vergine mi rivolgo al termine di questo documento
post-sinodale, in unione con i Padri e i fedeli laici presenti al Sinodo e
con tutti gli altri membri del Popolo di Dio. L'appello si fa preghiera. O Vergine santissima, Con Te rendiamo grazie a Dio, Vergine del Magnificat, Tu che sei stata, Nel tuo cuore di madre Vergine coraggiosa, Tu che insieme agli Apostoli in preghiera Vergine Madre, Amen. Dato a Roma, presso San Pietro, il 30 dicembre, festa della Santa
Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, dell'anno 1988, undicesimo del mio
Pontificato. IOANNES PAULUS II |
|
HOME benvenuti | liturgia | bibbia | voci dal deserto | immagini & webcam | chiese locali | testi & documenti | pensieri
san francesco & santa chiara | massime eterne | papas pefkis | l'arcivescovo lambruschini | banner exch | links